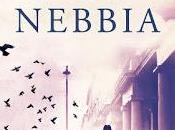A cura di:
Marco Appioli
“Stay Hungry, Stay Foolish”, recitava Steve Jobs nel celeberrimo discorso ai neolaureati della Stanford University di qualche anno fa. Guardare sempre un po’ più avanti, osare, sembra essere il motto di un festival che non vuole mai cullarsi sugli allori. Il 2011 doveva essere, a detta degli organizzatori, l’anno del gran cambiamento. Purtroppo in alcuni casi le cose non sono andate a meraviglia, e alcune falle organizzative hanno penalizzato un festival altrimenti perfetto. La nuova “sezione staccata” del Poble Espanyol ha visto una buona partecipazione solo per la festa finale della domenica con i Mercury Rev.
Le tanto osannate tessere magnetiche che avrebbero dovuto abolire le file nei bar non hanno funzionato per tutta la prima serata del giovedì causando code ancor maggiori e grandi proteste da parte di coloro che in esse avevano caricato del denaro diventato improvvisamente inutilizzabile.

Il nuovo palco Llevant era obbiettivamente troppo lontano da quelli principali. Infine la finale di Champions League ha svuotato per buona parte il festival nella tarda serata del sabato.
Ma le pecche organizzative non possono costituire certo il fallimento di una manifestazione della solidità del Primavera Sound. Altrimenti nominatemi un festival dove suonino 230 gruppi in 8 palchi, in un palcoscenico meraviglioso ed in una situazione climatica pressoché perfetta. Dove non si navighi dentro i bagni chimici, lo staff sia accogliente, e dove non suoni Vasco Rossi.
Giovedi 26 maggio
Il mio festival inizia con una band molto interessante, gli Islet. Gruppo sperimentale di derivazione afrobeat più orientati verso gli Animal Collective che verso i Vampire Weekend. Purtroppo pochi tappeti di tastiere, una ottima sezione di percussioni ma qualche pecca a livello vocale. Un gruppo che per ora si ascolta meglio su cd che dal vivo, ma di cui si sentirà probabilmente parlare fra qualche anno. Come i successivi Cults, band che contrario non rischia nulla ma ha un solido background costruito su tutta la produzione Motown e su una cantante di indubbio valore.

I Moon Duo colpiscono per l’impatto shoegaze, oscuro e psichedelico seppur nella semplicità delle linee melodiche dei pezzi. Sembra quasi, riscrivendo il passato, che i Joy Division siano stati assoldati per scrivere la colonna sonora di Easy Rider. I bizzarri Of Montreal improvvisano un circo pop progressive di grande impatto, coronato da improbabili pupazzi che fanno del palco un teatro di colori simile ad una istantanea del Mago di Oz, anticipando le meraviglie dei Flaming Lips che poche ore dopo calcano lo stesso palco. Ma questa volta animaletti, palloncini, proiezioni su una enorme mezzaluna di led colorati enfatizzano in un carosello psichedelico tutto l’estro e la follia della band del visionario Wayne Coyne.
Mi vengono in mente le suite dei Motorpsycho, alcune digressioni dei Mogway, gli Spacemen 3. Tutto frullato in un’esplosione di colori simile a quando da bambini si spremevano insieme le tempere in un foglio e poi lo si piegava in quattro. Una sauna psichedelica (anche data la temperatura) che prepara al concerto dei Walkmen, che vale tutta la passeggiata nel lontanissimo palco Llevant.
Una voce incredibile di stampo gregdulliano, strumenti vintage, un accattivante base di pianoforte. Il gruppo del giorno fa diventare il grande scenario un piccolo club, raccontando intime storie d’amore dall’America più “Dylaniana”, profonda e ombrosa. Un’eleganza compositiva che non ha tempo, di una band di cui chiunque dovrebbe innamorarsi. La nottata si conclude magnificamente conCaribou, ovvero Dan Snaith e le sue atmosfere musicali liquide e tropicali, che strizzano l’occhio alla dub downtempo di Kruder & Dorfmeister, ai Four Tet ma anche alle sperimentazioni elettroniche dei Soulwax.
Venerdi 27 maggio
I Male Bonding aprono le danze del venerdì mentre sul Palco Pitchfork cala il sole. L’impressione è quella di un gruppo compatto, che produce un sunto di grunge e punk rock mescolando i Nirvana di Incesticide con dinamiche e melodie degli Husker Du. Il peccato è che queste ottime influenze paiono sopraffare la band a discapito di una pressoché totale mancanza di personalità compositiva. Il pubblico giovanissimo si dimena e apprezza dei pezzi che a me appaiono banali all’inverosimile. Arriva il momento di The National, uno dei concerti che aspettavo con più entusiasmo. Il gruppo pare non esprimere a pieno le enormi doti mostrate negli album, ed in particolare nel recente, riuscitissimo “High Violet”. Con mio sommo disappunto, il sound si ripiega in se stesso, appiattendosi sulla voce baritonale di Matt Berninger e su atmosfere piacevoli ma non laceranti, struggenti, come ci si sarebbe potuto aspettare anche in virtù dei meravigliosi testi. Troppa monotonia, forse una scaletta non impeccabile, o la sezione ridotta di fiati fa di questo live un concerto riuscito a metà, ben suonato da una band da cui però ci si aspettava molta più empatia, “molti più brividi sulla schiena”, come direbbero gli americani. Arriva forse il momento più atteso dal pubblico del Forum: i Pulp, riformati, suonano il loro primo concerto dopo ben quattordici anni di assenza dai palchi.
E per due ore pare che l’orologio torni indietro al 1995, quando il manifesto di “Common People” rivoltò la mia vita e quella di qualche milione di ragazzini, in un certo senso condizionandola per molti, moltissimi anni. Jarvis continua a darti quella sensazione di familiarità, ha ancora quell’aria da dandy allampanato che dopo una giornata di lavoro prendi a braccetto e porti a giocare a freccette al pub sotto casa. Non sono venuto al Primavera Sound per vedere i Pulp, forse mi pareva un “falso storico” rivivere una parte della mia giovinezza, ed invece è stato bellissimo, sublime e lacerante, come solo le emozioni ingenue dei sedici anni possono essere. Un concerto epocale che rimarrà una delle esibizioni più belle e toccanti nella storia del festival, due ore di spettacolo che si stampa soprattutto sui visi, e sui ricordi, delle persone che hanno vissuto quegli anni ricalcando la via suggerita da Jarvis: “And then dance, and drink, and screw, because there’s nothing else to do”.
Arriva l’ora di scendere nell’anfiteatro dell’ ATP, dove gli Explosions in the Sky costruiscono un paesaggio sonoro trasognante, che si scioglie sugli arpeggi di “The Birth and Death of the Day”, cresce nelle chitarre abrasive e lancinanti della meravigliosa, dilatatissima “Postcard from 1952”, creando un ordito strumentale che raggiunge apici emotivi che trascendono dall’ormai inflazionato genere post rock. Un live liberatorio, catartico, che colpisce ed affascina il pubblico del Forum, preparandolo all’esibizione dei Battles.
Orfani del leader-cantante Tyonday Braxton, la band risolve nel modo più efficace il problema di come eseguire i brani dell’album precedente, il fortunato “Mirrored”: semplicemente non suonandolo. Rispetto al live a cui ho avuto la fortuna di assistere 4 anni prima nello stesso scenario, il gruppo di punta della Warp appare meno legato ad asettiche perfezioni Math Rock e più orientato verso un suono dub e da colonna sonora. Lo stesso percorso che gli inglesi Foals hanno coraggiosamente intrapreso nel loro secondo lavoro, per intenderci. Se il perno della sezione ritmica rimane il batterista John Stainer, le novità arrivano dal batti e ribatti di chitarre e tastiere, che incorniciano l’enorme cascata di loop minimali che rende i nuovi Battles semplicemente imparagonabili a quelli del precedente tour. Diversamente eccezionali, in ogni caso.

Sabato 28 maggio
Simpatico gruppo in apertura dell’ultimo giorno di festival: Tune – Yards, capitanati dall’eclettica Merryll Garbus, in un turbine di loop di voce, percussioni e ukulele, interpretano un pop personalissimo influenzato da ritmi tribaleschi, voci “nere” da soul corale e una certa dose di hipsteria che ammalia il pubblico del pomeriggio. Gli Yuck, composti da ex membri dei Cajun Dance Party, dimostrano dal vivo tutto il valore espresso nel recente disco d’esordio: non inventano nulla ma reinterpretano l’indie anni ’90 come pochissimi in questo momento. Assoli alla Dinosaur Jr, su strutture disarticolate tipiche del miglior Malkmus, melodie semplici e malinconiche, una strizzatina d’occhio anche ai Sonic Youth di Dirty.
Ai Fleet Foxes, con mio grande stupore, tocca suonare quando ancora il sole è alto. Ma non per questo le loro atmosfere suggestive, invernali e notturne, i loro dipinti dominati da arpeggi di chitarra e banjo, perdono in credibilità. Il grande merito di questa band è riuscire a trovare originalità in un suono retrò alla Cosby, Still, Nash & Young, permeandolo di cori bucolici che strizzano l’occhio a Panda Bear. Il suono è, se possibile, ancora più “grande” che da studio, e brani come “The Cascades”, “Battery Kinzie” e “Sim sala Bim”, col suo mandolino greve creano una splendida atmosfera. Privata, complessa, meditativa, mentre la luce, finalmente, lascia spazio all’oscurità.
La ricetta di Jon Spencer Blues Explosion invece è devastante: una miscela di punk, garage, blues filtrato da riverberi acidi e schizzati, un cantato carnale ed esoterico, che rimescola tra i classici degli esordi, “Wail”, “2Kindalove”, “Bellbottoms” e propone nuovi brani inediti senza mai fermarsi un istante. Il rock ‘n’ roll nelle sua essenza più ancestrale, lercia e deflagrante. Jon Spencer è semplicemente una bestia feroce, mai doma, e i due brutti ceffi che lo seguono da quindici anni interpretano al meglio le sue perle di adrenalinico rock n roll. Perché, come dice lui: “The Blues is number one, but we’re playing rock ‘n’ roll!”
Gli Holy Ghosts, gruppo di punta della DFA dopo l’addio alle scene degli LCD Soundsystem, propongono un set di grande impatto: cadenze dei Cut Copy su melodie alla Phoenix, tanto beat retrò, e una piacevole melodia electropop di sicuro successo. Un’ennesima scommessa vinta dall’etichetta di James Murphy. I cori ricordano le grandi hit anni ’70 e ’80, il delirio arriva su “Hold On” e “Say my Name”, il momento più toccante su “Jam for Jerry”, dedicata a Jerry Fuchs, batterista dei !!! deceduto a soli 34 anni in un tragico incidente.
Il gran finale arriva con gli Animal Collective, che tornano al Primavera Sound dopo tre anni conquistando questa volta il palco principale, l’Escenario San Miguel.
La gran fortuna è quella di potere assistere ad un concerto memorabile, perché la band non è vincolata dal dover presentare necessariamente i brani dell’ultimo lavoro, datato ormai 2009. Il tour promozionale del fortunato “Merryweather Post Pavilion” è ormai finito da tempo, e il collettivo può “jammare” sui propri brani, mescolandoli e proponendo un’infinità di nuove creature che faranno (presumibilmente) parte del prossimo album. Il concerto si snoda in un crescendo di sperimentazioni afrobeat: ben otto brani su un totale di dodici sono inediti. In pratica si assiste ad una premiere, le cui uniche concessioni al passato sono le celebri “Did You See the Words” in apertura e “Brothersport” contenuta all’interno di una suite di tastiere e percussioni di circa dieci minuti. E poi l’immancabile finale con “Summertime Clothes”. I ragazzi di Baltimora cercano in ogni modo di darsi da fare per non dare nessun punto di riferimento nel loro live: in certi frangenti, con tutta la buona volontà possibile, non si capisce chi suoni cosa. Una cosa è certa: non esiste una band, al momento, che suoni con questa libertà di intenti, pretendendo di distruggere la forma-canzone, rifuggendo da ogni tipo di vincolo e di caratterizzazione. Rifuggendo persino dalla propria musica. Il gruppo più lontano dall’assioma “Less is more” che io abbia mai sentito. Se c’è qualcosa di diametralmente opposto al minimalismo musicale, questi sono gli Animal Collective. Nessun leader, membri della band non esattamente fissi, dietro i quali si celano progetti paralleli, colonne sonore, e chissà cos’altro.
Il concerto perfetto, edificante e coerente sarebbe stata la sintesi orchestrata degli ultimi due meravigliosi lavori. Macchè, troppo facile. Gli Animal Collective sfidano il pubblico a spingersi oltre, a non chiedere il pezzone che tutti possano cantare quasi finalmente liberati, a pretendere di più da una musica che non vuole avere confini, ruoli, etichette. Quello che sono stati i Kraftwerk per la musica elettronica, oggi sono loro. A volte incompresi, a volte iper-esaltati, un gruppo ed un live che non lasciano certo indifferenti, e che hanno cambiato un festival che, come loro, ha voglia di mettersi in gioco a costo di sembrare impopolari. Il gruppo più affamato e pazzo, “hungry and foolish” che abbia mai calcato questo festival. Steve Jobs ne andrebbe fiero