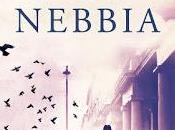Ci sono persone e isole che nella vita svettano come alti lampioni sul lungomare ideale che percorri, mentre tu col muso arrossi alle frustate degli eventi o sbollisci in un sorriso, sollevi l’espressione e trovi una luce che spinge in porto sicuro tutti i diobuono, i semmai, gli “altroquando” dei nervi che solleticano gli istinti dispersi, un po’ efferati, di tutti.
Procida è stata il nostro porto elettivo in anni che sono già molto passati senza troppi ragionamenti, senza nemmeno avvertire, del resto, che durante questo lavorio di lancette il mondo dei fatti sociali che ci ordina s’è spinto ancora più giù, in qualche caletta isolata, costosa ed esclusiva, un mare che raggiungere ancora costa fatica, e non è più una vibrazione di piacere quella che sposta i remi sulla barca, si galleggia d’istinto come si riesce, fidando nella cecità fortunata delle correnti.
Era Vera a Procida quel nostro alto lampione solitario, il nostro abuso collettivo di feticci e slogan fuori moda in un tempo che cominciava a trasmutare tutto: Hedge Fund e Che Guevara, Derivati e trattini, sex in-ex-stream, colture e fabbriche smantellate, Underground questo e quello, avvocati come nuovi cecchini negli snodi del possibile, La Mafia oggi ci vai a mangiare ridendo, è underground di genere, è diventata una catena di ristoranti alla moda in Spagna e tu Cotugno che l’hai inventata non ti giovi nemmeno del Brand, però ospiti intellettuali sbolliti che gli viene buono citare Marx come vecchio da rileggere, forse qualcosa d’umano aveva intuito davvero, almeno quel tipo di salotto che si smonta in fretta come fosse un’Ikea al contrario, gli amici acculturati spingono avanti il carrello e il giro si perde nelle more dei serial casalinghi.
Veruska, detta Vera, ci raccoglieva al porto di Procida. La sua salda statura svettava, invariabilmente ondeggiante, per raccogliere prima l’occhiata di complicità degli amici sulla piccola folla che si radunava in accoglienza al molo dei traghetti. Vera era puro Underground, vissuto senza sconti.
Scendevamo io, tu, gli altri, quelli che non conoscevi e che non avresti immaginato, dalla sua tana nell’isola Vera aveva lanciato la solita generosa ventina di inviti, estendibili a chiunque altro, erano questi gli ordini di campo per la Pasqua apocrifa che avremmo rappresentato tutti a Procida, la più introversa delle tre sorelle, nel golfo chiassoso di Napoli.
Le dorsali viarie dell’isola, esterna sinistra Corricella, centrale paese, esterna destra per spiaggia Castello, in una geografia semplice come la schiena di un asino, riuscivano ad attraversare il corpo isolano tenendosi in un’atmosfera intima come di anni italiani precedenti il boom nonostante le macchine ti sfiorassero alla solita maniera schizoide di oggi.
Soltanto a Pasquetta rituale partenopeo chiedeva che la crema più scura dei popoli vesuviani si rovesciasse al porto e invadesse come un’armata stracciona ogni spazio libero delle poche spiagge e dell’interno profumato dai limoni, scalciando urla in accenti slabbrati e palloni addosso alle signore scure sedute nelle icone delle porte su strada, e tutto il caos pan-dionisiaco che ingravida da sempre il golfo.
Vera ci spiegava la particolare salvezza procidana col fatto che l’isola godesse naturalmente del controllo capillare camorrista, seconde ville e motoscafi veloci avevano garantito una certa distanza dallo sviluppo selvaggio delle cose umane.
Poi, se eri sceso dal traghetto attracollato di eccessivi pesi, Vera insisteva per evitare il tuk-tuk-taxi e farsela a piedi per quei tre quarti d’ora che prima salivano nel panorama aperto, poi pianeggiavano in una serie di curve tra mura strette che celavano le limonaie esposte, con l’eccezione del cancelletto, un anno aperto e l’altro chiuso per il pericolo di frane, che si apriva nella luce del giardino panoramico dell’isola di Arturo, dove Morante e Moravia usavano scambiarsi gli amori e le lettere.
Si seguiva Vera trotterellando un passetto dietro, l’ampia falcata del suo metro e ottanta di mezza slava e i racconti delle cose del mondo sociale e politico con cui accorciava le distanze spingevano a una forma di umiltà vagamente contegnosa. Il piccolo nodo si scioglieva col soccorso dell’isola che tornava a scollinare, sul pianoro dove si aprivano le discese a mare sul lato di Vivara. Si era giunti al cuore dell’ospitalità, il gruppo faceva circolo e Vera assegnava gli alloggiamenti possibili, i più alternativi che avrebbero dormito anche in terra negli stretti quaranta metri di casa, gli altri parcheggiati lietamente a pensione Savoia, una vecchia struttura fatiscente di carattere fascio-umbertino, dotata di un giardino di limoni vasto e bellissimo e percorsa dal fascino delle cose che resistono tignosamente, andando in malora.
Si riusciva a stare felici negli ultimi fremiti degli infissi schiodati, sussurranti, nelle more dei rubinetti gocciolanti, delle infiltrazioni di umidità e rumori, delle scale sbilenche. L’albergazione vintage di Anastasia e delle altre due sorelle ottuagenarie che gestivano l’esercizio da una vita, era ancora uno dei motivi antropologici segreti, fondanti dell’isola, insieme all’umanità ruvida che odorava d’antico, alla testa matta di Girone che ti sbraitava addosso il menù della trattoria sul mare oppure semplicemente si girava e se ne andava per i cazzi suoi, e se volevi ordinare qualcosa dovevi inseguirlo e blandirlo, certe volte non v’era certezza alcuna.
A Pensione Savoia, piuttosto, potevi esserti intascato tre limoni di straforo di notte, nel giardino, tra quelli caduti in terra, ma non c’era verso. La mattina che andavi a saldare il conto, dio solo sa come Anastasia facesse, è probabile che condividesse ormai il sistema nervoso delle tubature marcite, dei labirinti di spifferi, fino all’estensione delle radici nella terra; lei intonava comunque sempre, dal retro nebbioso di due vecchi fondi di bottiglia, lo stesso canto: “E voi(tu), avete preso pure tre limoni, è ovéro?”
Era overo si, si confessava senza vergogna e si tornava sempre a Savoia, comunque, consapevoli che il miracolo delle sorelle ottuagenarie avesse il maledetto tempo contato di quei rosari indigeribili della modernità, che si sarebbero invariabilmente presi la Pensione, a breve.
Vera attendeva tutti a ogni ora dalla sommità di palazzo Guerracino, quel bellissimo edificio rosso antico che sovrasta il panorama di Solchiaro, aspettava sulla terrazza a giro di cui da qualche anno aveva affittato il piccolo superattico, nella nobiltà trasfusa sugli oggetti del mondo alternativo che eravamo noi tutti ancora, pur molto vicini ai quaranta ambigui anni di una vita. Può dirti il peggio quest’ala sconsiderata dell’esistenza, non sei più giovane e nemmeno pienamente adulto, hai ancora slanci eroici ma qualcosa di sottile nella fermezza delle gambe comincia a farti tremare, alcuni si chiudono e diventano il paguro di se stessi.
Vera rappresentava il nostro comunismo intimo, disperso e raccolto a rituale animista, in anni in cui già si faticava a credersi collegati ad altro di politico che non fosse uno sbaglio di gioventù. Lei incrollabile, come una madre generosa con le guance scavate dall’utopia, abitava una porzione celeste del palazzo che fu residenza di riposo dei regnanti napoletani, un paio di secoli dietro, una porzione alta da cui vedevi il mare ovunque girassi lo sguardo incredulo.
Entravi dentro casa e ti coglieva un brivido, un abbaglio, stavi lì con la borsa in mano senza sapere bene dove poggiarti, facevi conto di metterti a leggere tutta la rincorsa di scritte a vernice o pennarello che saliva sui muri, le leggevi una per una ed erano tante, erano fuori posto, fuori anima, fuori ogni considerazione che avessi mai potuto avere dell’amore, nella forma più nuda e sconveniente che si potesse concepire.
ABEL VIVE, i caratteri più grossi.
E poi una fuga di frasi in font manuali e colori diversi a trafiggere l’intonaco bianco e fin nei soffitti, si traversavano come scambi ferroviari punti e virgole e binari di senso che invitavano a oltrepassare la soglia della camera da letto; c’era logos solidificato fino accanto alla finestra di Solchiaro, dove il sole tuffava le sue grazie nei vapori dell’orizzonte nudo a mare.
Erano Violeta Parra, Mercedes Sosa, Amparo Ochoa, erano poesie e illuminazioni sulla morte che spurgavano dal tratto più ingenuo e occulto di Vera, era Abel che viveva fuori da ogni grazia e comandava a bacchetta le truppe semantiche dell’impossibile requiem, così come aveva comandato le missioni Ong argentine nei territori desolati del Chaco. Il fantasma di un medico di Buenos Aires con cui Vera aveva condiviso un tratto portante di destino e l’unico vero amore possibile che può capitarti in una vita, quella congiunzione che passa una volta soltanto, che non ti farà mai a pezzi con le dinamiche o la stanchezza, con il conto del privato e il disinteresse per gli ideali.

Vera sapeva come trattarsi con ironia, le sue esagerazioni invitavano alla partecipazione rispettosa più che al velato obiettare di un silenzio, un po’ come capitava per il tradizionale mare ai faraglioni di Chiaiolella; i cartelli erano chiari, c’era scritto: Vietato Attraversare, pericolo di frane. Eppure è lì che si andava tutti a sdraiarci sull’onda del suggerimento di Vera, salendoci addosso con i discorsi e le clownerie, con le freccette di sabbia e sassolini che ci piovevano addosso ogni tanto dal costone alto.
Vera era riuscita a tirarsi fuori da un anno in cui era davvero naufragata a Procida. Come un vapore spezzato dalle tempeste, aveva chiuso la propria carcassa pericolante nel rimessaggio del tetto di palazzo Guerracino e ci aveva versato ettolitri di alcol dentro, pronta a lanciarci il proprio zippo ardente sopra.
Un giorno poi, come le pure forze della natura, aveva sfebbrato improvvisamente la stagione ed era tornata a produrre vento e luce. Vera è l’unica persona che abbia mai conosciuto per cui la generosità, il fare gruppo e distribuirsi, moltiplicarsi, connettere e condividere fossero tavole di una legge interna perfettamente congruente. Così il mondo aveva ricominciato a vorticargli intorno, si tornava dai misteri procidani come persone migliori, con un quanto di vita spremuta in più, con numeri di telefono su foglietti nei taschini o già sottobraccio a qualche forma di cuore tiepido, in arcana mutazione di stato.
Di un giorno che successe la tragedia, ancora forse qualcuno ne sorride.
Di un alba che seguiva una corta notte di veglie febbrili, di quei quindici sparsi che eravamo, delle poesie cantate in circolo semi-sdraiati sotto le stelle di Solchiaro, di Silvia con la chitarra da Napoli e la voce di un angelo senza titolo; inventava le parole lei, traslitterava semplicemente ciò che ascoltava senza sapere le lingue, il suono delle frasi dei tanghi argentini e dei fado portoghesi, ne estraeva idiomi inventati che poi trascriveva per comodità, fedeli alla quasi perfezione fonetica.
C’erano poi due suonatori uruguagi, ragazzi che Vera aveva arruolato qualche giorno prima incrociando una performance di strada in una stazione del Metrò. Gli altri intorno, stonavano e cercavano di stare al passo, sommersi dalla carezza delle copertine stese contro l’umidità della notte, nel calore di una semi-presenza a corredo che smuoveva le mani cieche di tutti verso qualcun altro, con il desiderio tiepido liberato verso un corpo differente, o anche solo verso l’idea di un qualche domani plausibilmente destinato.
Sparimmo tutti, poi, per un paio d’ore di duro sonno appena. Alla colazione delle sette affluimmo sparsi come randagi assottigliati, portati dagli odori del vento, ognuno pestato da differenti quadri onirici di coscienza.
Vera che sbraitava nel suo accento secco, sarcastico, mentre non smetteva un attimo di correre in giro a raccattare immondizie e distribuire tazze fumanti e biscotti rimasti non se l’aspettava nessuno, comunque.
In quelle due ore era andato via tutto, il corpo-voce di Silvia e la chitarra erogena di Esteban, Vera se n’era accorta per forza, per via che lei e l’uruguagio di strada era già una settimana che vivevano nel tetto del Guerracino, e la danza delicata che avevano condotto aspettandoci non poteva ammettere alcun tradimento dell’amicizia né della solidarietà, in un caso e nell’altro. Questa la ragione verticale, Vera.
Il motivo per cui molto di questo fu sciolto, come fosse solo una rapida esibizione di passi sporchi, fu che Vera lo considerò come un giro maldido di tango, una cosa che nella vita può sempre capitare. Nessuna vecchia carcassa ammarata che si rinnovi può sostenere una deviazione del genere per più di un tanto.
Per l’ennesima volta fummo grati a Vera, allo strano modo in cui ci riconoscevamo tutti, al suo disperdersi in un’idea di comunismo che non è mai morta, un sogno che ha continuato a vivere oltre le latrine politiche nell’anima di pochi intimi.
E tu te lo ritrovi vicino e in tasca e sulla guancia, persino, un giorno che eri Esteban, un uruguagio con un po’ di arte e molta poca parte in un paese estero, non avevi niente con cui pagare i servizi del mondo e sei stato raccolto, ospitato, nutrito di cibo e di storie, e ti si è dato anche il bastante per prendere un traghetto e un treno lungo per dove dicevi che ti sarebbe piaciuto andare a provare, dopo.
Scendiamo ancora le strade di Procida, incrociamo i molti caratteri ruvidi, introversi, dell’isola, schiviamo abbassandoci e sparpagliandoci le pallonate dei selvaggi rituali della pasquetta che ciacolano le neo-lingue del golfo.
Silvia viene giù trasognata e lenta, poco discosta da noi, quattro giorni pieni sull’isola senza cambiarsi, e solo la custodia della chitarra a farle compagnia in spalla.
Da qualche parte nell’isola grandi altoparlanti diffondono la festa, le canzoni neomelodiche, i presentatori proiettati nell’etere profumato vicino al tuo orecchio prigioniero. Nella distanza sentiamo invitare sul palco un bambino che vuole raccontare una barzelletta in tema alla festività che stiamo attraversando, scendendo verso il molo dei traghetti.
Con voce acuta, che fa a fette un paio di chilometri di barriere ambientali, il bambino racconta che c’è un Gesù sulla croce e queste tre suore gentili che vanno a portargli unguenti e conforto, e della prima che pietosamente leva il chiodo da una mano, della seconda misericordiosa che libera i piedi, del Signore che, guardandosi un po’ preoccupato, alla fine sbotta: “Oh, mò tu guarda se tre mignotte non me fanno cascà per terra!..”
Un grande gelo profondo avviluppa l’isola per l’eternità di un paio di secondi. Poi il presentatore rimette in moto il set che Procida è diventata tirando fuori non so che supercazzola dal cilindro, e noi veniamo sommersi da un nuovo neomelodico sparato a palla. Così ciò che ne possiamo ridere noi, abbandonati sulle gambe, e Silvia nella somma del proprio conto, che sbotta più forte di ognuno, nemmeno si sente alla fine.
Ora, così distante e spossessata di noi, l’isola di Procida appare nella tranquilla indifferenza che la abita realmente, nei vecchi abusi consolidati e nelle nuove incurie moderne; accade nelle strade, nelle mura, nell’aria e nei modi di tanta gente locale, nelle radici un po’ insensibili che affondano in terra e sono anche un po’ truci.
L’ultima volta che sono sbarcato a Procida, Vera non c’era più. Andammo comunque ad occupare una stanzetta malmessa che dava sulla bella terrazza panoramica di Pensione Savoia, ma fu tutta un’altra storia, oppure semplice il tempo trascorso. Anastasia ci comunicò, forse, la dipartita di una delle sorelle della storica trimurti ottuagenaria reggente, e disse poi che accidenti le malore, e non ci si faceva più ad andare avanti così, si stava per chiudere e buonanotte ai suonatori. Col tempo avrebbero riaperto altri, con i soldi per sistemare tutta la preziosa crosta di fatiscenza che avvinceva il luogo. Hotel Savoia, oggi, si prenota su internet, e anche palazzo Guerracino è stato rifatto a lustro.
Al teatro naturale della Corricella, invece, Vera ci portò sempre con moderazione. Si diceva che l’immagine più bella dell’isola, quella che gli americani e la Findus amano senza saper nemmeno che appartiene a Procida, quella specie di muraglione di presepe bianco senza tempo che rappresenta a nostra insaputa l’Italia nel mondo, non fosse altro che poesia accademica, solo il riflesso di una noiosa caverna platonica, e noi avevamo voglia di vivere con Vera.

di Alessandro Gabriele