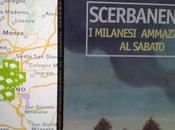immagine Federico Federici
su L’anima tema di Federico Federici
Se un catalogo servisse a mostrare ciò che l’anima debba temere, racconterebbe forse la storia della degenerazione di una stella. Nella relatività generale un buco nero è una singolarità nello spazio-tempo, causata dal collasso gravitazionale di una stella di una certa massa, che non lascia sfuggire più nulla al proprio orizzonte degli eventi. Si può azzardare allora che un buco nero, sia una stella, un’entità celeste visibile, che per via di un dato evento, prosciuga il suo corpo, iniziandosi alla sua scomparsa. Ciò sembra accadere ad alcune stelle di grande superficie, che a un dato punto della loro esistenza, come ubbidendo a un’intima galvanizzazione, si contraggono, per via dell’attrazione che ogni loro singola particella attua verso le altre se stesse, che insieme fanno l’astro. Questo moto pare generare nell’atmosfera intorno alla stella, un particolare trattenimento, che influisce sulle azioni e sul tempo, creando un orizzonte isolato e indipendente che lascia l’astro vivere solo della sua progressiva scomparsa all’occhio che la osserva. L’anima tema di Federico Federici (L’opera racchiusa, Lampi di stampa, Milano, 2009) inizia il libro similmente a questo fenomeno, come se tutto si fosse già esaurito secondo una sua propria maturazione, in un punto di osservazione in cui l’accaduto, più che essere dipanato, sia stato concentrato in una contrazione in cui luce e spazio, esistono inscindibili dal tempo. E creano una sorta di ambiente assoluto, un inizio fine a se stesso, un trattenimento inàne delle coordinate di un luogo. Il luogo è una casa, una “casa vuota” con un “lume dentro il vetro” (pag.14) che forse accenna una presenza, forse definisce un’assenza o concentra soltanto l’attenzione, in un’aura di estremo contatto. È questa la condizione della casa del poeta. Una condizione sempre esistente, nella misura in cui viene nominata ma che se non detta, mimetizza le presenze immateriali e la possibilità di contatti ulteriori, in un vuoto che rende altrimenti quel luogo disabitato. Ma ora, qui finalmente, “l’angelo ammirato attentamente nel dipinto” (pag.15) può suggellare la stanza al suo centro liquido, come iniziandola a un varco. È l’incipit. Il risveglio e lo stabilirsi di una veglia puramente auditiva che finalmente rende al luogo il cuore della sua geometria. Da questo orizzonte, gli eventi mutano in una zona visibile solo poeticamente, perché la resa di una simile densità accade solo in poesia. Quando il corpo poetico inizia la caduta nella fisica della sua anima. E quando ciò accade in modo perfettamente conscio, avviene un’assunzione di presenza in un tempo inesausto “un tempo andato altrove” (pag.17) che olia l’ingranaggio dell’ora stante, e dice di una impossibile fede “che dura un attimo” “sopra il male” (pag.17); un male che anche minimamente cruento, strazia di pena e uccide ogni credo, e ciò giusto in quel protrarsi dell’attimo all’infinito, che è il verso che lo dice. È a questo punto di sintesi estrema, come a dimostrarsi fattivamente e attraverso se stessa, che la poesia si erge a quell’infinità sospesa e immediata avvalendosi di un tempo che non ravvisa etica. Un tempo che si colloca spontaneamente al colmo del suo stesso movimento “sempre l’apice lo stremo del crepuscolo/ci approssima la notte:” (pag.18) e di qui accosta la speciale captazione che chiamiamo ascolto. Quando, questo, non sia smarrito nella diramazione del giorno, che schiude sempre parti, a generare e degenerare notti per pura necessità, solo perché luce e buio sono “uniti senza origine nel moto” (pag.18). Allora “l’aria ferma” (pag.19) che Federici nomina, sembra essere un’impressione legata al climax di tutta l’opera, ciò che consente di esperire il vuoto, attraversato fissamente dai corpi che propagano oltre la propria forma un afflato indecifrabile che sta a misurare gli interstizi, i silenzi, come fossero il messaggio più pregnante che si possa tra creature. Ma certo questo paesaggio asciugato dal superfluo delle azioni, non poteva essere ricreato in assenza di parola. È la parola che introduce a un altro grado la visione di quel “mondo,” che “ne matura il senso” (pag.20) cui tutto e tutti sembrano partecipi. Parola che ogni cosa detiene indistintamente come una rimembranza o una dimenticanza che sembri adattare o disattendere quanto del mondo stesso appaia: “non così che si conserva/l’apparenza delle cose” (pag.21). Apparenza che vive dell’esatta tempistica della sua dispersione e che perciò, al di là del suo aspetto effimero, può rimanere, in un verso, come rivela Federici: “tiepida nel palmo/pura quando fu toccata”(pag.21). Ma quanto l’anima abbia ragione di temere, riguardo questa scomparsa, che sembra paradossalmente l’unico movente veramente assertivo della sua presenza al visibile, lo dice, la caduta di ogni gesto, nel trattenimento fatale di un orizzonte che si incunea sempre di più “nel vivo della storia” (pag.22), un trattenimento fino alla percezione che concentra ogni idioma in un unica lingua in cui, dei vivi e dei morti “restano confusi i nomi” poiché sia“mai nessuno perso nel conto della grazia” (pag.24). E ciò consenta comunque, in questo passaggio inaudito, a coloro che il poeta chiama, fratelli e sorelle, e che “restano in colmo all’invisibile” (pag.25), di affacciarlo, come a guardare il come questo avvenga, come la poesia ripieghi nella “luminosa piaga” che scava il fuoco, coniando parole in cui l’origine cominci in luce, nominata (pag.26), e in ogni istante renda a ognuno rintracciabile “nei cuori l’atto di presenza” (pag.28). Una presenza dei cuori alle cose, la cui impossibilità, è forse davvero l’unica cosa che l’anima abbia da temere.
L’anima tema. Federico Federici
si cala in silenzio, luce da cielo – sta scritto
e ci si posa per assomigliare l’uno all’altro
al termine di tutto in niente – si è scoperto
e sono più che i tentativi queste offerte
alle madonne cave e di sangue
sangue rifinire l’anima di dentro a fuori
perché di foglia e ramo e di non altro è la ragione
da terra a cielo la perfezione è nell’attesa
*
nella luce appena ferma il tuo volto
forse per ammonimento mi cancella
il nome sulle labbra, forse qui d’un tratto
muto sempre rinascente è di traverso
il lume dentro il vetro in una casa vuota
visto alla finestra acceso come un segno
*
qualcuno, che prima è venuto, è andato via lasciando
presto il suo sigillo d’acqua al centro della stanza
l’angelo ammirato attentamente nel dipinto ha
labbra chiuse, sciamano in un coro poche voci
care, i gridi si confondono, le rondini
*
per aver soltanto vòlto il viso al tuo passaggio
hai finito lì da dietro di guardarmi, dove non vedevo
a onor del vero: non sono forse belli i tuoi occhi? o
come non sapessi già il colore dei capelli, l’opera
dolce delle labbra, il fiato, il dono della voce, chiusi
dietro al dito che indicava la più breve via in silenzio
*
credevo di ascoltare un tempo andato altrove
ritornare qui nel suono di campane giudizioso
l’ora della messa fioriscono a battiti di ciglia
e qualche lacrima schiarita in resa al cuore
dura un attimo la fede sopra il male, la pena
tenera trapassa senza sangue qui parte a parte
*
sempre l’apice lo stremo del crepuscolo
ci approssima la notte: fu ascolto chiaro
d’acqua tra le pietre trattenuta appena
tutta tramandata in fiume al mare
senza più lacune, gorghi, sottovoce rotta
alla sorgente, né cominciamenti d’altro
vivi intorno ai bassi segni del fogliame
uniti senza origine nel moto; noi
vi entrammo già due volte per bagnarci
*
l’aria ferma mi dà pace quanto basta alla figura
che ritorna a farsi viva nell’immagine intravista,
solo ricongiungimento al caldo della luce, poi caduti
il corpo, la sostanza delle cose, l’incolmabile divario
che ti ha resa un’altra lì da me; non tra noi
ricade l’ombra dove entrando il fuoco più si vuota
la materia prende a sé in un ago azzurro luce propria
*
si declina, da una parte brucia
nei colori e i nomi, intorbida
le cose, stacca i segni ai muri,
le lettere alle parole, tiene a sé
in un guizzo chiusa la materia,
il mondo, ne matura il senso
e tutti e tutto indifferentemente
chiama al ricongiungimento
s’offre in sé la fiamma
è la smemoratezza nostra
*
se pure non così che si conserva
l’apparenza delle cose va da sé
dura bene viva nei riflessi d’aria
quieta in ogni cosa persa a tempo
non raggiunta a voce o presa
in luce chiara, tiepida nel palmo
pura quando fu toccata
*
credi, poi che di tutti i nostri gesti
cade l’ombra addosso ai muri
vi penetra una parte, s’apre il varco
tra briciole di pietra intorno all’architrave
dura poco poi nel vivo della storia
altri giorni prima, per diversi pesi,
si equilibra indietro il tempo, il piatto
uguale trattenuto a mano, basso;
hanno un solo suono i passi
dalle spalle indietro e poi
*
le pietre, il muro, i resti
di pane sui lenzuoli, i letti
umidi sfatti, i visi pianti
«non siate tristi oggi se parto»
nella parte viva della casa
l’ombra sgrava il buio
contro la parete scura
bocca nuda di febbraio
*
levàti agli altari al vento, agitati alti in bocca
a chi prega i vivi, i morti nella stessa lingua
restano confusi i nomi, li ingoia la cadenza
esatta, mai nessuno perso nel conto della grazia
*
i pochi, fratelli e sorelle, che sono amori e amici
in colmo all’invisibile restano del mondo voci
e d’altri appena gli occhi; accolti in una turba scura
defilano in preda all’aria, scossi come si riscuote
l’albero nei rami alti lungo i muri, lasciano cadere
polline e capelli, la segatura tarme ai buchi
chino il capo sui tormenti di una piaga fitta
sulla pelle in luce li tortura l’ombra, respirano
accostati ai vetri come reliquie i santi
*
perché parlare ai numi? – ai padri i figli e i nuovi nati ai figli –
uomini occupati meglio in ciò che li tormenta;
prima incerta, poi fu chiara la parola – la memoria corta
sembra in qualche differente assenza andare al tempo
indietro, all’inizio del declino, colta in luminosa piaga
dentro il fuoco: qui l’origine comincia in luce, nominata
*
non veduto quasi è il tratto della grazia
qui dettato di stupore accanto al volto
e a te da me non giunge il senso della voce
solo canto chiaro nella gola in alto, a cielo,
muto nel pensiero o luminosa vena in viso
male s’apre al fondo del respiro
*
le mani agli altari – quelli delle figlie in sposa –
fiori di prodigio lungo illuminati corridoi dei giorni
e bianchi nodi seni bianchi senza vento spighe
da un agosto fatto di silenzio senza età
sta nei cuori l’atto di presenza, il battito nel petto
*
correre narrando a chi s’incontra di sfuggita
l’assorta compagnia dell’anima, il sentore dei giardini
dietro la finestra, la sempre viva luce senza fuoco,
la felicità promessa, data finalmente salva e senza causa
di dolore all’occhio che non serve più a vederla
e pure dico: questa è l’inaudita voce così come fu detta
*
lascia che a dire siano le cose
gli abitatori del mondo addossati alla cruna
dell’ago, le lingue impresse a memoria
l’elencazione dei nomi dei morti toglie il respiro
tempo è di dare le mani nell’andirivieni dei vivi
fermare gli occhi, lo sguardo a chi trema