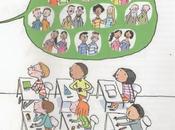10
Dove, poi che rimase la donzella
ch’esser dovea del vincitor mercede,
inanzi al caso era salita in sella,
e quando bisognò le spalle diede,
presaga che quel giorno esser rubella
dovea Fortuna alla cristiana fede:
entrò in un bosco, e ne la stretta via
rincontrò un cavallier ch’a piè venìa.
Chi è Angelica? Una dolce pulzella tutta lacrime e spasmi d’amore, come vorrebbero le tradizioni cantate dai bardi medievali? Eh beh, questo proprio no. Credo che se ne siano resi conto tutti: sia chi ne ha nozione personale, che chiunque si sta avvicinando alla materia a causa mia.
Angelica è, se vogliamo, il prototipo di una nuova femminilità, emancipata ed evoluta. È stata mandata in occidente, dal Catai (di cui era principessa, in quanto figlia di Galafrone), per poter ovviare agli eventuali insuccessi di Argalia. O mio dio, quanti nomi… Aiuto!!!
Argalia, fratello fortissimo di Angelica, è munito d’una magica ed invulnerabile armatura, oltre che da una altrettanto magica lancia d’oro capace di disarcionare chiunque anche solo sfiorandolo. Entrambi erano stati inviati in Francia, ben prima che scoppiasse il casus belli di cui si è detto e che condusse sino allo scontro sui Pirenei. Scopo della loro venuta era cercare di arruolare cavalieri per la difesa del Regno di Galafrone, loro padre.
Angelica propone un duello: chiunque fosse riuscito a sconfiggere Argalia (il quale fingeva d’essere altri, precisamente un tal Uberto Dal Leone), l’avrebbe sposata. In caso contrario – chi perdeva – avrebbe seguito i due (Angelica e Argalia) sino in Catai, per combattere Agricane signore dei Tartari. Si fa complicata la storia? Ma no, state tranquilli, non vado oltre e poi non c’è bisogno, poiché queste son storie dell’Orlando Innamorato. Se ho accennato ai fatti è solo per farvi notare che tipo di ragazza era Angelica. Capirete che un duello come quello che lei propone, non è leale, vista la lancia e l’armatura fatata di Argalia. Eppure – comu fu e comu nun fu – quest’ultimo è accidentalmente ucciso da Ferraù – personaggio che conosceremo a breve – e a questo punto sarà Angelica a concludere la missione, sia per mezzo di un anello che la rendeva immune da qualsiasi magia che le si opponeva, ma soprattutto per mezzo della sua bellezza.
Insomma, come dicevo nella puntata precedente, Angelica ammalia tutti i paladini franceschi, come anco i cavalieri mori, e se li porta in Cataio a combattere.
Ora riprendiamo da dove avevamo lasciato il Furioso: Orlando e Angelica sono tornati in Francia; c’è una battaglia tra i mori ed i cristiani di Re Carlo. Angelica, nel trambusto della battaglia, dalla tenda del duca di Baviera, riesce a scorgere i motivi di una ormai prossima sconfitta cristiana. La Fortuna, con la F maiuscola, sarà ribelle alla vera fede cristiana. La Provvidenza si ribella? Che fare? Servirebbe un prontuario! Commuoversi comunque non serve, no di certo, lo abbiamo detto prima. E quindi Angelica non sviene, come accade spesso ai personaggi letterari da né carne, né pesce, per dirla ancora una volta con gli Elii. Lei sa bene quello che vuole dalla vita:
«Ma tu talìa ‘stu ‘mbranatu ri Orlando unni mi purtau!?! E st’autri sciminuti re francisi??? E vuoi virri ca ora venunu chiddi ri Marsilio, ca nunn’hannu vistu na fimmina saiddu ri quantu tiempu, e c’agghia dari urienzia ju??? Ma neanche se ne parla. Cu cci cummatta cu sti pitarri!».
Donna in carriera, non se la sente di legarsi con alcuno di questi nobilissimi “pitarri”, come lei stessa dice. Altro che “mercede” del vincitor (quello che – Rambo ante litteram – doveva uccidere più infedeli). Non solo: né cristiani, né musulmani! Soprattutto non come glielo vogliono imporre.
Così, prima che fosse stato troppo tardi, Angelica montò in sella, girò la chiave e se la filò sgommando, lasciandoli alloccuti: “ciauru, beddi!”
Allora si avventurò per la selva. Una selva tutt’altro che oscura. Rigogliosa di verde fogliame rugiadoso, come ebbi già modo di dire in passato. Sul viottolo – uno dei tanti, in questo giardino dei sentieri che si biforcano – ecco che scorge da lontano un cavaliere, armato di tutto punto, che a piedi se ne veniva correndo.
11
Indosso la corazza, l’elmo in testa,
la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo;
e più leggier correa per la foresta,
ch’al pallio rosso il villan mezzo ignudo.
Timida pastorella mai sì presta
non volse piede inanzi a serpe crudo,
come Angelica tosto il freno torse,
che del guerrier, ch’a piè venìa, s’accorse.
12
Era costui quel paladin gagliardo,
figliuol d’Amon, signor di Montalbano,
a cui pur dianzi il suo destrier Baiardo
per strano caso uscito era di mano.
Come alla donna egli drizzò lo sguardo,
riconobbe, quantunque di lontano,
l’angelico sembiante e quel bel volto
ch’all’amorose reti il tenea involto.
13
La donna il palafreno a dietro volta,
e per la selva a tutta briglia il caccia;
né per la rara più che per la folta,
la più sicura e miglior via procaccia:
ma pallida, tremando, e di sé tolta,
lascia cura al destrier che la via faccia.
Di sù di giù, ne l’alta selva fiera
tanto girò, che venne a una riviera.
14
Su la riviera Ferraù trovosse
di sudor pieno e tutto polveroso.
Da la battaglia dianzi lo rimosse
un gran disio di bere e di riposo;
e poi, mal grado suo, quivi fermosse,
perché, de l’acqua ingordo e frettoloso,
l’elmo nel fiume si lasciò cadere,
né l’avea potuto anco riavere.
15
Quanto potea più forte, ne veniva
gridando la donzella ispaventata.
A quella voce salta in su la riva
il Saracino, e nel viso la guata;
e la conosce subito ch’arriva,
ben che di timor pallida e turbata,
e sien più dì che non n’udì novella,
che senza dubbio ell’è Angelica bella.
Cu iè stu cavaleri?
È una scena da immaginare questa. L’Ariosto ci aiuta con una similitudine: Il cavaliere correva più leggero del semi-nudo partecipante a certi palii organizzati presso la corte estense. Non sono belle visioni per gli occhi. Pensate al fastidio della ragazza quando scorse il tizio – che poi era il paladino Rinaldo – soprattutto se aveva in mente quelle strambe gare che si organizzavano in Ferrara. Viene da dire che schifo, no?
Angelica, non appena lo riconobbe, ebbe il tempo di spalancare gli occhi ed esclamare spazientita:
«Matri ‘mmaculata, proprio a chistu havia capitari!».
Niente idillio, nè delicatezze, c’è la fuga d’Angelica. La ragazza scuoteva il capo, nervosa. Una fuga strategica, sperando che quello non l’avesse scorta, o almeno riconosciuta.
Come quando incontriamo per strada l’ultima persona che si desidera vedere e si cerca una via d’uscita, in tutti i percorsi e le traverse possibili, sperando di non incappare nel vicolo cieco, o nella strada che fa il “giro dell’uovo”.
Rinaldo, signore di Montalbano, era appiedato perché precedentemente il Boiardo lo aveva fatto scendere da cavallo per farlo combattere ad armi pari contro Ruggiero (suo prossimo cognato). Il cavallo di Rinaldo, Baiardo (che non ha niente a che vedere col BOiardo), una vera star del mondo equino (ratananno di quelli che bardano a Scicli per la cavalcata di San Giuseppe, probabilmente), inspiegabilmente era poi fuggito.
Così adesso il paladino lo stava cercando, quando d’un tratto aveva visto la bella Angelica. A quel paese il cavallo, meglio la ragazza, no? L’inseguimento, su e giù per i sentieri del bosco durò un bel poco, sin quando la principessa del Cataio arrivò ad un fiume.
Ed ecco la fregatura di chiunque fuggendo un male, si ritrova per conseguenza a fronteggiarne un altro anche peggiore.
Il puzzolente Ferraù era al fiume, aveva perso l’elmo tra i flutti mentre si dissetava. Ferraù, figlio di Falsirone e nipote di Marsilio, aveva la pelle invincibile, nessuna lama poteva ferirlo. E questo non a causa di qualche stregoneria, ma per il semplice motivo che non si lavava. Altro che epidermide, lì si poteva parlare di scorza (o scorcia, in termini più siculi). Immaginate Angelica come doveva essere contenta di incontrarlo.
Tra l’altro, Ferraù, era stato l’uccisore di suo fratello. Sempre più simpatico, no? Per non parlar del fatto che a causa del patto stabilito dalla stessa principessa del Cataio (chi fosse riuscito a sconfigger Argalia, l’avrebbe sposata), adesso il moro pretendeva pure le nozze. Che felicità, per la principessa, eh?
Eppure a me questo olezzante eroe mi sta simpatico, che ci posso fare. Sarà qualcosa che abbiamo nel cosiddetto dna siculo (cosa in cui poco credo, a dire il vero, questo fantomatico dna di trinacria, ma non è tempo per parlarne). Infatti Ferraù da sempre è apprezzato tra i fans dell’opera dei pupi. Ma puzza, direte voi? ‘Nca facciamolo puzzare!!! Il ragazzaccio sporco e un po’ menefreghista, ma dal cuore ardente, ha sempre affascinato le masse. Doveva essere pure un po’ comunista, stando a ciò che se ne dice nelle zone di Arcore (i comunisti non si lavano, mi pare che si sia detto).
Angelica comunque scappava urlando, ormai seriamente intimorita dalla testardaggine di Rinaldo che la seguiva a piedi. Subito la riconobbe Ferraù, che come ho detto sostava vicino al fiume. E a quel punto, con Rinaldo ancor dietro, pure lei si rese conto di chi fosse quell’altro tizio::
«E porca la matosca, ma tutti a mia capitanu?!? Macari stu fitusu buzzurru haìa truvari!!!».
16
E perché era cortese, e n’avea forse
non men de’ dui cugini il petto caldo,
l’aiuto che potea tutto le porse,
pur come avesse l’elmo, ardito e baldo:
trasse la spada, e minacciando corse
dove poco di lui temea Rinaldo.
Più volte s’eran già non pur veduti,
m’al paragon de l’arme conosciuti.
17
Cominciar quivi una crudel battaglia,
come a piè si trovar, coi brandi ignudi:
non che le piastre e la minuta maglia,
ma ai colpi lor non reggerian gl’incudi.
Or, mentre l’un con l’altro si travaglia,
bisogna al palafren che ‘l passo studi;
che quanto può menar de le calcagna,
colei lo caccia al bosco e alla campagna.
18
Poi che s’affaticar gran pezzo invano
i dui guerrier per por l’un l’altro sotto,
quando non meno era con l’arme in mano
questo di quel, né quel di questo dotto;
fu primiero il signor di Montalbano,
ch’al cavallier di Spagna fece motto,
sì come quel ch’ha nel cuor tanto fuoco,
che tutto n’arde e non ritrova loco.
19
Disse al pagan: – Me sol creduto avrai,
e pur avrai te meco ancora offeso:
se questo avvien perché i fulgenti rai
del nuovo sol t’abbino il petto acceso,
di farmi qui tardar che guadagno hai?
che quando ancor tu m’abbi morto o preso,
non però tua la bella donna fia;
che, mentre noi tardiam, se ne va via.
20
Quanto fia meglio, amandola tu ancora,
che tu le venga a traversar la strada,
a ritenerla e farle far dimora,
prima che più lontana se ne vada!
Come l’avremo in potestate, allora
di chi esser de’ si provi con la spada:
non so altrimenti, dopo un lungo affanno,
che possa riuscirci altro che danno. -
21
Al pagan la proposta non dispiacque:
così fu differita la tenzone;
e tal tregua tra lor subito nacque,
sì l’odio e l’ira va in oblivione,
che ‘l pagano al partir da le fresche acque
non lasciò a piedi il buon figliuol d’Amone:
con preghi invita, ed al fin toglie in groppa,
e per l’orme d’Angelica galoppa.
22
Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui!
Eran rivali, eran di fé diversi,
e si sentian degli aspri colpi iniqui
per tutta la persona anco dolersi;
e pur per selve oscure e calli obliqui
insieme van senza sospetto aversi.
Da quattro sproni il destrier punto arriva
ove una strada in due si dipartiva.
23
E come quei che non sapean se l’una
o l’altra via facesse la donzella
(però che senza differenza alcuna
apparia in amendue l’orma novella),
si messero ad arbitrio di fortuna,
Rinaldo a questa, il Saracino a quella.
Pel bosco Ferraù molto s’avvolse,
e ritrovossi al fine onde si tolse.
24
Pur si ritrova ancor su la rivera,
là dove l’elmo gli cascò ne l’onde.
Poi che la donna ritrovar non spera,
per aver l’elmo che ‘l fiume gli asconde,
in quella parte onde caduto gli era
discende ne l’estreme umide sponde:
ma quello era sì fitto ne la sabbia,
che molto avrà da far prima che l’abbia.
25
Con un gran ramo d’albero rimondo,
di ch’avea fatto una pertica lunga,
tenta il fiume e ricerca sino al fondo,
né loco lascia ove non batta e punga.
Mentre con la maggior stizza del mondo
tanto l’indugio suo quivi prolunga,
vede di mezzo il fiume un cavalliero
insino al petto uscir, d’aspetto fiero.
26
Era, fuor che la testa, tutto armato,
ed avea un elmo ne la destra mano:
avea il medesimo elmo che cercato
da Ferraù fu lungamente invano.
A Ferraù parlò come adirato,
e disse: – Ah mancator di fé, marano!
perché di lasciar l’elmo anche t’aggrevi,
che render già gran tempo mi dovevi?
27
Ricordati, pagan, quando uccidesti
d’Angelica il fratel (che son quell’io),
dietro all’altr’arme tu mi promettesti
gittar fra pochi dì l’elmo nel rio.
Or se Fortuna (quel che non volesti
far tu) pone ad effetto il voler mio,
non ti turbare; e se turbar ti déi,
turbati che di fé mancato sei.
28
Ma se desir pur hai d’un elmo fino,
trovane un altro, ed abbil con più onore;
un tal ne porta Orlando paladino,
un tal Rinaldo, e forse anco migliore:
l’un fu d’Almonte, e l’altro di Mambrino:
acquista un di quei dui col tuo valore;
e questo, ch’hai già di lasciarmi detto,
farai bene a lasciarmi con effetto. -
29
All’apparir che fece all’improvviso
de l’acqua l’ombra, ogni pelo arricciossi,
e scolorossi al Saracino il viso;
la voce, ch’era per uscir, fermossi.
Udendo poi da l’Argalia, ch’ucciso
quivi avea già (che l’Argalia nomossi)
la rotta fede così improverarse,
di scorno e d’ira dentro e di fuor arse.
30
Né tempo avendo a pensar altra scusa,
e conoscendo ben che ‘l ver gli disse,
restò senza risposta a bocca chiusa;
ma la vergogna il cor sì gli trafisse,
che giurò per la vita di Lanfusa
non voler mai ch’altro elmo lo coprisse,
se non quel buono che già in Aspramonte
trasse dal capo Orlando al fiero Almonte.
31
E servò meglio questo giuramento,
che non avea quell’altro fatto prima.
Quindi si parte tanto malcontento,
che molti giorni poi si rode e lima.
Sol di cercare è il paladino intento
di qua di là, dove trovarlo stima.
Altra ventura al buon Rinaldo accade,
che da costui tenea diverse strade.
32
Non molto va Rinaldo, che si vede
saltare inanzi il suo destrier feroce:
- Ferma, Baiardo mio, deh, ferma il piede!
che l’esser senza te troppo mi nuoce. -
Per questo il destrier sordo, a lui non riede
anzi più se ne va sempre veloce.
Segue Rinaldo, e d’ira si distrugge:
ma seguitiamo Angelica che fugge.
Alla sedicesima ottava Ludovico Ariosto ci informa della cosiddetta “cortesia” di Ferraù, preoccupato dalle urla della fanciulla in fuga dall’allupato Rinaldo. E di come subito si mise pronto a difenderla da qualunque male la minacciasse. Ma soprattutto ci rende edotti del fatto che il petto e l’animo del saracino non si inebriava certo meno di quello dei due cugini – la premiata coppia Orlando e Rinaldo – in quanto ad amor per Angelica. Ed ecco allora il moro guerriero che snuda il brando e va incontro a Rinaldo, a lui già noto per duelli precedenti.
Così tra i due comincia una crudel battaglia. Sembra quasi di sentir il fracasso della ferraglia che si ammacca, fateci caso. Ariosto dice che ai colpi dei due eroi non avrebbero resistito neanche le incudini. Per un attimo il lettore si lascia confondere e trascinare romanticamente sino al ricordo dei duelli cortesi o all’Opera dei Pupi.
Ma qualcosa ci distrae d’un tratto, un pensiero: che sta facendo Angelica, nel frattempo? È la seconda volta che la perdiamo di vista (la prima volta fu durante lo scontro dei due eserciti, mori-franchi. Noi rimbecilliti a guardare il luccichio delle armature sfavillanti, mentre lei se la svignava dal padiglione del duca di Baviera). Dunque, adesso, Angelica se ne sta immobile e commossa dai due che si battono per lei?
‘Nca quali!!! La picciotta è già lontana. Mentre quelli si affirravano, lei, ancora una volta, se la scappò, cari miei. E Rinaldo e Ferraù continuarono per un bel po’ a mazziarisi, prima che col sopraggiungere d’una leggera stanchezza si facesse largo anche in loro lo stesso pensiero che prima turbava noi:
«E Angelica?» – si chiesero i due cretini.
Il primo a rendersene conto fu proprio Rinaldo – signore di Montalbano – che, alzando la mano, così disse al compagnetto:
«’Ma frati, fermiti. Cchi nun lu viri ca la picciotta nun c’è? E cchi ni sciarriamu a fari, nuiautri?».
Beh, Ferraù dovette convenire che veramente non c’era più motivo di litigio. Rinaldo riprese ancora a parlare:
«Beddu miu, cca, mentri nuiautri ni mazzuliamo, la fimmina si nni va luntana. Ma ni cummena perdiri ancora tiempu? Sienti a mia, ma frati, lassamu perdiri, iu la spada e tu la scimitarra, e gghimu a circari Angelica. Quannu puoi la ritruvamu e allura attorna ni sciarriamu. Cchi dici?».
Al pagan la proposta non dispiacque: così fu differita la tenzone;- dice Ludovico. E visto che ora questi due prodi cavalieri già sembrano meno eterei e più umani, il poeta ci mette il carico di sopra e, dopo un rapido scambio di gentilezze e premure vicendevoli, li fa montare sullo stesso cavallo (si ricordi che Rinaldo è appiedato) e lì fa andare alla ricerca della loro desiderata Angelica.
Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui! Eran rivali, eran di fé diversi, e si sentian degli aspri colpi iniqui per tutta la persona anco dolersi; e pur per selve oscure e calli obliqui insieme van senza sospetto aversi.
E per fortuna che l’Ariosto ci aveva già lasciato capire che i cavalieri cortesi son tutta fantasia, se no ora chissà come ci restavamo male, no? Con il pericolo di ripetermi, lo ribadisco: in Ludovico Ariosto c’è un forte desiderio di smitizzazione. Ecco perché questi cavalieri antiqui suonano come uno sbeffeggiare quanti vogliono ad essi far risalire la propria stirpe (vd. gli Estensi per Ludovico, ma la cosa è rinnovata anche dai politici di oggi: tutti dicono di ispirarsi al pensiero di De Gasperi o di Berlinguer…mah?!?).
Allo stesso tempo – sempre rivolgendosi a questi personaggi in cerca di radici mitologiche – si dice: “Taliati, cavalieri moderni, vere o false che siano queste storie di uomini eccezionali, vi firati a fari na cosa ri chista oggi?”. Quanti dei nostri moderni cavalieri interromperebbero il loro litigio, se venissero a mancare i motivi reali dello stesso? E quanti salirebbero insieme sullo stesso, unico cavallo disponibile, almeno per mettersi alla ricerca del “problema”, se non per risolverlo?
Dice anche questo l’Ariosto. Ma non basta, in realtà io credo ci sia un ulteriore livello di comprensione, per questa frase, in apparente contrasto con quanto appena detto. Ed è il momento più difficile di questo post. Mi rendo conto che qui il mio discorso diviene ostico, forse anche a causa dell’esigenza di non dilungarmi. Ma adesso cerco di spiegarmi meglio:
l’Ariosto era pur sempre un consumato diplomatico, dunque sapeva bene che molto spesso le diatribe che nascono tra Signori locali, altro non sono che mera apparenza e i suoi gestori (i gestori dell’apparenza, cioè i Signori locali) non fanno che accampare pretestuose ed inconcludenti giustificazioni politiche a motivazione di tale litigiosità.
Tutte cose cui la popolazione (l’elettore/sostenitore di quei signori/gestori), culturalmente inerme, fa spesso sincero affidamento, suo malgrado.
Puh, quanti voti mi capitau macari a mia ri siri culturalmente inadeguato a capire che i Signori locali spesso fingono di litigare.
Intendiamoci, non che non ci siano reali scontri politici (anche poco cavallereschi), ma di questi, spesso, non abbiamo una reale percezione materiale. Le cose più vere sono sempre quelle meno tangibili. Gli scontri reali sono quelli dissimulati o occulti.
Ma ritornando a ciò che constatiamo ogni giorno: li avete visti i politicanti in TV quando si sciarriano tra di loro e poi, appena fuori (dalle sedi parlamentari come dagli studi televisivi), se ne vanno assieme a “mangiare” (in tutti i sensi)? Qui la popolazione, talvolta, non è solo culturalmente inerme, ma è anche ignara dei “fatti reali”, che poi spesso è cosa coincidente con la mancanza di un bagaglio culturale adeguato.
A scanso di equivoci, qui tutti siamo culturalmente inadeguati a tali cose. Non mi si fraintenda, cultura non significa leggere libri (o almeno non solo questo e comunque non sarebbe affatto bastevole). Utilizzo cultura in una accezione diversa, cioè quella derivante “colere”, cioè coltivare il proprio campo di conoscenze, come si fa con le patate. Un campo che non è solo di chi lo sta coltivando, ma anche di chi lo ha coltivato e lo coltiverà. Conoscenza dei fatti (seppur talvolta illusoria) questa è cultura. E se avete trovato contraddizioni nel discorso sin qui fatto, vi prego di non preoccuparvene più di tanto.
La contraddizione vuol dire avere più possibilità di aver beccato un qualcosa che si avvicina alla Verità! Se uno si contraddice in più posizioni, avrà più possibilità di aver ragione, rispetto a chi rimane sempre miseramente coerente con la posizione iniziale, no?
Infatti Rinaldo e Ferraù giungono ad un bivio. Che cosa fare? Quale via scegliere? Quale via predilige l’Ariosto? La cosa strana – e credo che Borges se ne sia fatte di risate sul punto – è che, nei sentieri che si dipartivano, “senza differenza alcuna apparia in amendue l’orma novella”. Eh, vacci a capire qualcosa. Angelica è una mezza strega, non scordiamocelo. E poi, esistono delle giustificazioni metafisiche: una ad esempio potrebbe essere che Angelica abbia incoerentemente intrapreso entrambe le vie, tanto per assicurarsi di non sbagliare, come dicevo poco prima. Sono cose che noi solamente percepiamo faticosamente, senza capirle. Per cui lasciamo che il fatto si sedimenti e si esplichi da solo. Andiamo avanti…
Al bivio i due ritrovati amici si dividono: Ferraù va da una parte e Rinaldo dall’altra. Il saracino molto pel bosco s’avvolse. Questo “avvolgersi” non può che farci pensare ancora una volta al Giardino dei Sentieri che si Biforcano, di memoria borgesiana. Ferraù, al termine di questo “avvolgimento”, di questo aggrovigliare il filo della vita, nel suo eterno dipanarsi ed imbrogliarsi, si ritrova al punto iniziale.
Fate voi, o lettori, i ragionamenti filosoficamente adeguati su questo risultato.
Ferraù, in buona sostanza – come direbbe lo zio di Johnny Stecchino – è nuovamente sulla riva del fiume ove havìa persu l’elmo. Il saracino di Spagna, riflette un pochino e si risolve con una alzata di spalle:
«Lassamu perdiri Angelica, tantu ri stu passu pierdu sulu tiempu.».
E si rimette a cercare l’elmo.
Italo Calvino fa notare lo stato di assoluta apatia mentale di questi eroi. Sono incoerenti, tanto per ritornare ai discorsi di prima e farvi capire che non stavo vaneggiando in preda a chissà a quali mezzi di alterazione percettiva.
Seguitemi nella cronologia degli eventi: Ferraù lascia la battaglia perché ha sete, cerca un fiume e mentre beve gli cade l’elmo dentro l’acqua. Si mette a cercarlo. Poi arriva Angelica, allora lassa futtiri l’elmo e va appriessu a picciotta. Ritorna casualmente (e potrebbe essere un caso intenzionale) al fiume, dunque si rimette a cercare l’elmo come se nulla fosse accaduto prima. E ho pure omesso un duello non terminato.
È gente ben strana questa, non credete? Ondivaga come l’umanità coi suoi desideri, si potrebbe dire, no? Un non-sense questo.
L’umanità è strana? E cosa c’è di strano se è caratteristica quasi costituzionale l’essere così presti al dimenticare quello che si dovrebbe fare, per correr dietro ai desideri più o meno irraggiungibili?
Ma la stranezza generalizzata, è ancora stranezza o essa sopravvive solo nel “particolare”?
Forse allora sono le ipocrisie del nostro vivere mondano a farci dire che questo è comportamento “strano”?
Possiamo mica dire al prossimo che in fondo, in fondo in fondo, tutti siamo un poco egoisti?
Qualche stimato autore di critica dice che i personaggi dell’Ariosto sono poco caratterizzati psicologicamente e da intendere solo nell’intreccio sociale. Così come si potrebbe guardare dall’alto alla “società”, dicono.
Però noi sappiamo che – passando dal macro al micro (sul tema ho avuto piacevoli scontri di vedute con l’esimio sig. Guglielmo Pacetto) – poi l’individualità esiste, no?
Il pensiero sociale moderno ormai ne ha persino confermato l’esistenza. E vi giuro che si è faticato a comprendere che la socialità è individualità allargata. È stato un percorso difficile sempre a causa di quelle ipocrisie che non ci consentono di apprezzare il valore della contraddizione.
Dunque io starei attento a dire che i cavalieri di Ludovico non abbiano personalità. Credo che il fatto sia solo non esplicitato dal poeta. Ed è più che realistico. Solo faticosamente si riesce a percepire la reale consistenza psichica dell’altro che si pone di fronte. Molto spesso, del resto, operiamo in maniera deduttiva o tiriamo ad indovinare interpretando i sogni. Ma non per questo ci azzardiamo a dire che il prossimo sia privo di personalità.
Ferraù, allora, cerca cerca, cerca nel fondale sabbioso dell’inconscio personale. Cerca l’elmo perduto. Sonda il terreno con un ramo spezzato. Sin quando spunta fuori l’insondabile. Ciò che è imprevisto e se appartiene a qualcosa – semmai possa appartenere a qualcosa – sarà il mondo dell’inconscio collettivo ad averlo in sé. Passiamo dunque dal personalismo individuale di Freud al collettivo Junghiano, ritorniamo dal micro al macro.
Cos’è l’insondabile? Sul finire della venticinquesima ottava, spunta fuori per metà, a mezzo busto, sul fiume, un cavaliere.
E cu è chistu ora? Ve lo state chiedendo, dite la verità.
È Argalia!!! Il fratello di Angelica, quello che era stato appunto ammazzato da Ferraù. La visione sembrerebbe di reminiscenza dantesca (vd. Farinata degli Uberti che ad un certo punto del Canto Decimo dell’Inferno, decide di spuntare a mezzo busto dal suo sepolcro).
Sennonché, nel nostro caso (grazie Ariosto di non essere Dante) la cosa scade nel ridicolo, anche a causa del grande sbavientu che si prende il prode Ferraù. Si scantau, si scantau, l’eroe imbattibile e puzzolente si scantau. Il fantasma di Argalia con la destra teneva l’elmo in questione. Ferraù aveva gli occhi di fuori e i capelli rizzati che sembrava “u spavintatu a stidda” (figura tipica del presepe siciliano), non fiatava.
«Piezzu ri deficiente, circavutu chistu, ah? – fece l’etereo figuro – Ah mancator di fé, marano! perché di lasciar l’elmo anche t’aggrevi, che render già gran tempo mi dovevi?»
Era seriamente incazzato il fratello morto di Angelica. Il fatto è che, a suo tempo, in punto di morte, al suo uccisore (Ferraù, per l’appunto), aveva chiesto e fatto promettere che avrebbe gettato il suo elmo in un fiume. Ora, guarda caso, il Caso aveva voluto che questo cadesse tra i flutti, da sé, per il desiderio di una sorsata d’acqua.
E ci sono politici nazionali che sanno bene quanto possa esser insidiosa una sorsata d’acqua (mi riferisco ai recenti referendum sulla privatizzazione di essa).
Dunque Argalia dice ancora:
«E allura ora nun ti contrapigghiari se u casu vosa accussì, piuttosto turbati del fatto ca mancasti alla prumissa! – poi continuò con tono più accondiscendente – Comunqui, se propriu vuoi n’elmu spacchiusu, cercatinni n’autru. Ad esempiu chiddu ri Orlando, eh, chissu iè nu bellu elmu. O masinnò chiddu ri sa cujinu Rinaldo, eccu, chissu macari, è nu gran bellu elmu. Però t’ha procurari cu onore, no comu facisti cco miu, ah. E sentimi, se ti firi a vincillu, unu re rui…tenatillu strittu stavota, cretinu!».
Al termine della rampogna, Ferraù non fiatava ancora, ma stavolta a bocca chiusa. Era vergogonoso per ciò che aveva fatto. Allora giurò su sua madre Lanfusa l’imbecille, piuttosto che mandarli tutti a quel paese ed andarsene a mare…
Giurò che no, non avrebbe mai più avuto elmo diverso da quello che Orlando trasse dal capo del fiero moro Almonte in quel di Calabria, sull’Aspromonte (riferimento a fatti della Chanson d’Aspremont).
Così adesso lasciamo Ferraù, che se ne va a cercare Orlando in giro per le vie del mondo, dimenticando la “santa” guerra tra mori e cristiani. E forse non era poi tanto imbecille, l’elmo è sicuramente cosa ben più seria, rispetto all’insostenibilità logica di una guerra santa.
Rinaldo, frattanto, non aveva proseguito molto per la sua strada, che si vide spuntar davanti Baiardo, il suo cavallo. Ricordate? Era a piedi proprio perché il suo fido e nobile destriero se l’era pensata e se n’era andato per i fatti suoi. Un po’ come quando, dopo aver posteggiato in discesa, ci si dimentica di tirare il freno a mano, più o meno (ma molto più o meno, poiché qui il cavallo aveva una sua personalità ben definita, molto più di quella di una maggiolino tutto matto).
Rinaldo, pure lui, si dimentica di Angelica e della guerra santa (cui neanche minimamente aveva pensato sin dalla fuga equina), e comincia a rincorrere nuovamente il suo cavallo.
Tutto come prima, insomma. La vita riprende, con la sua assurda routine quotidiana. Ognuno alla sua occupazione. Ognuno dietro i propri desideri e speranze.
L’ottava si conclude volgendo lo sguardo ad Angelica che fugge. Una delle tante aspirazioni umane (tra le maggiori, potrei azzardare). Ma noi non possiamo andargli dietro, almeno per ora. Le spiagge dorate e profumate di sole ardente ci aspettano! Le onde che si affacciano con moto indolente sull’umida battigia e la coprono ad intermittenza. I piedi immersi ed il pensiero vuoto, privo di costrizioni occupazionali e di vestiario formale…etc, etc, etc…
Alla prossima puntata…
<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=&t=” target=”blank”>
Gaetano Celestre