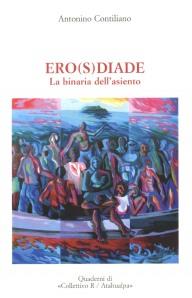 Percorsi verso l’ignoto. Antonino Contiliano, Ero(s)diade. La binaria dell’asiento, con un’Introduzione di Sergio Pattavina, Firenze, Quaderni di Collettivo R / Atahualpa, 2010
Percorsi verso l’ignoto. Antonino Contiliano, Ero(s)diade. La binaria dell’asiento, con un’Introduzione di Sergio Pattavina, Firenze, Quaderni di Collettivo R / Atahualpa, 2010
_____________________________
di Giuseppe Panella*
Erodiade, dapprima moglie del Tetrarca di Galilea Erode Filippo I e madre di una famosissima Salomè, poi compagna di Erode Antipa fratello del precedente marito dopo il divorzio da quello, non ha mai goduto di buona letteratura. La sua impresa principale – quella di richiedere al marito la testa di Yokanaan-Giovanni il Battista per il tramite della danza dei sette veli di sua figlia – l’ha consegnata alla storia come l’esempio di una tragica cortigiana reale. Un’intera letteratura di taglio decadente-espressionistica – dalle pagine originarie del terzo evangelista Marco a Oscar Wilde, da Giovanni Testori al Pier Paolo Pasolini del Vangelo secondo Matteo, da Carmelo Bene a Ken Russell fino a Carlos Saura in una lunga sequela di ritratti a metà che privilegiavano la figlia ai danni della madre – la mostrano come una donna angosciata, rosa dall’ambizione, dotata di un erotismo torrido e perverso che, però, non dura nel cuore degli uomini sui quali dovrebbe regnare.
E, allora, perché dedicarle il titolo di una raccolta di versi che apparentemente si occupa di tutt’altro? Scrive, a questo proposito e per farsene una ragione, Sergio Pattavina nella sua cospicua Introduzione al volume (L’indignazione di Contiliano):
«Ma la (s) introdotta nel nome del personaggio biblico, spezzandolo, ci rimanda più verisimilmente all’autodafè “erodiade”, col quale Contiliano ci avverte della dualità “platonica” della sua storia poetica, dell’uno e del molteplice, della diade infinita appunto, che è stata l’asse costante della sua ricerca, e per certi versi l’insuperata contraddizione della sua poesia […]. Nello stesso tempo, la (s) rimanda, separando e unendo i sue lemmi, al ruolo che Ero(s) svolge, come figlio di Poros e Penia, nell’unire la Via e l’Assenza, e nello spezzare costantemente questa unità : ordine della ragione e disordine della follia (ancorché poetica), il qui e ora della storia e l’altrove dell’utopia, l’immanenza e la trascendenza, l’apollineo e il dionisiaco, il culto della tradizione e il dàimon dell’innovazione, la lingua “additata di patri” e la babelica mescolanza di tutte le lingue possibili, la poiesis dunque come conflitto tra langue e parole immanente al divenire storico, al fluire discontinuo e ininterrotto del tempo» (pp. 7-8).
Diade, dunque, come divisione netta in due della propria storia personale che in virtù di questa divaricazione si rovescia in quella generale; diade come alternativa e separazione tra realtà diverse, tra progetti differenti e convergenti solo nella poesia; diade come aspirazione al sogno e all’utopia che si fanno connessione diretta con la realtà rifiutata del presente e, nello stesso tempo, amata come potenzialità del futuro. Come disse il grande matematico Evariste Galois difendendosi durante un processo politico intentatogli per sedizione: “Solo chi odia fortemente il presente potrà amare potentemente il futuro”. Contiliano sembra aver adottato questo stemma così drammatico a mo’ di guida per la sua carica lirica attraverso il mondo malato delle parole del mondo presente:
«ERO(S)DIADE. Il cavaliero, il duce, il puzzo, il prepuzio, / il trend, il truce, etaut, autet / réseau di mercato, miasmi allo spasmo / e lui ch’el cuce e spulce parassita, dio / gode da solo, la moglie è frigida / e nessuna grotta è più sicura // ero(s)diade ! // al supermercato l’anima sali / cestello sei d’incensi al castello / e alla guerra vai e non morirai / third sul carrello sedia stai // giacobino o bolscevico, mai Mao al club / del G8, may day mai dai venti se sei sei / good e beds, e n’est pas réseau d’egaux / nettezza spia e fermenta gli eventi / e sub-urbana è negozia bicamerale // destrezza // sinistra e destra cresce il salotto / malandrino e supino pompino // aggiotaggio enrangés i sanculotti / a mediaste medium l’emozional- / emoticon popular bandoliero decolla / il decollato nazional delle bandere nere / Giovanni cantiere delle libertà aperto / a magnar cinico e clinico magnana / ognor botanico e alla mano cer- / bottana con l’arem del sultano» (p. 15).
Il ritmo incalzante dei significanti spinge e sommuove l’inconscio dei significati. Ogni cosa è doppia, spaccata, separata, biforcata: destra e sinistra, alto e basso (anche nel linguaggio che attinge al triviale per separarsi dall’alto lirico del sublime), verità e menzogna, apparenza e verità, ipocrisia e menzogna mediatica. Anche il linguaggio oscilla, si fa ironico, parodico, spiazzante e rovina alla fine nello slogan politico del decostruzionismo più spinto e talvolta più ostico.
Una possibile chiave di lettura del libro è contenuto inoltre nel sottotitolo, quella binaria dell’asiento che riporta indietro l’orologio della scrittura di Conciliano, al Seicento spagnolo delle concessioni (gli asientos appunto) per la tratta e il trasporto degli schiavi di colore che la Corona madrilena ha sempre sottoscritto con singoli privati o compagnie commerciali fino alla fine del Settecento. L’asiento, dunque, è simbolo di schiavitù, di asservimento, di dominio e ne manifesta la sua duplice natura: linguistica e politica. Rotta binaria di mancanza di libertà e di sua possibile (ri)conquista, ad esso è dedicata la duplicante natura della scrittura contiliniana:
«FUSIBILE. Lavoro precario / mangio saltuario / mi innamoro a orario / dipendo dall’erariooooo // sono flessibile sono un fusibile // scopo in solaio / l’amore in affitto / mi viene una fitta / mi faccio un erbariooooo // sono flessibile sono un fusibile // sono di transito / mi manca l’approdo / navigo un sito / divento un colabrodooooo // eye tracker mi veglia / un acro mi spoglia / mi suda l’ascella / eccomi in cellaaaaa // sono flessibile sono un fusibile // ci vuole un hacker / ci vuole un falsario / ci vuole un breviario / ci vuole un sudariooooo // sono flessibile sono un fusibile // ci vuole un prontuario / ci vuole un assassino / ci vuole Johnny Stecchino / ci vuole un fornaiooooo // sono flessibile sono un fusibile // è l’ora del delirio / manca il collirio / giustizia a frittelle / tribunali a panelleeeee // sono flessibile sono un fusibileeeee» (pp. 48-49).
Il rischio della poetica di Contiliano è quella per essere scambiata per un’esaltazione del girare a vuoto, della proliferazione di parole in libertà, dello scatto poetico come piétiner sur place. Senza concludere nulla e rimanere legati alle proprie parole sparse qua e là senza sapere dargli il giusto e rigoroso senso lirico. La paura che il testo poetico risulti, alla fine, solo fine a se stesso e pura finalità del suo autore è paventata dallo stesso autore (come annota giustamente anche il prefatore Patavina a p. 11). Nel testo precedente il limite della comprensibilità è raggiunto e le impennate, i gridi, le elocuzioni e le onomatopee si rincorrono e rimbalzano le une sulle altre. I segni si manifestano come tali e il significato sembra annegare nella pozza dei significanti molesti. Eppure nella lunga estensione dei modi più o meno significativi in cui può essere elaborata l’odissea di vita del precario “flessibile” e il suo essere destinato a bruciare come un “fusibile” c’è tutto un mondo – di povertà esistenziale, di emarginazione, di impossibilità ad essere tutto intero nella propria attività umana. Il “fusibile” è fatto di energia sprecata e dissipata nell’atto dell’accendere la luce; il “flessibile” è destinato a piegarsi e a essere usato da chi ha il potere di gestirlo e di utilizzarlo per i propri fini. Il suo grido è ironicamente coniugato come l’espressione rabbiosa di una mancanza, di un’assenza di esistenza che adotta i volti e le maschere dei presenti e vincenti. Allo stesso modo, ad esempio, resta insondato il mistero di ciò che è accaduto all’Io di ognuno dal momento in cui si è scisso ed è esploso in mille pezzi non più ricomponibili e si rivela soltanto come un avatar:
«CAVE AVATAR. Ave, drago je accuse / ago e go, godo come mai / e per e-mail odo la rete // festina son vago e spago / Gorgia spacco le parole / in tre parti uguali e angolo / e amico di scena passo tosto / geometria e asimmetria // Euclide dissi, incredibile // si può vivere con la morte / decidere bisogna dentro / e tra scaglie e scogli / infierire il contagio // non è più tempo di chiedere / esigere è tempo e insieme / danzare come zanzare / tumori parole bando sbando / più incendio e bandoliere // qui sulle frequenze in fuga / tra le scene e le poltrone / chi butta la battuta tutta / e fuma la notte sul mondo? // voce è nostra nel sottoscala segate / costi aggiuntivi e tagli liberisti / o carta di credito e schiavo per debiti / se Cesare non dimagrisci e pisci // dimmi come tracciare radionde / queste voci big bang fuoriquinte / perché intermittenze eco ribelle / biondo il silenzio sopravviva slums / banlieuses metropolitani skizomedia / e cablati bastardi senza fondo / vento non spento e non lento» (pp. 60-61).
L’avatar di ognuno incombe e si maschera da vero sembiante simbionte – la poesia cerca di snidarlo attraverso l’uso obliquo e spiazzante delle parole del suo delirio. Così Antonino Contiliano si sdoppia e raddoppia la propria volontà di distruzione critica del linguaggio che pure utilizza: solo contro l’universo di discorso dominante, ha soltanto il suo doppio per difendersi dalle logiche del delirio che imperversano nel mondo dominato e amministrato dalla potenza del Potere vigente.
___________________________
[Leggi tutti gli articoli di Giuseppe Panella pubblicati su Retroguardia 2.0]
_____________________________
*Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)






