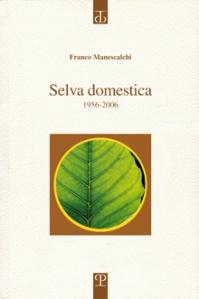 Intus et in cute: il tempo secondo di Franco Manescalchi. Franco Manescalchi, Selva domestica (1956-2006), prefazione di Marco Marchi, Firenze, Polistampa, 2011
Intus et in cute: il tempo secondo di Franco Manescalchi. Franco Manescalchi, Selva domestica (1956-2006), prefazione di Marco Marchi, Firenze, Polistampa, 2011
_____________________________
di Giuseppe Panella*
.
Selva domestica è il tempo secondo della produzione poetica di Franco Manescalchi: secondo in ordine di tempo (anche se raccoglie testi che vanno dal 1956 fino a tutto il 2006), secondo nel senso etimologico del termine in quanto felice ritorno alla scrittura poetica dopo l’apparente chiusura delle pagine liriche presentata in La neve di maggio, la precedente raccolta che chiude il secolo che è trascorso o forse apre il secolo che viene. Selva domestica è, dunque, ancora un libro di sintesi ma nel senso peculiare in cui il termine può avere per un poeta come Manescalchi.
Non si tratta, infatti, di scandire un percorso temporale ma di scaglionare spazio per spazio i tempi del sentire aggregandoli in mannelli non legati dalla fune feroce del tempo ma racchiusi e stretti dalla mano pietosa della ricerca poetica di una situazione nuova, di un ubi consistam che non sia acquiescenza al vecchio e al logoro ciò che è stato.
Selva domestica è, in realtà, un tentativo di ridare vigore ai temi che erano già presenti in La neve di maggio ma provando a saggiarli non più e non soltanto sul versante della poesia civile e dell’impegno militante quanto su quello di una domestica pietas per le cose e le frequentazioni del mondo circostante (le poesie sul gatto di casa, tra cui una – assolutamente deliziosa – in vernacolo, vanno in questa direzione). Libro intimo ma non per questo meno civile, “politico”. Libro intenso ma non per questo incapace di uno sguardo largo sulla vita e sul mondo. Libro autobiografico ma privo di quell’impossibilità a comprendere gli altri esseri umani che troppo sovente campisce la voluptas dolendi della lirica della profondità spirituale (o presunta tale). Libro, infine, capace di rendere conto della verità del tempo che passa pur non essendole soggiacente e schiacciata in maniera esorbitante. Libro, in conclusione, di una vita ancora in divenire e che ha ancora tutto da dire come se le parole e le cose che la costellano non fossero combacianti ma inseguissero due strade o due destini diversi e spesso configgenti.
Manescalchi è poeta lirico ma il suo lirismo è stretto, composto, dilavato – come se ciò che è sovrabbondante o superfluo venisse di volta in volta raschiato o rimosso.
La passione che lo abita si risolve in modi composti (anche se commossi e rilucenti di empatia) e non c’è praticamente mai un aggettivo di troppo o un eccesso di bravura o una sbavatura retorica che potrebbero tradirla. Scrivere poesia, per Maniscalchi, significa confrontarsi con il passato che dirupa nel presente senza troppe speranze per il futuro: è un gioco difficile da condurre ma fatto di azzardi calcolati. Dice bene Marco Marchi nella sua lunga Prefazione alla raccolta:
«Una “città scritta” – dapprima Firenze, e insieme, fin dai tempi più antichi, con Firenze e con la poesia, il mondo – si è al contrario immediatamente parata all’orizzonte, consentendo all’esercizio poetico complesso di Manescalchi le giuste coordinate ambientative di tipo societario, secondo un irradiamento che ha presupposto nel poeta, costantemente, accanto ad un lavoro creativo di scrittura in proprio, a tu per tu con la pagina bianca e con la formalizzazione di testi, l’attenzione alle parole degli altri e ai significati profondi a quelle parole delegati. Una poesia multiforme e disponibile, poco importa se talora perfino solo un conato di poesia o un suo desiderio rimasto irrealizzato, rintracciabile con molta umiltà e con molta pazienza positivamente presente e incentivabile in un microcosmo di relazioni e quotidiani rapporti, pronto giorno dopo giorno ad assurgere a valori allargati: valori a loro modo confortanti e stimolanti, e nel contempo di verifica nei confronti di quella necessità espressiva e comunicativa che la pratica della poesia porta sempre con sé» (p. 6).
Difficile separare anche questa Selva domestica da Firenze, dal suo contesto di città antica e sempre attraversata da conflitti e scontri e contrapposizioni spesso brutali e irricomponibili; difficile separare la poesia di Manescalchi dal suo impegno culturale, rifiuto insieme della turris eburnea e della facilità affabulatrice della “poesia di strada” e di riporto linguistico. Difficile ancora leggere questa poesia come un commiato al tempo che fu – piuttosto un appello ai posteri, una “lettera” – leopardianamente indirizzata – “ai giovani del XXI secolo” o una sorta di J’accuse senza appello.
Certo Manescalchi è poeta eminentemente novecentesco, teso al rifiuto di certe modulazioni romantico- ottocentesche che ancora affliggono talvolta il pur amato Betocchi o gli ermetici minori della “seconda generazione” ma neppure proclive a uno sperimentalismo fine a se stesso che rifiuta la passione o il sentimento umile e profondo in nome di un tecnicismo ostico e, nello stesso tempo, im-poetico. La volontà di scrittura lirica permea tutto il suo percorso dal ’56 a oggi – un lirismo fatto di cose però e non solo di impalpabili linee di frattura tra realtà e sogno, una liricità densa, ferrosa e implacabile, tenera e terribile ad un tempo (da “ladro di ciliegie” – per citare insieme e Brecht e Fortini). La Musa di Manescalchi è di quelle che vanno affrontate a muso duro: democraticamente dà spazio a tutto ma molto aristocraticamente ne concede davvero solo a pochi.
Non è poesia facile anche se apparentemente lo sembra: musicale e musiva, tende drammaticamente al diapason dello scacco tra parola e immagine, tra tentazione descrittiva e sprofondamento lirico.
«CARTOLINA POSTALE. sono stanco davvero: ho visto il mare / nelle pendici fra volterra e cecina / dove il tempo si scioglie in mille pieghe / e i fantasmi camminano sull’acqua / del passato remoto che ritorna / ho visto il mare della preistoria / alzarsi sulle crete lavorate / e rianimare i fossili / sono stanco davvero: a populonia / ho sentito le acque ritirarsi / e riemergere il golfo di baratti / coi bastioni murati dove adesso / le alghe ricominciano il percorso / precario dei millenni verso casa / uscendo da quel gioco di colline / e di lingue di terra senza tempo / dove Firenze appare oltre le balze / del chianti ogni apparenza ha preso il volo / e sono stanco d’essere nel vero» (p. 31).
Difficile non pensare a quel “tra Cecina e Corneto” di Dante del canto tredicesimo dei suicidi che qui si evoca ma è altrettanto facile sbarazzarsene: Manescalchi non cita (al massimo ruberà – come scriveva T. S. Eliot dei “veri poeti”). La profonda malinconia di questi versi non esclude la gioia di vedere attraverso le parole e di descrivere il passare del tempo, narrare la storia che nasce da antichità remote (“il mare della preistoria”), rinnovellare il percorso antico in nome di una possibile uscita dal cul-de-sac della contraddizione tra la verità e l’apparenza del mondo.
La carte postale spedita è un ricordo di ciò che è stato, l’approccio riuscito a una memoria che non vuole scomparire e che, invece, si dilegua (“prende il volo”) nel momento in cui le parole ne prendono possesso definitivo. Più tardi lo dirà esplicitamente nelle sue Contro-pagine per Guido:
«Questa la casa dove sono nato / dove il presente si è fatto passato / e la gente / era felice / di incontri da niente // dove sono morti / e risorti / i miei vecchi / e io / coi calzoni corti / mi perdo per gli orti // Questa la casa che / tocco vedo percorro / a passi lievi ma / non c’è. // Non ci sono / tutte le cose / che han dato un senso alla vita / i conti fatti a matita / su quaderni dimessi / e che alla fine del mese / erano sempre gli stessi // l’odore buono / del pane appena sfornato / e le lacrime amare / di mia madre. // Cose così dette a caso / appena a lume di naso / per finire / nelle spire di fumo / del presente. // Mio padre mordeva limoni / interi, con tutta la buccia. / Adesso appesi a una gruccia, / son statue i suoi abiti buoni» (pp. 87-88).
A differenza di quanto dice e sostiene ed enfatizza tutta la migliore (e più esemplificata) tradizione romantica e simbolistica, Manescalchi non si sente “in esilio”, non vuole mettere in scena e/o metaforizzare l’albatro di Baudelaire o il fazzoletto sventolato da Mallarmè in chiusura di partita. Si sente con i piedi nella terra (la sua terra di sempre) e si vede a casa a riflettere sulla difficoltà di vivere qui e ora, in quella casa e su quella terra. Il suo posto è quello di sempre e la sua “domesticità” ne è la prova e la sfida insieme. Non vuole essere lo straniero ma il cantore di qualcosa che ancora c’è (a differenza – solo per fare l’esempio opposto – di Pasolini o Luzi).
«Rimani, non c’è niente da spartire, / Ora il tavolo è nudo, nudo il legno. / Si legge il tempo, le sue dure spine, / A nodo a nodo, come in un disegno. / Metti la giacca alla spalliera e siedi, / Anche la gatta tace nel suo regno, / Regno che tu mutissima presiedi. / I fogli sono bianchi nel cassetto, / Alto sui tetti il sole arde Rifredi. / Forse il tempo è compiuto, ma di getto / Un volo di piccioni al cornicione / Scompiglia l’orizzonte ed io rimetto / – Con un gesto improvviso – in discussione / Ogni certezza, l’ultimo copione » (p. 256).
L’invito, dunque, è a restare ancora, di non smettere di resistere e/o di sognare: in bilico, in difficoltà, a cavallo tra il buon Antico e il cattivo Nuovo, ma a rimanere legati alla propria vita e alla propria storia non perché sia la migliore o la più bella di tutte ma perché è pur sempre l’unica che c’è. A pagare i propri debiti e a morire – dice un antico ma strepitoso proverbio della vecchia napoletanità – c’è sempre tempo…
___________________________
[Leggi tutti gli articoli di Giuseppe Panella pubblicati su Retroguardia 2.0]
_____________________________
*Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)



![[Rubrica: Italian Writers Wanted #12]](https://m22.paperblog.com/i/289/2897898/rubrica-italian-writers-wanted-12-L-cIVqIF-175x130.png)


