Fine di un'epoca. Con queste dichiarazioni, l'inventore della realtà virtuale Luis Lanier ha sepolto le ultime speranze dell'economia globale: Internet non è riuscita a portare il benessere economico che aveva promesso. E sembra che ora la festa sia finita.
Ma cos'è che ha rovinato i giochi? C'è che non esiste economia in un mondo dove il produttore e il consumatore sono la stessa persona. L'agricoltura di sussistenza, quella dove si vive solo del proprio orto e si mette da parte l'eccedenza, non genera commercio, non fa girare l'economia. Era così agli albori dell'umanità ed è così anche oggi.
Noi utenti della rete siamo prosumer: consumiamo e produciamo contenuti (post su Facebook, tweet, foto su Instagram) destinati ad altri produttori-consumatori. I nostri click sono diventati merce di scambio. Le persone che ce lo permettono (il sig. Facebook, il sig. Twitter, il sig. Instagram) vendono spazi pubblicitari ad altri prosumer a volumi sempre più alti, ma con ricavi medi sempre più vicini allo zero. Ma se nessuno compra, a che serve la pubblicità? La soluzione a tutti i mali del secolo non è arrivata, o, almeno, la soluzione non è questa Internet dei prosumer.
Siamo diventati pazzi? Come consumatori acclamiamo la gratuità della rete, come lavoratori ci infiammiamo quando, sempre sulla rete, ad essere gratis siamo noi. Progresso e sviluppo hanno smesso di andare d'accordo. Social network e lavoro da tempo non hanno più un buon rapporto.
A preoccupare non sono soltato i 5 milioni di posti di lavoro polverizzati dalla rete. Questi posti non sono eliminati, sono riciclati. La rete toglie, la rete dà. La rete elimina la classe media, la rete crea la classe del lavoratore a gettoni, l'operaio-ingranaggio del crowdsourcing, del lavoro a rubinetto, della gig-economy, l'economia dei lavoretti autonomi e saltuari – che, pensate, prende il nome da un discorso della candidata presidente USA Hilary Clinton. Il lavoratore è stato demansionato fino al livello della sussistenza.
È chiaro che questa situazione non piace a nessuno. Davvero può essere sostenibile, anche solo in minima parte, l'attuale trend che vede, parola di Manpower, la forza lavoro (suo malgrado) sempre più freelance e sempre più flessibile? Davvero si può vivere di micro job trovati con un click? Certo, qualcuno, vendendo servizi, si sta arricchendo, ma presto tutti i suoi consumatori saranno prosumer «connessi e infelici» – e pure poveri – quindi disposti a consumare solo in gratuità. Morte dell'economia, fine di ogni guadagno.
Ma non è detto che vada così. Contro l'ipercapitalismo 2.0 alcuni paletti potrebbero bastare a riequilibrare il gioco di poteri, a tutto vantaggio non solo del prosumer ma anche, come abbiamo visto, di tutto il ciclo dell'economia. Ecco allora tre spunti di riflessione, tre idee che, opportunamente pesate e combinate tra di loro, potrebbero rendere sostenibile un'economia del lavoro "atomizzato".
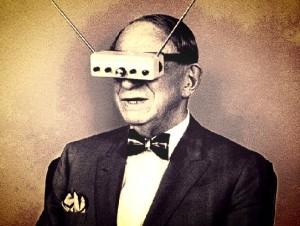
2. Welfare per la persona, a prescindere. Esistono persone costrette a svendersi alla gig-economy per sopravvivere. Quale sistema che ha a cuore la persona può permettersi questo? Abbiamo capito che il fenomeno non è marginale, smettiamo di ignorarlo. L'idea di "reddito di partecipazione" va rispolverata: chi partecipa alla vita della comunità va ricompensato dalla comunità. Non mantenuto, ma compensato: con quel tanto che serve per integrare un reddito da lavoro non sufficiente.
3. Il laboratorio della condizionalità. Tassare non è sempre possibile, così come non è possibile quantificare equamente ed esaustivamente un eventuale reddito di partecipazione. Nell'ambito delle politiche del lavoro si è affermato il concetto di condizionalità: una persona disoccupata viene incentivata e sostentata dal sistema pubblico solo quando si attiva per trovare un lavoro. Il modo per realizzare un buon sistema di condizionalità è abbastanza complesso e coinvolge una pluralità di persone incaricate di ricercare e proporre posizioni di lavoro al soggetto in cerca, il quale, parallelamente, viene monitorato per verificarne l'effettiva attivazione. Spesso, in questo processo la Pubblica Amministrazione si avvale di partnership con soggetti privati. È per il momento il sistema migliore per contenere i costi pubblici della disoccupazione. Ma se questo sistema rinunciasse all'attore pubblico e funzionasse con scambi tra privati? Con "laboratori" di lavoratori autonomi occasionali che finanziano l'erogazione di servizi welfare mentre sono in attesa che un'agenzia trovi loro un lavoro stabile? Sarebbe sostenibile? Sicuramente l'idea è molto astratta e detta così non suggerisce molto. Ma non è affatto inattuale e potrebbe, chi può dirlo, avere degli sviluppi sorprendenti.
Siamo nelle mani della rete, insomma, ma una rete fatta di persone. Bot, software umanizzati, umani robotizzati e piattaforme senza personalità esistono, ma alla fine dei conti è sempre la persona ad essere nodo della rete. Una verità scontata che non possiamo però permetterci di dimenticare.
Simone Caroli
