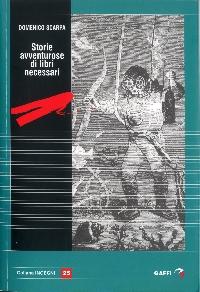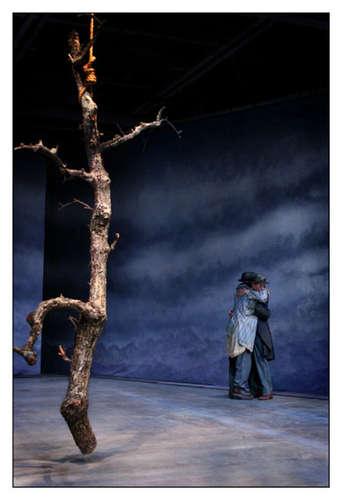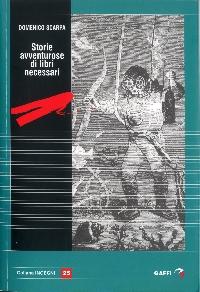
Ci fu un tempo in cui i libri che trattavano di letteratura mi incutevano un sacrosanto terrore. Ogni paragrafo cominciava con una sfilza di numerini puntati che già ti mettevano con le spalle al muro: “Che ti credevi, bellezza? sarà divertente quanto il compito in classe di matematica, o la devitalizzazione di un molare”. Varcata la soglia dei numerini, si entrava nel regno dei quadrati minacciosi; anche le cose più ovvie – tipo che alla fine dei romanzi rosa l’eroina si sposa e il cattivo incorre nella giusta punizione – ti venivano incontro tradotte in una ridda di ascisse e di ordinate, di grafici, di schemi greimassiani e di puntute freccine che mentre cercavi di venirne a capo, ti trapassavano da parte a parte, sostituendo al colpevole “principio del piacere” le austere soddisfazioni della Scienza. Non c’era che una cosa da fare: costruirsi una capanna con i libri dello zio Carlo, di Francesco Orlando, di Giacomo Debenedetti, e lì sotto aspettare quatti quatti che passasse ‘a nuttata, leggendo e rileggendo Auerbach e il Passagenwerk, Sklovski e René Girard, i Benandanti e – soprattutto – Spie, in attesa di tempi migliori. La certezza che c’era nel sole, per dirla con l’Aquilone, qualcosa di nuovo, a me arrivò con i saggi di Antoine Compagnon su Lanson, su Thibaudet, su Brunetière, e con le sue riflessioni su meriti, demeriti e limiti della teoria letteraria. Nelle pagine di Compagnon, quel colpevolissimo piacere del racconto che Barthes si concedeva – come il bicchierino clandestino del cardiopatico – sfogliando
I tre moschettieri prima di addormentarsi, riconquistava il diritto di cittadinanza sul terreno, sino ad allora vietato, degli studi letterari. Lettura e narrazione critica ritrovavano una complicità lungamente bandita e la strada aperta dai grandi Romanzi Critici del passato recente – dagli Oggetti Desueti di Orlando, dalle Antigoni di Steiner, dai saggi di Lavagetto sulla menzogna o da quelli di Moretti sulle Opere Mondo, per citarne soltanto alcuni – diventava praticabile e familiare. Era ormai permesso, al critico-narratore, raccontare i suoi accidentati percorsi tra Storia e storie, generi e sottogeneri, indizi e formazioni di compromesso; e il racconto delle sue vicissitudini trovava un pubblico appassionatamente attento, come quello di Ulisse o di Sherazahade. Un pubblico per cui la letteratura era, sulle tracce di Stevenson, anche avventura e felicità; e perché, se lo era la letteratura, non avrebbe potuto esserlo anche la critica?
Non credo sia dunque un caso che proprio con un saggio di Stevenson si apra questa splendida raccolta di “racconti critici” di Domenico Scarpa (Gaffi Editore), giustamente intitolata Storie avventurose di libri necessari. La presenza di Stevenson nel novecento italiano si rivela, all’attenta perlustrazione di Scarpa, tanto segreta quanto decisiva: da Cecchi a Manganelli, da Parise a Calvino, da Sciascia a Michele Mari, è una traccia sotterranea carica di significato, che evidenzia la presenza, nell’Italia del secolo passato, di un fermento di ambiguità e di ludica leggerezza troppo spesso invisibile alle storie letterarie “ufficiali”. Ma è proprio quel che sfugge ad ogni storia ufficiale e ortodossa, ligia alle gerarchie di un canone un po’ fossilizzato e alle idées reçues della doxa dominante, il territorio privilegiato di Domenico Scarpa. I suoi microromanzi critici investono questioni apparentemente marginali – la fortuna di Alvaro sotto il fascismo, le disavventure critiche di Domenico Rea – mettendone in luce, attraverso una fittissima rete di nessi culturali, ideologici, psicologici, l’importanza storica ineludibile. Come il romanzo per Georges Perec, la storia letteraria è per Domenico Scarpa un puzzle narrativo di cui nessun pezzo, per quanto piccolo o monocromo, può dirsi inessenziale o ininteressante; e proprio come Perec, è anche grazie al suo dono per il racconto che Scarpa ci persuade della validità di questa prospettiva, di questa visione.
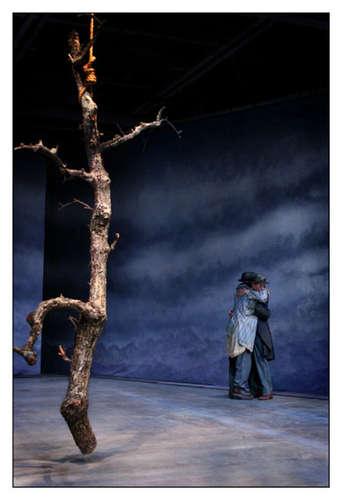
Tra i pezzi del puzzle, naturalmente, ogni lettore avrà i suoi preferiti: a seconda che gli interessino di più Meneghello o Parise, Manganelli o Fruttero e Lucentini, Bassani o Primo Levi. Le mie predilezioni vanno innanzitutto alle pagine straordinarie del
Lapidario estense, che seguendo le labili tracce dell’ebraismo nella narrativa di Bassani, esplorano il rapporto dello scrittore con la morte e con i morti, ritagliano il giusto spazio all’influenza della filosofia di Benedetto Croce, per approdare a una riflessione, tra le più illuminanti, sul “grigio” della lingua del romanziere di Ferrara. Ma va molto a fondo, e in una direzione davvero imprevista, anche
Oscuro/Chiaro. Giorgio Manganelli vs Primo Levi, che partendo dalle opposte poetiche di Manganelli e di Levi, identifica tra loro invisibili linee di convergenza. Scrittori entrambi “discesi agli inferi”, a livello esplicito compiono scelte opposte: Levi adotta il piano linguaggio referenziale del testimone, Manganelli dissimula “il suo nitore da solido platonico sotto un’amazzonia lessicale e sintattica”. Una breve polemica li contrappone sulle pagine dei quotidiani, nel 1976. È il punto di partenza di un lungo scavo di Scarpa che approda ad alcuni punti nodali della loro opera, del loro pensiero. Alla fine, il programmaticamente chiaro Levi, alla luce di una definizione dell’ebraismo formulata da Manganelli, assume nuove connotazioni: “Manganelli sostiene che essere ebreo vuol dire avere confidenza con l’oscuro: è un’angolatura dell’anima; come se gli ebrei guardassero da un’altra parte, verso cose che non osiamo guardare. Poco importa che l’ebreo sia laico, ateo e si pensi occidentale”. Basta aggiungere qui le parole: e faccia professione di razionalismo per avere il ritratto di Primo Levi. Per il solo fatto di essere ebreo e di aver trascorso un anno in Auschwitz, Levi è un oscuro ad honorem: “L’ebreo deve, è costretto, e insieme gli è naturale, misurarsi con le tenebre, giacché da millenni è l’oggetto privilegiato dell’ombra, il buio interiore dell’Occidente che lo investe”.
Posti l’uno a fronte dell’altro, indagati sottilmente nei nessi tra espressione letteraria ed esperienza vissuta, Manganelli e Primo Levi in queste pagine si svelano e si illuminano reciprocamente, tra l’opacità di alcuni silenzi voluti e il sussultare di una “tenerezza buia e maciullata” davanti all’indicibile, all’informe della sofferenza umana. Tra i piccoli romanzi critici costruiti da Scarpa – ciascuno con un suo ritmo necessario, e le sue immodificabili “svolte del respiro” – è questo, forse, in definitiva, il mio prediletto. Ma quello che ha per personaggi il giovane Lucentini, Nino Franck, grande traduttore sconosciuto, e uno stralunato Beckett che, in preda a una crescente ebbrezza alcoolica, vagabonda per la banlieue parigina, è certamente il più esilarante. Disegna, sullo sfondo del nostro novecento, la fortuna italiana di En attendant Godot: un’immagine necessaria se mai ce ne furono, tracciata qui dal critico Scarpa con consumata perizia di narratore e con quella felice levità stevensoniana che, riconducendoci al primo saggio, chiude il cerchio rigoroso e affascinante di questo libro avventuroso.

Mariolina Bertini insegna Letteratura francese all’Università di Parma. Ha curato edizioni delle principali opere proustiane per Einaudi, Bollati Boringhieri, Suhrkamp e in collaborazione con Luzius Keller. Ha curato un’edizione di prefazioni e altri scritti teorici di Balzac e cura per i Meridiani Mondadori un’ampia scelta della Commedia umana il cui primo volume è uscito nel 1994 e il secondo nel 2005. É vicedirettore della rivista L’Indice. Questa recensione è apparsa sulla pagina di Anobii dedicata al libro di Domenico Scarpa.