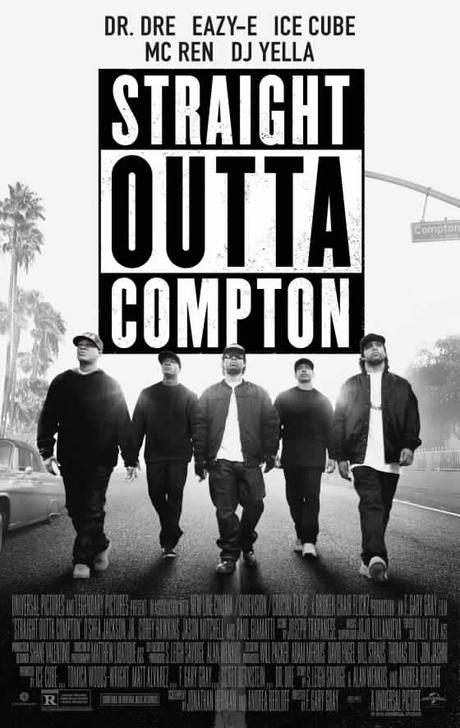 Nella
complessa struttura che compone la società americana, tutto sembra mosso da
infinite contraddizioni - storiche, politiche, culturali – che ne evidenziano l’estremo
paradosso. In questa applicazione solerte dell’antinomia che nutre il progredire degli U.S.A., posando la lente d’ingrandimento
sul periodo a cavallo tra il termine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, non si
può non prestare attenzione a ciò che gli N.W.A. - i cui componenti sono i
padri del gangsta rap: la sigla/nome
del gruppo, per dirne una, per esteso suonerebbe “Niggaz With Attitudes” - hanno
rappresentato in quel momento storico ancor prima che musicale.
“Straight
outta compton”, titolo del loro album più famoso, ha quindi come intento quello
di individuare i punti chiave che hanno portato i ragazzi negri della west coast a porre il rap come un mezzo
neo-realista per riportare e descriverne la vita di strada all’insegna di
micro-criminalità e tutto ciò che ne consegue; non a caso uno dei brani più
famosi è intitolato “Fuck tha police”: soffermandosi più volte infatti sulla
violenza usata dagli agenti (in particolar modo quelli losangelini) nei
confronti della comunità nera, il film segnala come gli States abbiano affrontato
in malomodo, tra le tante, la questione blackness (ne abbiamo testimonianza
anche nel recentissimo, per realizzazione ed ambientazione, “Fruitvale Station”).
Se è dunque ottima la perspicacia e la collocazione dell’opera, la durata –
oltre due ore – non è sfruttata per approfondire i personaggi, che restano stereotipati
nella narrazione trita e ritrita dell’ascesa/discesa
traducibile in scalata-al-successo/decadenza, mentre restano interessanti
alcune scelte di regia, in particolare i piano-sequenza che spesso seguono di
spalle l’andare dei protagonisti e, ovviamente, le scelte musicali.
L’importanza
di “Straight outta compton” è, in primo luogo, al di là delle pecche
prettamente filmiche, di mostrare gli artisti hip-hop come una tra le tante voci
provenienti dall’abisso del degrado americano; secondariamente - si veda, ad
esempio, la quasi totalità della scena rap italiana - di mostrare la miopia e
la superficialità con la quale quell’arte è stata trascinata al di fuori del
proprio contesto culturale e, di conseguenza, totalmente annullata.
Antonio Romagnoli
Nella
complessa struttura che compone la società americana, tutto sembra mosso da
infinite contraddizioni - storiche, politiche, culturali – che ne evidenziano l’estremo
paradosso. In questa applicazione solerte dell’antinomia che nutre il progredire degli U.S.A., posando la lente d’ingrandimento
sul periodo a cavallo tra il termine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, non si
può non prestare attenzione a ciò che gli N.W.A. - i cui componenti sono i
padri del gangsta rap: la sigla/nome
del gruppo, per dirne una, per esteso suonerebbe “Niggaz With Attitudes” - hanno
rappresentato in quel momento storico ancor prima che musicale.
“Straight
outta compton”, titolo del loro album più famoso, ha quindi come intento quello
di individuare i punti chiave che hanno portato i ragazzi negri della west coast a porre il rap come un mezzo
neo-realista per riportare e descriverne la vita di strada all’insegna di
micro-criminalità e tutto ciò che ne consegue; non a caso uno dei brani più
famosi è intitolato “Fuck tha police”: soffermandosi più volte infatti sulla
violenza usata dagli agenti (in particolar modo quelli losangelini) nei
confronti della comunità nera, il film segnala come gli States abbiano affrontato
in malomodo, tra le tante, la questione blackness (ne abbiamo testimonianza
anche nel recentissimo, per realizzazione ed ambientazione, “Fruitvale Station”).
Se è dunque ottima la perspicacia e la collocazione dell’opera, la durata –
oltre due ore – non è sfruttata per approfondire i personaggi, che restano stereotipati
nella narrazione trita e ritrita dell’ascesa/discesa
traducibile in scalata-al-successo/decadenza, mentre restano interessanti
alcune scelte di regia, in particolare i piano-sequenza che spesso seguono di
spalle l’andare dei protagonisti e, ovviamente, le scelte musicali.
L’importanza
di “Straight outta compton” è, in primo luogo, al di là delle pecche
prettamente filmiche, di mostrare gli artisti hip-hop come una tra le tante voci
provenienti dall’abisso del degrado americano; secondariamente - si veda, ad
esempio, la quasi totalità della scena rap italiana - di mostrare la miopia e
la superficialità con la quale quell’arte è stata trascinata al di fuori del
proprio contesto culturale e, di conseguenza, totalmente annullata.
Antonio Romagnoli
Magazine Cinema
Straight Outta Compton
di F. Gary Gray
con Paul Giamatti, Neil Brown, Jr., Aldis Hodge, Jason Mitchell, Corey Hawkins
Usa, 2015
genere, biografico, drammatico, musicale
durata, 147'
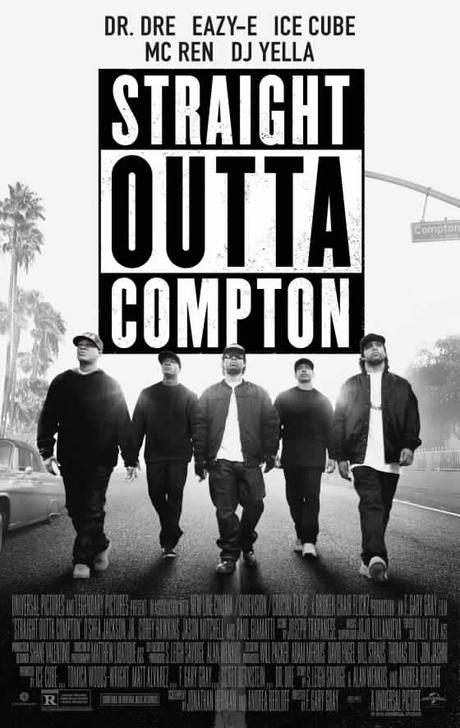 Nella
complessa struttura che compone la società americana, tutto sembra mosso da
infinite contraddizioni - storiche, politiche, culturali – che ne evidenziano l’estremo
paradosso. In questa applicazione solerte dell’antinomia che nutre il progredire degli U.S.A., posando la lente d’ingrandimento
sul periodo a cavallo tra il termine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, non si
può non prestare attenzione a ciò che gli N.W.A. - i cui componenti sono i
padri del gangsta rap: la sigla/nome
del gruppo, per dirne una, per esteso suonerebbe “Niggaz With Attitudes” - hanno
rappresentato in quel momento storico ancor prima che musicale.
“Straight
outta compton”, titolo del loro album più famoso, ha quindi come intento quello
di individuare i punti chiave che hanno portato i ragazzi negri della west coast a porre il rap come un mezzo
neo-realista per riportare e descriverne la vita di strada all’insegna di
micro-criminalità e tutto ciò che ne consegue; non a caso uno dei brani più
famosi è intitolato “Fuck tha police”: soffermandosi più volte infatti sulla
violenza usata dagli agenti (in particolar modo quelli losangelini) nei
confronti della comunità nera, il film segnala come gli States abbiano affrontato
in malomodo, tra le tante, la questione blackness (ne abbiamo testimonianza
anche nel recentissimo, per realizzazione ed ambientazione, “Fruitvale Station”).
Se è dunque ottima la perspicacia e la collocazione dell’opera, la durata –
oltre due ore – non è sfruttata per approfondire i personaggi, che restano stereotipati
nella narrazione trita e ritrita dell’ascesa/discesa
traducibile in scalata-al-successo/decadenza, mentre restano interessanti
alcune scelte di regia, in particolare i piano-sequenza che spesso seguono di
spalle l’andare dei protagonisti e, ovviamente, le scelte musicali.
L’importanza
di “Straight outta compton” è, in primo luogo, al di là delle pecche
prettamente filmiche, di mostrare gli artisti hip-hop come una tra le tante voci
provenienti dall’abisso del degrado americano; secondariamente - si veda, ad
esempio, la quasi totalità della scena rap italiana - di mostrare la miopia e
la superficialità con la quale quell’arte è stata trascinata al di fuori del
proprio contesto culturale e, di conseguenza, totalmente annullata.
Antonio Romagnoli
Nella
complessa struttura che compone la società americana, tutto sembra mosso da
infinite contraddizioni - storiche, politiche, culturali – che ne evidenziano l’estremo
paradosso. In questa applicazione solerte dell’antinomia che nutre il progredire degli U.S.A., posando la lente d’ingrandimento
sul periodo a cavallo tra il termine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, non si
può non prestare attenzione a ciò che gli N.W.A. - i cui componenti sono i
padri del gangsta rap: la sigla/nome
del gruppo, per dirne una, per esteso suonerebbe “Niggaz With Attitudes” - hanno
rappresentato in quel momento storico ancor prima che musicale.
“Straight
outta compton”, titolo del loro album più famoso, ha quindi come intento quello
di individuare i punti chiave che hanno portato i ragazzi negri della west coast a porre il rap come un mezzo
neo-realista per riportare e descriverne la vita di strada all’insegna di
micro-criminalità e tutto ciò che ne consegue; non a caso uno dei brani più
famosi è intitolato “Fuck tha police”: soffermandosi più volte infatti sulla
violenza usata dagli agenti (in particolar modo quelli losangelini) nei
confronti della comunità nera, il film segnala come gli States abbiano affrontato
in malomodo, tra le tante, la questione blackness (ne abbiamo testimonianza
anche nel recentissimo, per realizzazione ed ambientazione, “Fruitvale Station”).
Se è dunque ottima la perspicacia e la collocazione dell’opera, la durata –
oltre due ore – non è sfruttata per approfondire i personaggi, che restano stereotipati
nella narrazione trita e ritrita dell’ascesa/discesa
traducibile in scalata-al-successo/decadenza, mentre restano interessanti
alcune scelte di regia, in particolare i piano-sequenza che spesso seguono di
spalle l’andare dei protagonisti e, ovviamente, le scelte musicali.
L’importanza
di “Straight outta compton” è, in primo luogo, al di là delle pecche
prettamente filmiche, di mostrare gli artisti hip-hop come una tra le tante voci
provenienti dall’abisso del degrado americano; secondariamente - si veda, ad
esempio, la quasi totalità della scena rap italiana - di mostrare la miopia e
la superficialità con la quale quell’arte è stata trascinata al di fuori del
proprio contesto culturale e, di conseguenza, totalmente annullata.
Antonio Romagnoli
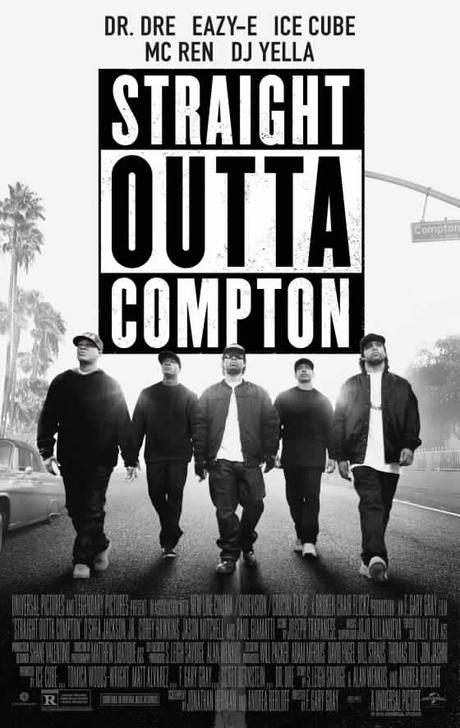 Nella
complessa struttura che compone la società americana, tutto sembra mosso da
infinite contraddizioni - storiche, politiche, culturali – che ne evidenziano l’estremo
paradosso. In questa applicazione solerte dell’antinomia che nutre il progredire degli U.S.A., posando la lente d’ingrandimento
sul periodo a cavallo tra il termine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, non si
può non prestare attenzione a ciò che gli N.W.A. - i cui componenti sono i
padri del gangsta rap: la sigla/nome
del gruppo, per dirne una, per esteso suonerebbe “Niggaz With Attitudes” - hanno
rappresentato in quel momento storico ancor prima che musicale.
“Straight
outta compton”, titolo del loro album più famoso, ha quindi come intento quello
di individuare i punti chiave che hanno portato i ragazzi negri della west coast a porre il rap come un mezzo
neo-realista per riportare e descriverne la vita di strada all’insegna di
micro-criminalità e tutto ciò che ne consegue; non a caso uno dei brani più
famosi è intitolato “Fuck tha police”: soffermandosi più volte infatti sulla
violenza usata dagli agenti (in particolar modo quelli losangelini) nei
confronti della comunità nera, il film segnala come gli States abbiano affrontato
in malomodo, tra le tante, la questione blackness (ne abbiamo testimonianza
anche nel recentissimo, per realizzazione ed ambientazione, “Fruitvale Station”).
Se è dunque ottima la perspicacia e la collocazione dell’opera, la durata –
oltre due ore – non è sfruttata per approfondire i personaggi, che restano stereotipati
nella narrazione trita e ritrita dell’ascesa/discesa
traducibile in scalata-al-successo/decadenza, mentre restano interessanti
alcune scelte di regia, in particolare i piano-sequenza che spesso seguono di
spalle l’andare dei protagonisti e, ovviamente, le scelte musicali.
L’importanza
di “Straight outta compton” è, in primo luogo, al di là delle pecche
prettamente filmiche, di mostrare gli artisti hip-hop come una tra le tante voci
provenienti dall’abisso del degrado americano; secondariamente - si veda, ad
esempio, la quasi totalità della scena rap italiana - di mostrare la miopia e
la superficialità con la quale quell’arte è stata trascinata al di fuori del
proprio contesto culturale e, di conseguenza, totalmente annullata.
Antonio Romagnoli
Nella
complessa struttura che compone la società americana, tutto sembra mosso da
infinite contraddizioni - storiche, politiche, culturali – che ne evidenziano l’estremo
paradosso. In questa applicazione solerte dell’antinomia che nutre il progredire degli U.S.A., posando la lente d’ingrandimento
sul periodo a cavallo tra il termine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, non si
può non prestare attenzione a ciò che gli N.W.A. - i cui componenti sono i
padri del gangsta rap: la sigla/nome
del gruppo, per dirne una, per esteso suonerebbe “Niggaz With Attitudes” - hanno
rappresentato in quel momento storico ancor prima che musicale.
“Straight
outta compton”, titolo del loro album più famoso, ha quindi come intento quello
di individuare i punti chiave che hanno portato i ragazzi negri della west coast a porre il rap come un mezzo
neo-realista per riportare e descriverne la vita di strada all’insegna di
micro-criminalità e tutto ciò che ne consegue; non a caso uno dei brani più
famosi è intitolato “Fuck tha police”: soffermandosi più volte infatti sulla
violenza usata dagli agenti (in particolar modo quelli losangelini) nei
confronti della comunità nera, il film segnala come gli States abbiano affrontato
in malomodo, tra le tante, la questione blackness (ne abbiamo testimonianza
anche nel recentissimo, per realizzazione ed ambientazione, “Fruitvale Station”).
Se è dunque ottima la perspicacia e la collocazione dell’opera, la durata –
oltre due ore – non è sfruttata per approfondire i personaggi, che restano stereotipati
nella narrazione trita e ritrita dell’ascesa/discesa
traducibile in scalata-al-successo/decadenza, mentre restano interessanti
alcune scelte di regia, in particolare i piano-sequenza che spesso seguono di
spalle l’andare dei protagonisti e, ovviamente, le scelte musicali.
L’importanza
di “Straight outta compton” è, in primo luogo, al di là delle pecche
prettamente filmiche, di mostrare gli artisti hip-hop come una tra le tante voci
provenienti dall’abisso del degrado americano; secondariamente - si veda, ad
esempio, la quasi totalità della scena rap italiana - di mostrare la miopia e
la superficialità con la quale quell’arte è stata trascinata al di fuori del
proprio contesto culturale e, di conseguenza, totalmente annullata.
Antonio Romagnoli

