di Michele Marsonet. Nel dibattito scientifico e filosofico degli ultimi decenni ha avuto un grande peso la distinzione tra “scienza normale” e “scienza straordinaria”, utilizzata soprattutto da Thomas Kuhn nella sua celebre opera “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”. La prima si sviluppa attraverso la routine quotidiana del ricercatore, la seconda scorge nelle situazioni di crisi l’occasione per superare teorie obsolete e arrivare così a nuovi punti di equilibrio. La scienza normale, in altri termini, è l’attività dello studioso non rivoluzionario e poco critico, del cultore di discipline scientifiche che accetta il dogma predominante del suo tempo. Egli adotta una nuova teoria rivoluzionaria solo se quasi tutti gli altri sono pronti ad accettarla, se diventa moda per una sorta di travolgente consenso universale.
E’ possibile riprodurre tale schema nell’ambito del pensiero politico? Entro certi limiti sì, e ritengo che un autore come Carl Schmitt possa costituire un buon esempio in questo senso. Schmitt non è un personaggio facilmente “vendibile”. Com’è noto la sua carriera è viziata da un peccato capitale: la compromissione – per quanto limitata nel tempo – con il regime nazista. Studioso di formazione cattolico-conservatrice, Schmitt commette un errore che ai posteri appare imperdonabile: il 1° maggio 1933 si iscrive al partito nazionalsocialista, unica forza che, a suo parere, può salvare la Germania dal caos.
Assume in seguito un ruolo di grande rilievo nell’ambito legislativo del Terzo Reich, ma già alla fine del 1936 abbandona ogni incarico pubblico a seguito di un pesante attacco rivoltogli dal settimanale delle SS “Das schwarze Korps” che lo accusava, in sostanza, di essere un opportunista cattolico e un falso anti-semita. Lo salva Hermann Göring che impedisce il suo allontanamento dalla cattedra universitaria. A differenza di altri intellettuali tedeschi non abbandona il Paese e preferisce attendere in patria l’apocalisse del 1945. Non sono tuttavia sufficienti alcuni anni di adesione al nazismo per seppellire nell’anonimato un pensatore tra i più originali e creativi che la cultura politica del secolo scorso abbia prodotto e, sia in Italia che altrove, numerosi intellettuali continuano ad analizzarne l’opera.
La costruzione teorica di Schmitt è estremamente complessa, ma vi sono dei capisaldi da cui è possibile partire per tracciare una sintesi esplicativa. Il giurista e filosofo tedesco eredita dagli esponenti del cattolicesimo controrivoluzionario una visione pessimistica e critica della natura umana. Da un altro dei suoi ispiratori, Thomas Hobbes, egli mutua la convinzione che l’uomo sia fondamentalmente aggressivo e che il popolo vada guidato con mano ferma. Già queste brevi considerazioni ci consentono di porre Schmitt in aperta opposizione alla filosofia politica liberale. Ma, per comprendere appieno il suo pensiero, occorre collocarlo in una ben precisa cornice storica: quella della repubblica di Weimar, sorta sulle rovine della sconfitta subita dalla Germania nel primo conflitto mondiale.
Questo riferimento è, ai miei fini, di estrema importanza. Schmitt, infatti, aderisce alla visione secondo cui la storia è un processo continuamente mutevole; di qui la constatazione che “una verità storica è vera una volta sola”. A differenza di Hegel, non si trovano nei suoi scritti riferimenti a un preteso scopo finale della storia. Ne consegue che egli è interessato, in maniera pressoché esclusiva, a situazioni concrete, a problemi cui prende parte personalmente e ai quali è legato il suo destino.
Entro il quadro politico della repubblica di Weimar, sconvolta da crisi ricorrenti e dalla presenza di partiti che si proclamavano apertamente anti-sistema, va collocata una delle definizioni più celebri del giurista tedesco: “Sovrano è chi decide dello stato di eccezione”. Per ristabilire l’ordine e la pace il sovrano può, dopo aver proclamato lo stato d’eccezione, prescindere dal sistema costituzionale vigente in condizioni ordinarie. Ecco quindi l’aggancio con la distinzione tra scienza “normale” e “straordinaria” cui accennavo all’inizio. A Schmitt, coinvolto personalmente nelle vicende tumultuose della repubblica di Weimar, la routine non interessa. Ciò che gli preme è, invece, dotare l’autorità politica degli strumenti necessari a fronteggiare la sfida dell’eccezione. E, per far questo, occorre decidere senza condizionamento alcuno al di fuori del bene dello Stato. E’ importante rilevare, a tale proposito, che fu proprio Schmitt a coniare un termine poi destinato ad avere grande fortuna: “decisionismo”.
Usandolo egli intendeva sottolineare, al pari di Hobbes, che “auctoritas, non veritas, facit legem”. Chi ha autorità – che con il potere è associata – può fare le leggi. Il sovrano, in forza dell’autorità di cui dispone, può anche pretendere obbedienza. Ma non è sempre il sovrano legittimo a detenere l’autorità. Ne deriva che il sovrano incapace di fornire protezione non ha il diritto di esigere obbedienza. Infatti Schmitt non si stanca di citare la relazione hobbesiana di reciprocità tra potere e obbedienza.
Al problema del decisionismo è strettamente connessa la concezione schmittiana della politica, intesa come sfera dominata dalla necessità di “distinguere l’amico dal nemico”. Tale polarità vale sia sul piano internazionale sia su quello interno. Se chi detiene il potere non è in grado di riconoscere gli amici dai nemici, lo Stato soccombe alla società civile rinunciando a porsi al servizio dell’intera nazione anziché di qualche sua parte. A livello internazionale, se uno Stato non riesce in un momento cruciale a distinguere l’amico dal nemico, allora cessa di esistere nella sfera politica e ci sarà sempre un altro Stato che si assumerà questo compito. E’ quindi il protettore a determinare chi è il nemico, secondo la perpetua connessione fra protezione e obbedienza.
Mette conto notare che tale analisi – nella sua lucida crudezza – può essere applicata alle relazioni internazionali nel mondo contemporaneo. In un’alleanza politico-militare dominata da un Paese egemone, sarà sempre quest’ultimo a decidere chi è il nemico da combattere, mentre le nazioni meno importanti, che ottengono protezione in cambio di obbedienza, non avranno voce in capitolo nelle scelte strategiche fondamentali.
Di particolare interesse è la riflessione che Schmitt dedica al sistema partitico nella repubblica di Weimar. Rilevando come la natura dei partiti tedeschi si fosse rapidamente modificata, egli scrive: “Erano sempre più ristrette commissioni di partito o di coalizioni di partiti a decidere dietro porte chiuse il destino di milioni di persone. I partiti politici, non più direttamente impegnati nella discussione, appaiono ora come gruppi di potere economico e sociale che si fronteggiano calcolando gli interessi e le opportunità in termini di potere, per poi decidere su compromessi e coalizioni. La rigida coesione partitica determinata dai vincoli di fedeltà che legano gli eletti al partito rendono le procedure pubbliche simili a una farsa, dato che le decisioni importanti vengono prese dietro porte chiuse. Le decisioni essenziali si prendono fuori dal Parlamento”.
Tutti sanno come si sia voluto paragonare – spesso a sproposito – il nostro sistema politico a quello di Weimar. Ebbene, le considerazioni appena citate suonano stranamente familiari al lettore italiano. In esse è rintracciabile, senza modificazioni di sostanza, la critica che nel nostro Paese viene rivolta allo strapotere delle segreterie dei partiti nei confronti del Parlamento.
Quanto alla sua adesione al nazismo, indubbiamente Schmitt ritenne che la fine della repubblica di Weimar costituisse un caso paradigmatico di quello che definiva “stato di eccezione”, e che Hitler fosse l’unico in grado di restituire una leadership a un sistema politico in coma. Errore grave, ovviamente, che non può tuttavia mettere in ombra il suo prezioso contributo alla chiarificazione fondamentale del concetto di “politico”. Del resto, in Italia hanno messo in luce la sua genialità tanto studiosi conservatori come Gianfranco Miglio quanto marxisti non ortodossi quali Mario Tronti.
Il fatto che riconoscimenti gli giungano in pari misura da intellettuali che si collocano ai lati opposti dello spettro politico testimonia che il giurista e filosofo tedesco è un grande, ed è prevedibile che la sua fama sia destinata ad aumentare con il trascorrere del tempo. Ma Schmitt può fornire utili spunti anche a pensatori di scuola liberal-democratica. Per apprezzare un autore originale, infatti, non è necessario condividerne tesi e ispirazione.
Featured image, testata della Deutsche Juristen-Zeitung, fonte Wikipedia.
 di Michele Marsonet. Nel dibattito scientifico e filosofico degli ultimi decenni ha avuto un grande peso la distinzione tra “scienza normale” e “scienza straordinaria”, utilizzata soprattutto da Thomas Kuhn nella sua celebre opera “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”. La prima si sviluppa attraverso la routine quotidiana del ricercatore, la seconda scorge nelle situazioni di crisi l’occasione per superare teorie obsolete e arrivare così a nuovi punti di equilibrio. La scienza normale, in altri termini, è l’attività dello studioso non rivoluzionario e poco critico, del cultore di discipline scientifiche che accetta il dogma predominante del suo tempo. Egli adotta una nuova teoria rivoluzionaria solo se quasi tutti gli altri sono pronti ad accettarla, se diventa moda per una sorta di travolgente consenso universale.
di Michele Marsonet. Nel dibattito scientifico e filosofico degli ultimi decenni ha avuto un grande peso la distinzione tra “scienza normale” e “scienza straordinaria”, utilizzata soprattutto da Thomas Kuhn nella sua celebre opera “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”. La prima si sviluppa attraverso la routine quotidiana del ricercatore, la seconda scorge nelle situazioni di crisi l’occasione per superare teorie obsolete e arrivare così a nuovi punti di equilibrio. La scienza normale, in altri termini, è l’attività dello studioso non rivoluzionario e poco critico, del cultore di discipline scientifiche che accetta il dogma predominante del suo tempo. Egli adotta una nuova teoria rivoluzionaria solo se quasi tutti gli altri sono pronti ad accettarla, se diventa moda per una sorta di travolgente consenso universale.
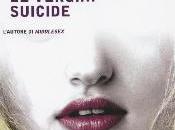

![[Focus On]: OCULUS.IL RIFLESSO MALE (Movie)](https://m21.paperblog.com/i/289/2894186/focus-on-oculusil-riflesso-del-male-movie-L-zfe1eo-175x130.jpeg)



