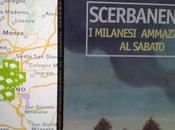di Cristiano Abbadessa
Si è conclusa ieri la seconda edizione del Festival Letteratura Milano. Esperienza piena e spesso esaltante, ma anche faticosa, assorbente, impietosa nel non lasciare spazio e tempo per altre occupazioni, o quasi. A questo, al grande lavoro festivaliero unito alla necessità di portare avanti almeno l’indispensabile quotidiano, si deve fra l’altro il lungo silenzio su queste pagine (e non è che mancassero le cose da dire).
Approfitto della fresca chiusura per ricapitolare alcune sensazioni, maturate soprattutto nel ruolo di editore-partner e organizzatore di eventi, che scaturiscono dall’inevitabile paragone con l’edizione 2012, e per abbozzare una considerazione che sarà tema di future riflessioni collettive.
Sono temi che ho già brevemente affrontato durante la festa di chiusura, e quindi non nuovi per chi era presente. Li estendo però a tutti, visto anche che, complici i ripetuti temporali, la festa ha avuto meno partecipanti del previsto e varie defezioni dell’ultima ora.

Lo dico pensando agli eventi organizzati e a quelli in cui ho fatto da spettatore. L’anno passato capitavano anche (e non di rado) appuntamenti con una decina di persone; poi c’erano quelli, già soddisfacenti, con 20-30 presenti, infine gli eventi di richiamo, capaci di attrarre pubblico nell’ordine delle centinaia. Stavolta, quando andava male, la ventina di persone a contorno si raggiungeva sempre; ma più spesso si contavano 40-50 presenti, forse più se si considerano le rotazioni che si sono spesso verificate.
Numeri ottimi, pensando anche che gli eventi erano il doppio rispetto al 2012 e che aumentava quindi il rischio della dispersione, uno dei forti dubbi della vigilia. Che, invece, direi proprio che non c’è stata.
Altra grande soddisfazione è stata la scoperta di nuovi luoghi, che si sono trasformati in teatri stabili del festival o che ci hanno aperto le porte per eventi circoscritti ma molto seguiti.
Ho registrato, proprio a partire dalle iniziative promosse da Autodafé, la passione con cui tanti gestori di locali hanno fortemente voluto portare la cultura nei luoghi del divertimento, impegnandosi a fondo (anche nella promozione, nell’allestimento degli spazi, nella soluzione dei problemi tecnici, nella passione con cui hanno scelto gli artisti) per la riuscita dell’evento. Un patrimonio prezioso, che è ben deciso a lavorare con la realtà del festival, e non in forma occasionale, per portare le varie forme artistiche e culturali a un publico vasto, per elevare la qualità del tempo libero, per far sposare la cultura alla convivialità e all’incontro.
Ma è stato notevole anche l’impatto di luoghi pubblici (nel senso della proprietà) che sono o potrebbero essere forti riferimenti per la vita dei quartieri e che sono stati finora poco utilizzati, lasciati in stato di abbandono. Esemplare il caso della Fornace (ma non è l’unico, sia chiaro): uno spazio che ha una connessione storica con un quartiere vissuto e culturalmente vivace come il Ticinese, ma che fino al festival aveva ricevuto solo il maquillage di una ristrutturazione, senza però prendere vita all’interno. Milano pullula di luoghi di questo tipo, di aree dismesse, di riconversioni lasciate a metà; e, tra i cittadini che vivono attorno a questi luoghi, la richiesta di cultura è fortissima.
Ulteriore elemento di successo (e qui l’esperienza ha consentito agli organizzatori un cambio di marcia davvero notevole) è stata la capacità di abbinare gli eventi (e i personaggi) ai luoghi adatti. L’anno scorso c’era stato il caso, indicativo, di un evento saltato perché la presentazione del libro di un personaggio molto noto, di sicuro spessore e impatto, era finita in una collocazione anonima e sradicata; stavolta si è avuta spesso la sensazione che l’offerta culturale del festival fosse in precisa sintonia con una domanda che proveniva da quel territorio, da quel luogo, da quello spazio, da quella comunità che ci ospitava.
Spendo due parole in più sull’argomento, perché ho sentito voci discordanti che affermano come uno degli scopi del festival sia anche portare la cultura laddove uno non se l’aspetta. Suggestivo e in parte vero, se parliamo di uno spazio aperto, di transito, magari insolito, dove il pubblico sceglie se accettare la proposta o rifiutarla (mi viene di nuovo in mente la Fornace, con il concerto di musica medievale a porte aperte, le note capaci di insinuarsi nello struscio serale lungo il Naviglio, la gente che passa e si avvicina, alcuni che buttano l’occhio e girano subito i tacchi, molti che si fermano per un po’ prima di andarsene, altri che entrano e si siedono scoprendo qualcosa di nuovo e un modo imprevisto di passare la serata). Molto meno convincente se parliamo di locali, di spazi chiusi e di luoghi privati con una loro precisa e consolidata connotazione; perché è inutile e dannoso cercare di fare un dibattito articolato in un pub dove la gente si accalca al bancone del bar e al buffet, sciama tra i tavoli, si siede per conversare, esprime un brusio che presto si trasforma in un vociare. In questo modo non si fa altro che infastidirsi gli uni con gli altri.
Ampliare la proposta culturale non deve mai diventare l’imposizione dell’evento culturale. E poiché, come ho detto, la disponibilità di spazi e la richiesta di eventi culturali mi sembrano davvero molto diffuse, non credo sia il caso di lanciarsi in sfide troppo azzardate e controproducenti.
La considerazione finale viene come conseguenza di quello che è stato un successo. Un festival davvero dai numeri impressionanti, con 180 eventi in cinque giorni. E, di conseguenza, una manifestazione che richiede un enorme sforzo organizzativo. Forse eccessivo.
Non mi riferisco tanto ai giorni del festival, dove l’apporto entusiasta e a tempo pieno dei volontari permette di gestire la mole di lavoro anche senza essere ubiqui. E, in ogni caso, ciascuno di noi ha dato per scontato (avendo, faccio il mio caso che vale per altri, quattro eventi da ideare e condurre, altri da presentare, altri da vedere per il gusto di essere anche parte del pubblico) che durante la settimana del festival non avrebbe fatto altro e si sarebbe messo in ferie dalle occupazioni abituali.
È però vero, e lo dico ancora da editore di Autodafé, co-organizzatore del festival, che nei mesi precedenti l’impegno è stato gravoso e meno distribuito. E mi inquieta un po’ il fatto di aver dovuto rimandare alcune urgenze della nostra casa editrice relative a progetti importanti (e con l’estate alle porte) per l’indisponibilità al lavoro delle “risorse” che abbiamo prestato al festival.
Probabilmente non si può pensare a un festival più grande di questo (anche per obiettive ragioni di calendario e programma), ma forse è anche difficile o impossibile, con questa struttura, ripetere il festival del 2013 e rinnovare tutto lo sforzo relativo.
Tuttavia, non credo affatto che la soluzione stia nel ridimensionarsi. Anzi, penso che il festival, se non come kermesse di giugno di sicuro come istituzione culturale, debba ancora crescere, proporre, allargare orizzonti, animare l’intero anno, interagire con la produzione di cultura e con l’accesso del pubblico alle opere (e non solo agli eventi).
Sensazioni, perché al momento non ho idee precise al riguardo. Di certo, non penso che la soluzione stia semplicemente nella, pur indispensabile, disponibilità di fondi, pubblici o privati che siano. Ma su forme, dimensioni e progetti credo ci sia spazio per riflessioni e discussioni costruttive.
Per adesso mi fermo, fiero e grato di aver fatto parte di questa avventura.