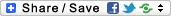Su facebook ho messo su un gruppo interessante, febbrile, dovi si discute di tutto tranne che di sci-fi, che poi è il tema sul quale è stato creato. Forse è per questo che funziona.
Sia come sia, l’altro giorno c’era una serata hard boiled (sì, facciamo le serate a tema), e sono stati fatti i titoli del film omonimo, Hard Boiled (1992) e di The Killer (1989), di John Woo. E sono stati postati due stralci (leggasi video sul tubo) che mi hanno entusiasmato. Questa recensione nasce da quegli stralci. Grazie al Doktor Mana per i suoi preziosi consigli, soprattutto in campo musicale.
Il cinema di Hong Kong mi manca. Non ho scuse particolari per questo. Ma attenzione, neppure un’avversione per la cultura asiatica, che al contrario mi piace molto, soprattutto nella sua complessità storica. Hong Kong, poi, è una fusione avvincente e unica, prodotta dalle sue dominazioni secolari.
È che mi piace altrettanto, se non di più, la cultura occidentale. La nostra. La storia romana sopra tutte le altre, tant’è che ci ho scritto anche la tesi.
Tutto questo preambolo per dirvi che non tenterò di spiegarvi John Woo e le chicche presenti dietro questo film. Sono convinto, infatti, che tra di voi ci sia gente che potrebbe farmi da maestro in materia. Mi limiterò a scrivere quelle che sono state le mie riflessioni durante e dopo la visione, nulla di più, con un invito rivolto a voi lettori/commentatori: se avete aneddoti, curiosità, paragoni da fare, fateli, la vostra voce è benvenuta.

***
Si inizia subito con quella commistione di culture di cui ho detto poc’anzi. Un killer (Chow Yun Fat), seduto in una chiesa cattolica, vestito all’occidentale, con sciarpa e cappello, pagato per svolgere un lavoro, quello che gli riesce meglio: per vivere usa la pistola. Primi piani sul viso della statua della Vergine, ceri e luce calda a fare da scenografia. E poi, la musica, quella si Sally Yeh (Jennie). Perché è nel suo locale che il killer deve svolgere l’incarico.
Proiettati costantemente nell’azione. Il punto è che questo che pare essere dogma, più che direttiva, viene applicato con una rigidità tale che, per il primo quarto d’ora, forse venti minuti, l’ambiente è circoscritto, letteralmente, al volto dei protagonisti. La città è invisibile, se si eccettua la panoramica dei titoli di testa, e viene usata per brevissimi scorci, e inquadrature strette tutt’al più a una sola strada, sempre teatro di violenze. Piegato com’è, lo scenario, alla violenza catartica. Perché di catarsi si tratta. Le sparatorie avvengono all’improvviso, con soluzione di continuità rispetto a scene all’apparenza innocue e tranquille. Il killer si appoggia al muro, soprabito tra le mani, alza il braccio solo un po’, una porta si apre, e si dà il via alla carneficina. Magnifico. Ma sulle sparatorie ci torniamo dopo.

***
Esse, infatti, sono alternate alla storia sentimentale dei protagonisti, a vari livelli. John Woo costruisce una storia d’amore che, proposta da chiunque altro, apparirebbe infarcita di retorica; si basa infatti sul sentimento che il killer prova per la cantante che è diventata non vedente a causa sua, di una sua esitazione; ma che, nella regia essenziale, ben attenta a evitare sia gli spiegoni che inutili digressioni romantiche, mostrandoci la relazione progredire col ritmo delle inquadrature che segnano lo scorrere del tempo, diviene accettabile: è una love story da soap opera, ma va bene così. E non perché prima, durante e dopo, viene bagnata con lotte a omicidi.
Contraltari della storia d’amore tra il killer e la cantante, sono due rapporti amicali dello stesso con un suo collega e con il poliziotto (Danny Lee) che gli dà la caccia. Su questa base già abbastanza complicata si innesta la trama principale che vede il killer avere problemi col suo datore di lavoro, Wong Hoi (Fui-On Shing), il quale, prima lo ha ingaggiato per portare a termine un contratto (leggasi omicidio) e poi ha deciso di farlo fuori, senza averlo neppure pagato.

***
Le sparatorie, dicevamo. Senza giri di parole: sono spettacolari. Coreografiche, variopinte, cinetiche. Non so fino a che punto realistiche. In più occasioni, infatti, ho avuto la sensazione (solo una sensazione, non mi sono fermato a contare) che i caricatori delle pistole contenessero più cartucce del normale. Perché il killer schiaccia il grilletto con una velocità impressionante, ma una Beretta non può contenere così tanti colpi. Ma a chi importa? Lo spettacolo che Woo mette in piedi rende questo dettaglio insignificante.
Gli si perdona tutto, pure l’adattamento italiano che sceglie di attribuire al killer e al poliziotto i nomignoli di Topolino e Dumbo. Normalmente, c’è l’effetto Bubi. Uno sente di un killer che si chiama Topolino e se la fa sotto dalle risate. Ancor di più se questo e il suo amico Dumbo mettono su un rapporto di rivalità/dipendenza reciproca e finiscono a parlare di sentimenti virili, quelli che nascono tra compagni di battaglia, quando i due si mettono a fare strage, con un borsone di armi.
Decine e decine i nemici massacrati. I vestiti di Killer e Poliziotto che si lordano si sangue e un nemico, il capo della Triade, Wong Hoi, allo stesso tempo stolido e spietato, inarrendevole e determinato, come sanno essere i tipi di quelle zone lì, caparbi fino alla follia.
Il killer vuole i soldi per aiutare la sua amata a recuperare la vista, altra motivazione da soap opera, perché qui ci hanno abituato a pensarla così. E invece la storia avanza e lava col sangue e il massacro, col suo essere spietata e poetica, ogni luogo comune occidentale. Un’ecatombe, che lo ricordo, era un sacrificio agli dei. Guardatelo.
Altre recensioni QUI