5 ottobre 2015 di Augusto Benemeglio
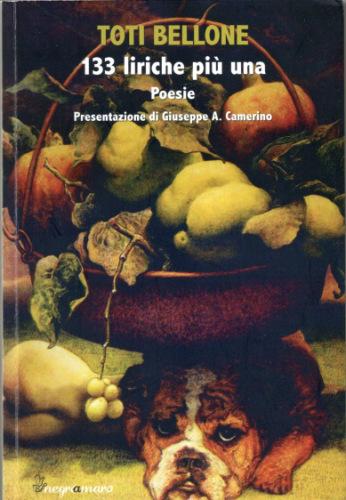
- Da Cardarelli a Prevert
Diceva Vincenzo Cardarelli, forse l’ultimo dei nostri “classici”, che la poesia è “l’arte di tacere”, come la tragedia è “l’arte di mascherarsi”. Toti Bellone ha taciuto per molti anni la sua arte segreta, per poi disvelarsi al pubblico – nudo – senza maschera, con un libro di versi dal titolo un po’ cabalistico-biblico, “133 liriche più una”, Salento Books, 2015, poesie scritte tra un viaggio e l’altro, tra un amore e l’altro, tra un sogno e l’altro, raccolte nel corso di una vita intera (dal 1975 ai giorni nostri) e magari annotate sui risvolti del giornale, o nel lembo dell’incarto della spesa, la bolletta del gas, il pacchetto di sigarette, il conto del ristorante, il biglietto dell’autobus, un po’ come faceva Prevert, a Parigi, che conciliava l’inconciliabile, il linguaggio basso del quotidiano con il volo lirico, provocando irreali fusioni o dissonanze musicali. Bellone si trova in qualche modo un po’ tra questi due poeti contrapposti, usa sia lo scalpellino e il rigore formale di Cardarelli, maestro di inquietudine essenziale (“Ho alle spalle il vuoto. Mi appoggio ai miei errori”), che la lirica prosastica, l’ironia e la denuncia, per l’assenza di giustizia e libertà, di un’epoca che è dominata da pianificazione, orologi, costrizioni collettive, e massificazione, con l’uomo, – diciamo pure l’umanità in senso stretto (“E’ bello sapere /ove lo sguardo si perde, che/qualcuno ti pensa”) – che è ridotto ai minimi termini. Potremmo dire che la sua è una lirica diaristica (ogni poesia è rigorosamente datata) e di lucida, spietata e sofferta “confessione” se il poeta non fosse un “fingitore”, come dice Pessoa. La sua è una tastiera di parole talora dissonanti, sospese tra momenti di esaltazione e solitudine, tra eros e thanatos, la pulsione della vita e della morte, tra cinismo e desiderio di pace, comunque un’anima travagliata e sofferta (“Un male atroce mi squarcia il cervello: non so cosa sia”) che gira su se stessa e non si pone alcuna salvazione; ma il suo è anche un sogno sempre barcollante, uno sguardo che ti spia da un muro cieco, e conta i passi del tuo agire e del tuo destino. Il suo stile si muta a seconda dei momenti, si va dalle reminiscenze classiche al verso libero moderno, per finire quasi all’haiku e allo sperimentalismo. In molte sue poesie riecheggiano, qua e là, le sue più disparate frequentazioni artistico-letterarie -filosofiche, al di là dei nomi da lui stesso citati: Platone, Giotto, Proust, Leopardi, Goethe, Rimbaud, Nietzsche, Ungaretti, Tobino, Bodini, De Donno, Toma, Verri, etc.
- Una vita di respiro e schiuma
Una vita, quella di Toti Bellone, da cronista in prima linea, inviato de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, con reportage che sono diventati libri (“Albania, i giorni della rivolta”, 1999; “La carovana delle sirene”, 2004), una vita di respiro e schiuma, “che duole”, quando rivisita il passato (“…il ricordo di terre lontane / che non ho mai visto/ il ricordo di una donna/ che non ho mai incontrato…un sentiero, una luce smorzata, un sentiero e il suo ruscello veloce”…), una vita lontana, insomma, e mai veramente vissuta, pur nel clamore dei movimenti di gente, gli spintoni che ti trascinano su treni, o aerei, e i tavoli da lavoro che bruciano d’invidia e carboni ardenti, confuso in tutte le armate del caos dei mass media, dentro la conigliera dei pensieri, che fervono tra le cicche e i fumi dell’alcol. Ma ecco che fra i tanti “nessuno” che a lui, giovane cronista, sembravano “qualcheduno”, “ un’ombra appare…e il mondo ha inizio”. E’ allora che cominciano i sogni e le speranze pazze di libertà, s’aprono i paraventi di spettacoli e desideri nuovi, di giorni tutti da vivere, intensamente, come un metaforico Canto dei Cavalieri del Tempio (Il Salmo 133 che dà il titolo al libro) con “alberi incendiati in fiore…e un dio che scivola dalle corde /di un violino /mentre il sole si nasconde tra le nuvole/ che somigliano a bianchi liuti.” E d’un tratto, in un’operazione di chirurgia spirituale, salta il fosso e si ritrova novello Zarathustra che vive in un’oscura caverna di sughero (“Il mio regno è un albero cavo/nascosto lì/tra due isole”), ad ascoltare i brividi di un canto “nella spirale percossa /irta di rovi/squartati nel buio/più nero / di rame/ e croci in fila rosse” e “castigar la brama di luce”, ed esce solo al crepuscolo, per rincorrere quell’ora che gli sfugge, quell’amore invissuto, quella gioia spenta nella cenere, e far rinascere in lui – dopo la morte di dio – l’uomo, anzi l’Oltreuomo: “Odio e calpesto/uccido e stritolo/la mente umana. La riduco in brandelli/ e l’obbligo a contraddirsi/ e dubitar di se stessa. //Sono io che guido la biga/ e alle bestie alate/imprimo ardire e lumi./ Infine vinco/ perché a me piace.”
- Giù per le antiche scale
Ma quel vivere fuori da sé è solo un miraggio, un autoinganno, un reiterarsi di quell’infelicità da lacrime (“Non sai quanto bisogno ho/ di piangere”), da estremi aridi deserti interiori in cui ti senti lo sdegno, lo schifo, la furia dentro te stesso, e un nuovo dio che ti tappa la bocca e la voce, che ti tarpa le ali, che ti dà la facoltà del “non” potere e “non” volere, insieme. Ed eccoti costretto a vivere in un groviglio di serpi dentro il petto, radici di una vecchia immonda pianta che non crolla all’impeto del vento, né si schianterà col fulmine che, prima o poi, verrà. Eccoti a ripetere parole stanche, con occhi paludosi e neri come l’inferno, e il desiderio di chiuderti nella tua “solitudine alata” (“Mi rifugio braccato quasi dalle frasi/ e dalla realtà dei miei simili e non/ in una chiesetta solitaria e vuota”). Oh, quanta decorosa tristezza in quei lecci della sua città, la “piccola cara Lecce”, che ottobre non depreda, e che aprile rinnova; oh, insensibili piante che fanno corona ai monumenti e non sospirano nei pleniluni, e mai che ci fosse un usignolo che li consoli! Stai quieto, gli sussurrano, dormi. Guarda il grande pareggio dei fratelli che non fanno gara, che non pregano più il Salmo 133 della battaglia e della croce. E’ roba che appartiene al lontano passato, tu torna al centro del tuo cuore. E Toti comincia a sperare nel futuro, “ma nella mente mi figuro onde/e mare/ e foreste/ come in un quadro del nulla…Non ricordo un giorno d’amore, un giorno di pace, un giorno di felicità” Come Mario Tobino, va alla ricerca della memoria, “giù per le antiche scale/nel buio, e poi risalire, /sperando che su, alla meta, / un fulmine illumini la mente”. Sembra quasi in cerca dell’espiazione e del contagio in questa nuova vita che si carica di voci, canti, vetri soffiati e flauti, ronzii di api, quieti incontri di farfalle e fiori, fra giochi di sole e danze lontane, una promessa quasi edenica. (“Mi piace qua/…mi pare come una forma/di pigrizia incontaminata”). Ma basta levar la testa per un attimo, scuotersi e vedere come tutto sia “un eterno ritorno”, il perpetuo gioco delle illusioni, di voci ed echi ingannevoli. Ecco le cose di sempre, con “le orche marine /al seguito di sanguinose scie”, con l’assillo dell’orologio, del telefono, del taccuino, della penna nel taschino che non si trova mai, e vedersi scorrere addosso i minuti, le ore, i giorni, gli anni mai vissuti che subito – roba di attimi – ti ritrovi uno sconosciuto davanti allo specchio, con qualche capello grigio, un po’ di pancia e qualche ruga di più: coraggio, coraggio, dici, guardiamo avanti.
- Un miraggio d’amore
E ora ti sovviene che ad Otranto, nella città dei martiri e delle statue di sale, dove c’è “l’ ora di tutti”, c’era stata anche la tua, un amore illimitato, un naufragio dei sensi, che ricorda un po’ la Micol de “Il giardino di Finzi Contini “ di Bassani: “Nicol prigioniera della propria bellezza/bianca, lunare,/ che si perde nel vuoto dei sensi…/ Rara, nel segno di virgo/esplora umani pianeti// riscopre lontani universi// leggera, nel borgo di giade,/ contempla vivaci passioni”. Ma ora anche lei “ si spegne /nel vuoto della vita”. Forse è la stessa fanciulla di memoria cardarelliana, quella “Bocca di sorgiva” che l’anziano poeta etrusco inseguiva sulla circolare di Roma, quella bocca scolpita, quel volto d’angiolo chiaro e ambiguo, quella creatura opulenta e pallida, dai denti di perla, quel sorriso aereo, arduo, lampante, “come un indicibile evento di luce”. E’ solo un sogno, un miraggio d’amore. Ora, dopo l’ennesimo amplesso, Toti è di nuovo solo, incapace di amore, incapace di farsi voce, di farsi canto; rimane in lui un’ombra scontrosa, uno sperdimento e un amaro malinconico furore: “ giro attorno/ alle macchie bianche/ del mio seme/ scrittura di sangue”. E torna ad essere l’enfatico, teatrale, giovane scribacchino di Sagre e Santi Patroni paesani, di tabernacoli, di fiere, di carnevali, di “pizziche” e luminarie, di tante, troppe, feste comandate e non, di tanti, troppi santi, canonizzati e non, di tanti onori, e tante spese per madonne di cartapesta e ceri; tutti hanno un lumino acceso – anche lui – e ognuno celebra il suo giorno di gloria, con il popolino intorno alla Madonna Addolorata: “Levati di dosso/il dolore straziante/dei ferri ritorti//spezzati storciti annullati/ma torna a casa/ è lì che lui (tuo figlio) ti vuole”. Ed è forse questo grido disperato l’ultimo suo canto, la centotrentaquattresima lirica.
5.Da Rimbaud a Freud
Potremmo definirlo, il suo, un diario di transustanziazioni oniriche, dove gli echi e gli specchi delle sue frequentazioni letterarie (consce o meno) si rifrangono, si spargono come piccole esche di luci, “Come alba dura / di un giorno pericoloso di giuochi”, ed ecco allora in “Sussulto d’amore” un flash del divino fanciullo più famoso della letteratura mondiale, Arthur Rimbaud: “ In verde prato dipinto d’azzurro/ove gli occhi cantano al sole/ con giovin fanciulla dai fili d’oro/ ho concepito l’amore” , in “Tristezza in rima”, c’è un bel verso impressionista e fulmineo, che rammenta il primo Ungaretti di “Porto sepolto”: “triste immobilità/ di foglie”, e in “Libertà per una mosca” ritroviamo echi di “Mosche in bottiglia” di Sinisgalli (“Siamo qui per dividerci/un’eredità di stenti./Non spezziamo quello che è intero,/diventa zero”) .Ma si affacciano anche poeti del colore come Monet ne “Il mondo nuovo” (“Vedo morire /un campo di papaveri/ mentre in alto, gaie / svolazzano le rondini”) e richiami a musicisti e filosofi come Wagner e Nietzsche in “Venezia, d’estate/ culla del mondo”. E non manca la siepe leopardiana: “ Oh, caro il mio cespuglio/ che ti calpesto al dì/ appena sveglio/ E sì che non sei nella mia stanza/ ma ti vedo nei mei sogni”, e neppure i sogni freudiani/junghiani (il sogno in Bellone è materia ricorrente, come lo è per tutti i poeti. Borges asseriva che si misura la grandezza di un poeta soprattutto con la maggiore capacità possibile di sognare): “Caro il mio sogno / che ti uccido al mattino/ appena sveglio”
6.Barchette di carta del Salento
Anche lui si porta la febbre di barocco della sua terra nel sangue, e la sua follia come Bodini-Bene-Pagano-D’Andria- Verri-Toma, etc. Certe volte sei così lontana, così lontana, terra mia, che pur di raggiungerti e annullarmi in te, anche la morte mi sarebbe cara; terra fra due mari, in cui navigano “Barchette di carta” (con questo titolo Bellone ha pubblicato un libro di racconti, nel 2002) che affondano in una pozzanghera di fango; barchette che ricordano Nicola G. De Donno, e il suo prezioso libro di poesie dialettali, “Palore” pubblicato nel 1999 da Vanni Scheiwiller, grande amico e ammiratore del “preside” magliese, un poeta severo, asciutto, schivo, metaforico: “Quante barche de sonni àggiu varate,/cchiù ggrande, ca parìane verità, / e mme su’ tutte, tutte, naufracate!”.Ed ecco che dall’ultimo ramo della quercia del bosco delle Ciancole, viene evocato un altro poeta salentino, morto giovane, Totò Toma, che visse sugli alberi, come il Barone rampante di Calvino, insieme a un cane e agli uccelli, e cantò gli animali, la loro dignità, la loro anima, la loro innocenza, e lo strazio, le feroci torture che noi gli infliggiamo da millenni, con quel nostro sangue ormai guasto dentro le vene e dentro l’anima, ributtato nel gioco delle sostanze. Salento mio, non sono capace di farti un canto, sei tutto spine e fuoco, solo una cosa ti posso donare, “la tristezza del secondo mattino e i valzer di Chopin”, e poi gli amori sorpassati, le romantiche campane, i silenzi veloci, gli sparsi ombrelli in arie feconde, il litigio in casa, la luna calante, la scia luminosa, i drappi neri, la chiesa dorata, il tempo che passa, la mantide curvata, la gazzella spaurita, e quel filare d’allodole tra le brume della casa rosa antico, e i carducciani pensieri d’autunno “che migrano verso fantasie lontane”.
Che dire alla fine di Toti Bellone? Quarant’anni di silenzio ed ecco il parto di una poesia (alla fine possiamo dirlo) senza infingimenti, autentica, sincera, che cresce dentro l’eterno giuoco dell’infanzia e dell’adolescenza,“ crudele e gioiosa”, e delle disillusioni; una poesia che non si scancella, che sgorga nella sua mente e nel suo cuore come dono prezioso. Una poesia nuda, distesa per le strade, talora sgualcita, che sta dentro le piccole cose della vita. Perché si scrive? Bella domanda. Uno scrive perché è vivo, – disse De Donno – e poiché la vita gli pare sempre più senza senso, diciamo che scrive per “sentirsi vivo” e per sognare un’altra vita. Infatti, -conferma Toti Bellone- “il mio vivere è stato sempre un sogno”.
Roma, 2 agosto 2015

