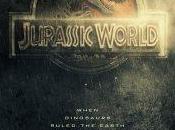Ecco confermata la capacità, assai diffusa nei paesi dell’ex Unione Sovietica, di trasfigurare in forme cinematografiche lucide, essenziali e taglienti certi spunti, di natura drammatica, che corrispondono a cicatrici profonde negli assetti sociali di riferimento: pur da prospettive diverse, sia Harmony Lessons del giovane kazako Emir Baigazin (già visto alla Berlinale del 2013) che il film del russo Jusup Razykov, Styd (Shame), hanno aperto squarci illuminanti, proponendosi a nostro avviso come le migliori opere in concorso al Trieste Film Festival.
Se, per quanto concerne Harmony Lessons, il nostro entusiasmo ha trovato riscontro giusto in qualche critica lusinghiera, nel caso di Styd l’apprezzamento è stato più plateale; si è difatti oggettivato nel premio come miglior film, attribuitogli per la sezione “lungometraggi”. E visto che a Trieste i vincitori sono scelti direttamente dal pubblico, non si può fare a meno di lodare la sensibilità e persino la pazienza di una platea festivaliera, che non si è fatta per niente intimidire dalle tonalità cupe, dalle dilatazioni temporali e dal senso di angoscia che il film russo inevitabilmente comunica. Si può anzi dire che ne abbia colto fino in fondo la struggente bellezza.
La “vergogna” cui allude il titolo del lungometraggio si rispecchia idealmente in una vergogna reale, ben radicata nella memoria del popolo russo, quella relativa al tragico incidente avvenuto il 12 agosto 2000 nel mare di Barents, episodio in cui persero la vita tutti i sommergibilisti imbarcati sul K-141 Kursk. Ma quella per cui ha optato Jusup Razykov non è certo una resa cronachistica dell’evento. Al contrario, in Styd l’episodio del Kursk con tutte le controversie internazionali che ne seguirono viene lasciato sullo sfondo, riecheggiato in termini molto vaghi e senza riferimenti diretti, per lasciar spazio a un punto di vista alternativo: quello delle donne di una base navale russa, rappresentate ognuna col suo carattere e con un diverso modo di affrontare lo sconforto, l’ansia, che la notizia dell’incidente ha portato nella piccola comunità posta ai confini del mondo.
La natura brulla della penisola di Kola dialoga così con sensibilità femminili particolarmente pronunciate. Già, perché tra gli spunti più meritevoli di uno script secco, scarnificato, in cui le psicologie dei personaggi principali vengono tratteggiate in modo ruvido e quasi urticante, spicca proprio il ruolo delle donne. Sono perlopiù ritratti femminili improntati a coraggio e forte dignità. Le donne giganteggiano, quindi, mentre sull’altro versante si impone il carattere cialtronesco, infantile se non addirittura patetico, di uomini che in certi casi vestono la divisa della marina russa e in altri no, ma che quasi mai sanno guardare al di là di una bottiglia di vodka e di un nazionalismo becero. Non pare affatto casuale che Jusup Razykov, uzbeko di nascita e con all’attivo diversi altri film, sia stato stato coadiuvato a livello di sceneggiatura da una donna, Ekaterina Mavromatis. Nella loro elegiaca e crepuscolare descrizione antropologica si ravvisano indovinatissimi accenti critici, rivolti alla disgregazione morale e ideologica dell’universo post-sovietico, come anche l’ancestrale fascinazione dei luoghi, caratterizzati tanto dall’asprezza dell’ambiente artico che dall’approccio disincantato, di impronta quasi sciamanica, della gente costretta a viverci. Il rito di restituire al mare quei beni che il mare aveva donato loro, nella speranza di “contrattare” così il destino degli uomini rimasti prigionieri di quelle gelide acque, è un chiaro esempio di ciò; ed è anche un qualcosa che ci ha richiamato, alla lontana, la forza evocativa e certe concezioni paganeggianti presenti nel cinema di un grande cineasta russo, Aleksey Fedorchenko.
Stefano Coccia