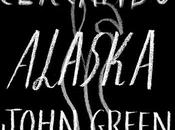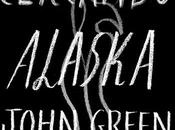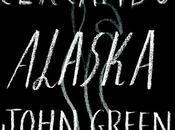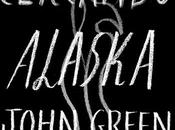Non c'è nulla di provocatorio, infatti, nel protagonista: ciascuno ha le sue ambizioni, i suoi sogni... e i sogni vanno coltivati, difesi contro tutto e contro tutti, anche a costo della vita. La follia vale quasi come scusante, incoraggia a osare oltre noi stessi. Perciò ci sta bene l'estrosa metamorfosi in stile Spiderman (o chi vogliamo noi) per il nostro simpatico invertebrato da corsa e perfino il progetto surreale di iscriverlo a Indianapolis è una boutade simpatica quanto surreale. Ma l'andamento della corsa, la sfibrante gara tra Turbo e il suo eroe di sempre - ovvero tra volontà d'acciaio e odioso mito del piccolo schermo - e l'esito finale sono solo una stucchevole menzogna. Mi chiedo, in particolare, se sia necessario proporre un sogno così disarticolato perché vi si possa credere e si possa desiderare che diventi realtà.
Non c'è nulla di provocatorio, infatti, nel protagonista: ciascuno ha le sue ambizioni, i suoi sogni... e i sogni vanno coltivati, difesi contro tutto e contro tutti, anche a costo della vita. La follia vale quasi come scusante, incoraggia a osare oltre noi stessi. Perciò ci sta bene l'estrosa metamorfosi in stile Spiderman (o chi vogliamo noi) per il nostro simpatico invertebrato da corsa e perfino il progetto surreale di iscriverlo a Indianapolis è una boutade simpatica quanto surreale. Ma l'andamento della corsa, la sfibrante gara tra Turbo e il suo eroe di sempre - ovvero tra volontà d'acciaio e odioso mito del piccolo schermo - e l'esito finale sono solo una stucchevole menzogna. Mi chiedo, in particolare, se sia necessario proporre un sogno così disarticolato perché vi si possa credere e si possa desiderare che diventi realtà.O, per essere più precisi, mi chiedo se la ruffianeria melensa del gabbiano Jonathan Livingston, che voleva fare del volo un piacere e una ragione di vita più che una manifestazione della sua natura, non sia in fondo molto più educativa di questa comoda e inerte rincorsa all'impossibile: comoda perché sottrae alle responsabilità del reale e inerte perché attribuisce il successo alla sfera del sogno, con il risultato di non essere né una spinta a fare, né a desistere dalle proprie follie. A dire il vero, durante la corsa di Indianapolis - infestata in modo indegno dalla pubblicità reale di prodotti in uso oggi in tutto il mondo - c'è una sequenza molto emozionante, nella quale sembra quasi che in quel luogo improbabile si riscopra il brivido della lentezza, ma è solo un attimo; subito si imboccano le scorciatoie narrative della favola moderna comme-il-faut, perbenista e politically correct. E l'esito è chiaro, vince l'impossibile allucinazione bimbominkia contro uno sguardo nuovo e incisivo di tutti sulle cose.