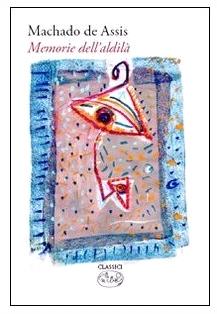
Nel frattempo, tra il momento in cui ti rendi conto di cosa dovresti fare per star meglio e il momento in cui ti risolverai a mettere in pratica i tuoi stessi consigli, i luoghi si svuotano di persone e dalle pareti prende a colare un liquame grigio, che puzza d’arance e copertone bruciato in maniera tanto penetrante da riuscire a sfocare i contorni delle cose che ti sono più prossime. Un libro ti cade di mano, perdendo un paio di pagine che svolazzano e come sciabordano nell’aria – nella caduta, ti sembra di intravedere parole e frasi che contengono frasi che deridono, motteggiandola, la tua condizione.
Altre ragazze ti scrivono, ricevono risposte evasive e si ritraggono, più fragili di te. Rifiuti tutto, anche quelle occasioni che avevi deciso di trascurare pur di averla, e che adesso potresti – è chiaro, dovresti – riprendere in mano. Ma con quale forza, poi, se quello che fai per gran parte del tempo è disprezzare tutto quello che ti passa davanti agli occhi, adagiare il reale su un tavolaccio e ricomporlo come un morto, prendendo misure della salma per sapere di quanto s’è ristretta, dai piedi alla testa? (Che poi, parentesi, di certo le misure, quando le hai prese, erano inferiori rispetto a quelle di cui tu adesso vagheggi; ma mica ti riesce di convincerti che dovresti riandare al diario in cui le annotavi amorevolmente assieme ai dubbi, e perciò per il momento ti resta solo quel ricordo, sformato in direzioni che stirano e pungono).
Il fallimento non c’è: tutto è cazzo come due settimane prima, cinque giorni prima, sette ore prima. Hai un lavoro che forse lascerai per opportunità ancora migliori; hai una vita che non è sfarzo e non è miseria. Non la vorresti diversa.
Solo che, e lo realizzi troppo tardi, non eri tu ad essere riuscito a rendertela migliore; era stata lei.

