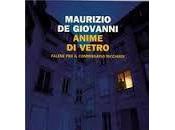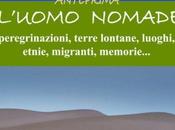Se si dovesse ritenere la mappa del Blaeu dal titolo: Civitas Neritonensis vulgo Nardo,del 1663, che conosciamotratta dal " Theatrum civitatum nec non admirandorum Neapolis et Siciliae regnorum ", quanto mai veritiera, allora potremmo, con curiosità e spirito d'indagine, osservare l'originaria facciata di S. Domenico (S. Maria de Raccomandatis) riprodotta nella sua reale conformazione.
Con un po' più di scrupolosa attenzione, guardando bene quel particolare e la qualità del tratto, forse troppo sintetico, ma calligraficamente proporzionato, si nota subito che, il veloce segno dell'esperto cartografo, non sosta molto tempo su quella facciata (confermando la semplicità della descrizione che doveva avere quella esistente e che il Blaeu, realmente osservava). Nello stesso tempo, 'accenna' (ed è questa la bravura del disegnatore) a quei 'probabili' particolari che possono aiutarci (l'evidente cornicione marcapiano che divide i due livelli, il grande cornicione aggettante che delimita superiormente la facciata, le due orecchie laterali a voluta, di differente grandezza per lato inserite nel profilo concavo decorato come le grandi finestre a piano terra e quella quadrata centrale). Casualmente, ed a totale favore del nostro lavoro, per la possibile e intuitiva ricostruzione della facciata, anche concettuale, notiamo come la stessa, nella mappa, si trovi in posizione quasi frontale. Allora potremmo schematicamente immaginare come risulterebbe, la soluzione antecedente alla 'ricca' realizzazione che conosciamo noi oggi.
Anche se, in generale, percorrere visivamente le strade sulla mappa della Civitas Neritonensis vulgo Nardo,del 1663, è evidente uno smodato uso dei tetti spioventi curvati, 'segnatamente' del tipo a ' pagoda'. Sappiamo che il metodo costruttivo e la tecnica edilizia assolutamente non potevano concepire quella soluzione. In più, là dove è presente (disegnata) l'edilizia intensiva 'a schiera' riportata sempre nella mappa, essa assume un aspetto 'ritmico' seriale e razionale un po' troppo 'olandese' che certo non poteva essere quello esistente, ma di sicuro faceva parte dell'esperienza e della pratica artigianale, quasi di 'serie', del disegnatore-cartografo. Comunque, riconoscendone il 'metodo pratico e riempitivo', usato dove gli aggregati si presentavano più densi, almeno per la distribuzione urbana e nella disposizione dei riferimenti cittadini (ad esempio; i vuoti dei giardini interni agli edifici o le piazze, le mura, i monumenti e le strade) si riterrebbe la mappa del Blaeu, perlopiù, attinente alla probabile realtà dell'urbano centro di Nardò del 1663.
In particolare: la linea cape dutch, dello stile coloniale olandese del Capo, si riferisce alle soluzioni architettonico-coloniali boere della Provincia di Western, in Sudafrica. L'espressione significa letteralmente "olandese del Capo" e deriva dal fatto che i boeri (o afrikaner) erano principalmente di origine olandese. La curva spezzata mistilinea, già individuata come una soluzione da 'cimasa' tardo-gotica, caratterizzava dunque anche il "cape dutch" e si può ricondurre ad influenze olandesi o germaniche medievali o ancora della Francia ugonotta, con elementi indonesiani. Quel particolare profilo mistilineo è stato preso in esame, da questi miei studi (Commentari d'antiquaria filologica), nel caso della descrizione della "linea adriatica", con le diverse facciate assonanti già presentate in:
Intorno al Mausoleo dei Duchi Acquaviva di Nardò (Parte terza)Tornando alla descrizione invece della facciata della chiesa di S. Maria de Raccomandatis (l'attuale S. Domenico), ci si accorge che è appena adornata e punteggiata da quelle che potevano essere delle aperture (o nicchie !?) poste asimmetricamente in facciata. Qui, si è tentato così di immaginare il suo probabile sviluppo, rispettando letteralmente, quei piccoli tratti indicati da Joan Blaeu, ma contestualizzandoli nell'ambito della città.
Naturalmente da questo discorso ne deduciamo qualche conferma, non certo marginale; alla data di stampa della mappa del 1663 ad Amsterdam, sulla base di quanto ritratto dal Blaeu, la facciata della chiesa, come la conosciamo noi, ancora non era stata realizzata. A parte il tempo che può essere intercorso tra il rilievo della città e la sua stampa, se altri dati permettessero di confermare il contrario, allora dovremmo rivedere l'affidabilità cartografica di gran parte dell'immenso lavoro interpretativo dell'esperto olandese.
Ma quello che qui si vorrebbe tentare di cogliere è, come si arrivò, poi, alla realizzazione di quella meravigliosa soluzione scultorea. Così ornata e fitta, densa di personaggi, decorazioni e simbologie? E' il risultato di una lunga fase di costruzione (1580 - 1663?), con attenzione sicuramente ai principi teorici e di scelte compositive progettuali 'regolamentate', in parte innovative, per il loro carattere ricercatamente antichizzato (volutamente riferito ad un linguaggio facilmente comprensibile dal cittadino post-rinascimentale da educare cristianamente, ma fondamentalmente asservito al feudatario, quindi di 'gergo' e 'ambito' sociale basso-medievale). Cioè al momento della costruzione della facciata, il suo complesso apparato di significati (quadro iconografico e iconologico), apparteneva già al 'passato'. Un passato 'fondante' costruito su regole ecclesiastiche che la facciata doveva riabilitare e rinnovare con un forte messaggio post-tridentino controriformato. I motivi che ho ritenuto fondamentali, per questa facciata 'insegna', saranno molto più chiari ai lettori quando avranno concluso di leggere quale ambiente sociale culturale esisteva nella Nardò del 1570 circa.
Perché dunque quell'uso di tanti tragici, messaggi scultorei figurati, scelti 'a tutto tondo', delineati, così in rilievo da sembrare uscire con disinvoltura dalla raffigurazione e capaci di imporsi sul piccolo spazio della piazzetta antistante? Anche se, un altro particolare da eccepire, risulta essere dato dall'effetto, non banale, di un 'alto rilievo' studiato per la pagina di quello che sembrerebbe un 'codice miniato' pietrificato o un originale retablo, magistralmente 'cesellato' e descritto nei suoi dettagli. Tale impianto, però, 'cede' quando si osserva e si analizzano le profondità delle sculture. Risultano spessori sbozzati e figure che perdono potenziale espressivo, deformandosi anatomicamente. Appare infatti abbastanza stiracchiata, quella geniale (frontale) tridimensionalità figurativa.
Tutto funziona, a condizione di essere guardato frontalmente (conforme alla mia tesi sulla condizione progettuale inerente alla filologia-scultorea-antiquaria, come pratica manifestatamente, ritengo, molto più utilizzata ed irrefutabile, di quello che si vorrebbe porre in secondo piano secondo le varie indagini e conclusioni storiografiche locali. Infatti diventa di rilevante importanza, 'isolare' descrittivamente quegli episodi, per meglio interpretare, dove e quali caratteristiche assume, o ancora, come viene individuata quella componente, della selezione 'antiquaria', nelle soluzioni progettuali, rispetto a quella architettonica). D'altronde una delle prime, ma fondamentali questioni, è quella di superare un equivoco essenziale e impegnativo, quasi vitale per l'argomento in questione; il gioco d'ombre, ottimamente leggibile, deve rifuggire da qualsiasi tentativo di porvi definizioni approssimate come quella di barocco, 'barocchetto' o peggio rococò. Risultato subdolo e ambiguo, adattato irresponsabilmente a definire la sola somma di stilemi, decorazioni, simbologie, re-interpretate e giustapposte (opinione comune, purtroppo e ancora oggi sostenuta da un fallace fraintendimento che può dipanarsi solo quando la reale decodifica della lettura artistica, è mia opinione, riconoscerà e permetterà di comprendere i riferimenti costruttivi reali, coinvolgenti maggiormente la sua originaria vocazione, totalmente intrisa dall'artigianalità e del gioco anche intellettuale dei surreali fuori scala che dai piccoli cammei o pannelli d'avorio divengono, basi d'altare o baldacchini oppure ancora intere facciate) per la maggior parte fondate su regole accademiche, risolte secondo la manualistica 'in vigore' e 'in uso'. Si conferma allora palesemente una sempre più disinvolta appartenenza alla filologia antiquaria (e non architettonica), condizionata da un ambito prettamente religioso e dalle influenze controriformistiche, come pratica comunicativa 'strutturata' e comune nella maggior parte della zona del Salento.
vedi anche:
Lecce: la filologia antiquaria e la colonna inglobata riccardesca Quel toro rinchiuso nella... parasta Nardò: Il Dies Irae medievale fra le pagine del S. DomenicoIntorno al Mausoleo dei Duchi Acquaviva di Nardò (Parte I)
Dalla descrizione del contesto sociale della città, alla seconda metà del '500, fra le righe dello studio dei documenti storici, infatti, è possibile trarre dei criteri interpretativi per cogliere tutte quelle trasformazione concettuali che diventano delle strutturali direttive culturali, sociali e, a questo punto, anche costruttive di grande riferimento. Occorre, dunque, comprendere come, delle semplici regole teoriche tradotte poi, in varianti scultoree, una volta trovato il proprio ambito vocazionale, invadono e saturano ogni genere di 'nicchia' spaziale, diventandone parte integrante, e anzi, proponendosi come unico modo espressivo di quella zona, capaci di delinearne un paesaggio rinnovato. Quindi le regole dell'uomo, precedono e accelerano i processi di trasformazione dei territori modificandone, lingua cultura e ambiente. Fondamentale è dunque comprendere lo stato sociale e culturale di 'quel' presente, le cui regole e i comportamenti, hanno generato 'norme' pietrificate simili a istruzioni per l'uso di 'senso' e di 'funzione', per la vita che in quella città, vi si svolgeva.
La facciata 'scolpita', di quell'originale monumento del S. Domenico di Nardò, assolve all'importante compito di tramandare e, con i documenti qui riportati, lasciare immaginare e completare mentalmente, il possibile reale motivo di un espediente strumentale e filologico legato all'antiquaria (cioè di stretto rapporto con l'arte e l'artigianalità delle procedure cantieristiche organizzate da maestranze alquanto consapevoli e aggiornate). Assolutamente non da intendere nell'accezione di ripetitività ornamentale o meramente pedissequa e ridondante se non decorativa, ma come sintesi generatrice di ricerche espressive indirizzate verso un'altra natura e un altro ambiente. L'artigianalità, nel tempo, ha scelto, selezionandone sapientemente le relazioni ed ha colto i termini adeguati, fregiandosene, ospitando ed esprimendo così, l'alto valore plastico quindi plasmabile della pietra locale, risultato duttile e originale, della manualità dei costruttori e della raffinata intuizione strategica dei committenti, nel ricercare e azzardare, proprio per quella pietra, le sue varianti espressive, declinate dal suo migliore e convincente utilizzo.
Nel caso della facciata della cadente Santa Maria de Raccomadatis di Nardò compreso il suo convento degradato, già appartenente all'Ordine dei Domenicani, occorrevano delle indicazioni precise, dirette e altamente comunicabili che mostrassero, nello spazio di una facciata, quali potevano essere le semplici, ma inderogabili regole per la salvezza dell'anima da trasmettere ad un contesto sociale come quello di Nardò.
Ma vediamo come l'ambito urbano di una città recepisce le 'istanze' derivate dai modi di vita e dai costumi di tutta una comunità nei fatti raccontati e scritti nei documenti.
Era in carica per la seconda volta come Provinciale dell'Ordine dei Predicatori del Regno di Napoli, quando nel 1569, esattamente il 26 agosto, veniva nominato vescovo di Nardò, il padre domenicano Ambrogio Salvio. La nomina giunge inaspettata al dotto teologo che a 78 anni non si aspettava certo un incarico di evidente responsabilità e di quella portata. L'umiltà e l'obbedienza comprovarono, ancora una volta, l'alto valore dell'uomo di Dio.
Infatti, nella descrizione, il Paoli ne fa menzione:
" Giunto dunque nella sua Diocesi cominciò a muovere guerra apertamente a que'vizi, e a quelle corruttele, le quali non senza suo orrore la tenevano in que' tempi occupata, ed oppressa. Ed erano queste sì molte di numero, e sì radicate nel cuore di que' miseri Popoli, che ogni altro di lui men forte farebbesi spavento a solamente meditare il come poterle combattere, non che il come poterle vincere. Ne dee già recar meraviglia a chi hà senno, l'udigli strani, e spaventosi abusi insorti i quella Diocesi ".
"[...] Arrivato in Diocesi incominciò con sollecitudine, e zelo, e vigilanza Pastorale a dimostrare con l'esempio la vita, e costumi, che lo fecero tanto caro a Pio Quinto (Antonio Michele Ghislieri, Papa dal 1566 al 1572) di Santa memoria, ed all'invitto Imperatore Carlo Quinto, di cui fù Confessore, e Predicatore mentre dimorò in Napoli, ed a tutte la stessa Città di Napoli, che come benemerito di quella risplende la sua memoria in diverse Chiese, e luoghi, e particolarmente in quella dello Spirito Santo, con statua, iscrizzione, e marmi. E ricordevole di quello ordinano i Sacri Canoni per esecuzione anco degli ordini del sacrosanto Concilio di Tridentino incominciò a visitare la Città, e tutta la Diocesi, e con cura particolare, a sradicare affatto le bestemmie pubbliche, e gravi, li Concubinarj publici, le usure, ed altri vizj, applicando conforme il bisogno il rimedio, ed il gastigo . Ma quando venne al Clero allora fatto quasi flagellum de funicolis, ritornò l'abito, e tonsura, e vita Clericale alli Preti, che andavano da Laici colle lattuchiglie, e maggior parte dell'anno vestivano da soldati tirando soldo dal Re per guardia di quelle Terre di marina, si vestivano con maschere, andavano alle taverne pubblicamente, e quelch'era peggio tenevano diverse concubine nelle proprie case con li Figli nati loro. E fece di modo, intanto cumulo disordinato di vizj, che vi piantò un'ordine grande di virtù riducendo il tutto conforme ordina il sacrosanto Concilio di trento. Ma maggior petto, e Zelo Pastorale mostrò nella visita, che fece nel Monastero di S. Chiara, avendolo trovato senza clausura, uscendo le Monache per tutto, andando a spasso alla marina conduttivi da personaggi di qualità, e senza solite grate al Confessionario, e Comunichino, e Parlatorio, e ruota, con mille altri disordini gravissimi, per li quali detto Prelato tocco dal zelo dell'onor di Dio lagrimando disse: trovo il Monasterio di santa Chiara un 'osteria, e quasi Lupanar ".
A conferma ed a conclusione del grande lavoro svolto per " que' miseri Popoli", dal domenicano Ambrogio Salvio (vescovo di Nardò dal 1569 al 1577), al tempo della pubblicazione della biografia, il Paoli afferma che gli importanti effetti della disciplina riconsolidata, a Nardò e in quella Diocesi, sono riportati nel primo dei due Codici nelle relazioni, conservate nella Biblioteca Chigi a Roma: " Vedrassi chiaramente in esso, quanto male fusse ridutto quel Popolo, e quel Clero: l'uno, e l'altro de' quali vive adesso così morigerato, e devoto. [...] Anzi e' sembra, che dar debbano queste ree memorie un risalto più vantaggioso a quella santità, e perfezione, colla quale tanto si vanno segnalando quelle Nobilissime Vergini (suore di clausura di S.Chiara), che vivono in perfetta vita comune, e sono lo specchio della Provincia ".
Quali siano stati i consigli, i suggerimenti, le strategie e le pratiche messe in atto con tanto zelo, pazienza e carità dal vescovo Ambrogio Salvio, che ricordo alla sua nomina aveva già 78 anni, sono riportati nell'antico testo a monito e per il futuro di quella Chiesa. Di certo quella facciata è risultata un'eccezionale invenzione per 'parlare' con chiarezza di fede. Essa funziona ancora per chi vuole cogliere i suoi messaggi, riscoprendosi giorno per giorno, uno strumento utile e prezioso che dal passato si proietta con colta semplicità nel futuro.
Il testo in corsivo è stato tratto da: Sebastiano Paoli, Della vita del venerabile monsignore F. Ambrogio Salvio dell'ordine de' predicatori eletto vescovo di Nardo dal santo Pontefice Pio Quinto e di altre notizie storiche spettanti a quella Chiesa, Libri due scritti da Sebastiano Pauli de' chierici regolari della Madre di Dio, in Benevento, stamperia Arcivescovile, 1716.
Il testo su citato è stato ricercato prima nella rete del "Museo Virtuale del Libro Antico" e poi consultato presso la bellissima struttura della biblioteca comunale di Gallipoli, al link:
http://www.culturaservizi.it/museo_virtuale_sudsalento/biblioteca-comunale-di-gallipoli http://www.europeana.eu/portal/record/08504/C4AD58215575B5D0DB49C53B08CD2593CB1F8D17.htmlProgetto ArtPast- Cultura Italia - Ritratto di Ambrogio Salvio, tela, pittura a olio, proprietà privata.
http://www.worldchesslinks.net/ezi21.htmlMonumento a Frate Ambrogio Salvio (Bagnoli 1491 - Nardò 9 febbraio 1577), il quale fu domenicano di grande capacità ed intelletto. Divenne Vicario Generale dell'Ordine dei PP Predicatori, Vescovo di Nardò (dal 1569 sino alla morte), confessore dell'imperatore Carlo V e prelato ben accetto a Papa Paolo IV e V, a Papa San Pio V ed ai Santi Filippo Neri e Gaetano Thiene. Sommo teologo, filosofo e famoso oratore, Frate Ambrogio, si distinse anche per l'ampliamento della Chiesa e Monastero di San Domenico a Bagnoli dove vi istituì un educandato.
http://www.panoramio.com/photo/28591564Basilica dello Santo Spirito - Monumento funebre di Ambrogio Salvio opera di Michelangelo Naccherino
http://www.culturaservizi.it/museo_virtuale_sudsalento/ritratto di F. Ambrogio Salvio
http://www.frassotelesino.net/wp-content/uploads/arte/G.%20LALA%3A%20La%20pala%20del%20Rosario.pdfLa battaglia di Lepanto, di Giuseppe LALA, in MOIFA' Luglio 2000, pag. 14