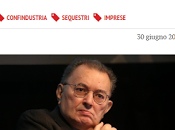di Giuseppe Nativo. Donne oltraggiate e ferite nell’animo e nel fisico dai loro compagni. E’ una cronaca martellante, quotidiana, che gli organi di informazione sottopongono all’attenzione popolare. Si moltiplicano i flash di agenzia, talora con poche righe, sovrapponibili per le analogie eccetto, talvolta, per l’epilogo che produce un incontenibile sgomento ed indignazione.
di Giuseppe Nativo. Donne oltraggiate e ferite nell’animo e nel fisico dai loro compagni. E’ una cronaca martellante, quotidiana, che gli organi di informazione sottopongono all’attenzione popolare. Si moltiplicano i flash di agenzia, talora con poche righe, sovrapponibili per le analogie eccetto, talvolta, per l’epilogo che produce un incontenibile sgomento ed indignazione.
Si impone prioritariamente non la necessità di una nuova legislazione o normativa in materia, bensì la costruzione di una nuova cultura relativa all’identità femminile e alla relazione di coppia.
La violenza è già entrata mimetizzandosi nella quotidianità, all’interno delle famiglie, nel contesto scolastico dei giovani, in quello lavorativo, in quello comunitario e sociale.
L’abusante, in genere, non presenta caratteristiche esteriori allarmanti: può avere un aspetto curato, gradevole, sa essere gentile, premuroso, affabile. In buona sostanza “bravo e devoto marito e un papà speciale”. Difficile credere che possa commettere gesti violenti una così brava persona!
Eppure il sospetto che la vicenda sia costruita dalla vittima per raggiungere un vantaggio personale, sia economico o sia relazionale, è forte e nemmeno celato.
Non sono poche le donne che decidono di procedere verso quelle tutele previste dalla legislazione vigente rivolgendosi alle forze dell’ordine. Non di rado, però, il timore li induce a recedere e tornare nell’ombra. Quest’ultima è una triste realtà che può prestare il fianco a quel senso di vergogna e di colpa della donna, che ha provato e prova, favorendo l’intima convinzione di aver provocato quello che le succede e di averlo addirittura anche meritato. Diffidenza e riprovazione sono le risposte che spesso le donne trovano quando si rivolgono a chi le dovrebbe soccorrere.
Ma che peso ha la pressione dell’ambiente sociale e familiare, specie nel meridione? Abbiamo girato la domanda a Maria Moschetto, psicologo e psicoterapeuta che opera nell’ambito della Sicilia sud-orientale.
«Ha un peso, purtroppo, decisivo. Esiste la convinzione che “i mariti si sopportano…” e che in fin dei conti “lui non ti fa mancare niente”, oppure “cosa penserà la gente…”. Rose Galante nella sua recente pubblicazione Perché non lo lascio? (Editore Antigone, Torino 2012) scrive “le donne che subiscono violenza spesso custodiscono il segreto di quello che succede fra le mura domestiche. Il silenzio rende le mura di casa una protezione per i violenti proprio grazie alla concezione inaccettabile della lealtà e del dovere di cui il nostro tessuto socioculturale è ancora impregnato”…».
…E la voce della gente?
«Altro fattore correlato è l’insidiosa progressione dell’informazione calunniosa e diffamante della “voce di popolo” che spesso presta il fianco al partner abusante il cui tema dominante è “una donna che lascia certamente ha un altro…”. Il rischio potenziale è l’isolamento e il confino, verso cui la donna viene assegnata, ben congegnati dal partner in una strategia di ostracismo sociale che è messo in atto in una dinamica che appartiene sempre e solo alla violenza».
…E l’autostima e il senso di identità delle donne?
«L’uomo sente di essere legittimato nell’esercitare violenza, rosicando, quotidianamente, l’autostima e il senso di identità della partner, instillandole insicurezza nel suo universo affettivo, rivendicando un pieno dominio su di essa dietro la facciata della riappacificazione. Le affermazioni più frequenti vanno da “senza di me sei nulla, non vali …” a “nessun uomo potrà mai amarti come ho fatto io…”. Da qui hanno origine gli orribili titoli della stampa, del tipo “l’ha uccisa perché la amava troppo” che non meritano ulteriori commenti.
Come intervenire allora efficacemente per abbassare queste terribili statistiche, paradossali per una società che si definisce civile ed evoluta?
«I decaloghi su quali comportamenti adottare, le mappe dei centri antiviolenza, le informazioni relative agli strumenti legislativi a disposizione sono, nell’epoca di internet e dell’overdose informativa, facilmente reperibili e rappresentano solo un aspetto, prettamente cognitivo, della complessa risposta alla violenza. A mio parere, il primo gradino del percorso di una donna che ha subito violenza è di ordine psicologico esistenziale: essa dovrà fortificarsi e ricostruire la propria identità, spesso “ridotta a brandelli”, il proprio mondo interiore per fronteggiare il “dopo”. L’intervento preliminare propedeutico è di protezione psicologica finalizzato a restituire una nuova visione di sé».
Riconoscere la violenza del proprio compagno è il primo passo di un lungo e sofferto processo?
«E’ vero, si tratta di un processo che è necessario vivere con i suoi tempi e che contempla tanto il lutto per la perdita definitiva del progetto relazionale, quanto il superamento di forti resistenze, spesso radicate e cronicizzate negli anni, sostenute da vari e personali meccanismi difensivi quali la negazione, la depersonalizzazione , la razionalizzazione. Spesso le donne ondeggiano fra allontanamenti improvvisi, case rifugio, amici, parenti e altrettanti repentini “rientri” che, purtroppo, come documentato dalla letteratura, potenziano la violenza. Denunciarla si rivela un passaggio critico in quanto segna. C’è un “prima” e un “dopo”, sfibra, scuote e sottopone a una severa verifica gli universi simbolici di una donna».
Cosa implica oltrepassare la soglia di un commissariato, di una caserma, di un tribunale?
«Superare tale soglia implica accedere ad un sistema istituzionale di tutela e protezione per eccellenza in cui sono richiesti solidi fatti probatori e non sentimenti ed emozioni. Varcare tale soglia assume un valore simbolico di rilevante importanza che equivale al raccontarsi. Significa depositare un fardello carico di ferite nell’anima, di disintegrazioni emotive. Ne discende che la formazione degli operatori delle forze dell’ordine dovrebbe essere uno dei capisaldi degli interventi da promuovere e sostenere in ambito politico-sociale».
Il momento storico è maturo per poter operare concretamente affinché possa cessare quella che può definirsi cronaca delle “morti annunciate”?
«Il settanta per cento degli omicidi delle donne è preceduto da violenze da parte del partner. Il momento più pericoloso per la donna è rappresentato dalla decisione di separarsi e i sei mesi successivi ad essa. Purtroppo la donna abitualmente non percepisce il rischio reale, tende a sottovalutare o minimizzare il pericolo, si rifiuta di credere che possa essere ferita o uccisa, resta fedelmente in contatto con quell’immagine “buona e devota” del compagno. Ma per dirla con le parole di Robert Musil (1880-1942, scrittore e drammaturgo austriaco) “i teneri sentimenti della dedizione maschile sono simili al brontolio di un giaguaro che ha fra le zampe un pezzo di carne e non tollera di essere disturbato”. L’uomo violento non accetta alcun rifiuto da parte della propria compagna, pretende di esercitare su di essa il dominio totale».
Quando la donna si allontana è il momento critico e pericoloso?
«Purtroppo è così. E’ un momento particolare in quanto il partner metterà in atto varie strategie al fine di riportarla sotto il suo diretto controllo: chiederà perdono, farà le promesse di rapidi cambiamenti, di una nuova vita insieme o eserciterà altra violenza, il più delle volte psicologica, ricattatoria “per il bene dei figli” oppure “per l’unione familiare”. Spesso si innesca così quel “ciclo della violenza”, ben noto agli specialisti del settore, che viene spezzato solo quando la donna matura un progetto di “uscita” dalla relazione, si riappropria del significato di sé come persona che non merita di essere maltrattata o umiliata solo perché “ha fatto arrabbiare” il proprio compagno. Concludo con le parole della citata Rose Galante “stare vicino alla vittima di un abuso non è tanto una strategia o una tecnica ma piuttosto una posizione di vita di fronte all’ingiustizia inaccettabile della violenza e dell’abuso […]. La donna si convince così che non è sola ad affrontare l’abusante, c’è qualcuno che sta dalla sua parte […] si sentirà più forte e coraggiosa, [...] poiché, in fin dei conti sarà lei a salvare se stessa”».
Featured image, John William Waterhouse, la sirena (1901).