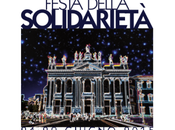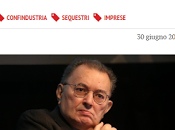Attribution: Paolo Pedrotti.
Nel mentre in cui il Festival dell’Economia entrava ormai nel vivo della sua programmazione, sabato pomeriggio al Teatro Sociale di Trento l’ambasciatore Sergio Romano, noto ai più per la sua attività di editorialista del Corriere della Sera, ma per i lettori più attenti apprezzato anche per le sue pubblicazioni d’ambito storico-politico, ha tenuto una lectio su quello che potremmo definire un classico storiografico, molto sentito presso l’opinione pubblica: i rapporti di Sovranità tra Stato e Chiesa. Un’orazione di circa un’ora, in cui Romano ha accompagnato l’uditorio all’interno di un’accattivante digressione storica, il cui punto d’avvio è stato il Risorgimento. Un Risorgimento che ha assunto i suoi connotati anticlericali solo in un secondo momento, avendo avuto al suo interno, almeno fino al Quarantotto, un ampio movimento che nel Papa Pio IX, da molti salutato come un liberale, vedeva una speranza per l’Italia. Il Neoguelfismo degli anni ’40 dell’Ottocento aveva infatti creato un’idea di Italia federale sottoposta alla guida spirituale e politica del Papato, in realtà ben lungi dall’intestarsi la titolarità di una qual si voglia riscossa contro l’Austria cattolica. Infranto il sogno, o il timore, di un’Italia a sovranità papale, e affogato anche, sul versante opposto, il Quarantotto mazziniano della Repubblica romana, i rapporti tra Risorgimento liberale piemontese e Chiesa di Roma hanno iniziato un repentino deterioramento, ben presto sfociato nella meglio nota “Questione Romana”. Non è un caso che sia la Destra che la Sinistra Storica liberali del Parlamento di Torino abbiano avuto al loro interno esponenti di primo piano appartenenti alla massoneria dichiaratamente anticlericale, tra i quali spicca l’uomo regista dell’operazione diplomatica che poterà all’Unità: Cavour. Le ostilità con la Chiesa sono poi esplose in seguito alla Breccia di Porta Pia, quando nel 1870 il governo italiano ha annesso quello che rimaneva dello Stato pontificio, ormai non più beneficiario della protezione di Napoleone III.
Un Papa “prigioniero dello Stato italiano”; ostile nonostante le modeste concessioni avanzate dalle Leggi delle Guarentigie; convinto che la creazione unitaria si sarebbe ben presto rivelata effimera, e perciò dunque determinato nell’intransigenza del “Non expedit”: le due sovranità sono in aperto conflitto, fedelmente alla tematica del Festival di quest’anno. Ma le aspre ostilità sarebbero state costrette ad affievolirsi, soprattutto a partire da quando la Chiesa temette l’esclusione dalla Storia, e decise di giungere a patti. Romano fa a questo punto notare quanto abbia influito, sul finire del secolo XIX, l’esordire sulla scena politica del Socialismo, nuovo nemico della Chiesa e nemico comune anche tra molti laici moderati. È in questo contesto che si può comprendere il senso ultimo dell’enciclica di Leone XIII Rerum Novarum, la quale, introducendo la teorizzazione dell’Interclassismo, opposto alla Lotta di classe, non escluse l’intervento dei cattolici in politica. Seguirono nel 1912 il Patto Gentiloni tra i liberali di Giolitti e i cattolici; nel medesimo anno la benedizione della Chiesa verso la guerra di Libia, dal clero salutata come positiva missione civilizzatrice; e infine, ovviamente, la fondazione del Partito Popolare di Don Luigi Sturzo. Poi arrivarono i Patti Lateranensi, e il senso di opportunità del regime fascista, che volle l’accordo con il Vaticano anzitutto per una ragione di mero prestigio, oltre che di stabilizzazione interna. Le due sovranità cessarono quindi di essere in conflitto, e la Chiesa prese una posizione mai avuta prima. Romano arriva addirittura a interpretare gli eventi del ’45 e del ’46, rispettivamente la caduta del Fascismo e il crollo della monarchia sabauda in seguito al referendum di cui ieri è ricorso l’anniversario, come i momenti d’apice della sovranità della Chiesa, in grado di condizionare addirittura alcuni passaggi del biennio costituente 46/48.

Attribution: Paolo Pedrotti.
Ma qui inizia una storia fin troppo nota, anche per coloro i quali della storia abbiano una conoscenza a mala pena manualistica: Sergio Romano sa che soffermarsi sul potere d’influenza politica esercitato dal Vaticano sulla società civile italiana ai tempi della Prima Repubblica, per tramite soprattutto della Democrazia Cristiana, sarebbe tautologico, quando non ripetitivo. La digressione storica fa quindi un salto di decenni e sfocia in aperta attualità, approdando ai nostri giorni con la visione di Romano di una “sovranità dimezzata” e di un potere che potremmo definire “residuale” della Chiesa.
Tangentopoli e il collasso della Dc altro non sono stati che eventi positivi per il Vaticano (questo sempre nella lettura che ci offre Romano), essendo stati in grado di innescare la diaspora democristiana che ha portato colonne di cattolicesimo in tutto l’emiciclo parlamentare. “Potere residuale”, si è detto, in quanto esercitato ormai solo sull’Italia e su nessun’altro paese dell’Europa cristiana, e in quanto esercitato ormai solo nel campo delle tematiche di matrice etica. Il fallimento dei referendum sulla Procreazione Assistita nel 2005 (con l’invito esplicito della Cei all’astensione); l’inconcludenza dei Governi di Centro Sinistra di fronte al problema delle coppie di fatto e alle convivenze omosessuali; infine ancora l’aperta e non risolta questione del testamento biologico e dell’eutanasia: tutte prove lampanti di quanto la Chiesa sia, in questa eterna e mai conclusa Seconda Repubblica, più presente e più incisiva di quanto si possa credere; tutti sintomi preoccupanti di una laicità malata.

Attribution: Paolo Pedrotti
Sergio Romano, partito da una tradizionale disamina della questione, arriva a una conclusione chiara e senza mezzi termini, quella di una gerarchia ecclesiastica ancora molto legata (sue testuali e inaspettate parole) al “potere temporale”. Soffermandosi a rispondere alle domande che dal pubblico sono accorse numerose a lectio compiuta, a chi gli ha chiesto a tal proposito un’opinione sul nuovo Pontefice, Sergio Romano ha invitato a considerare come pure il Concilio Vaticano II, voluto da un papa innovatore, sia ancora in parte inattuato e, pur riconoscendo fondamentali elementi di novità nell’elezione del nuovo Papa, ha concluso con ironico scetticismo, affermando: “Si, anche le parole di Letta sono belle, come quelle di Bergoglio. Ora stiamo tutti a vedere”.
Articolo di Lorenzo Danesi