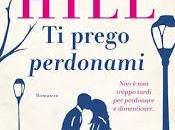A ben cento anni dal genocidio del popolo Armeno, ci ritroviamo a parlare e a ricordare un genocidio di una gravità e attualità fortissima. Questo ricordo deve diventare l’occasione per combattere ogni altra ipotesi di genocidio ovunque esso sia. Deve portarci a riflettere e a non accettare un’altra diaspora in atto oggi, quella Palestinese. Ricordandoci che tutto quello che succede oggi sotto ai nostri stessi occhi rimarrà sulla coscienza di tutti. Dobbiamo pensare con rispetto filiale a quel Paese, l’Armenia, che fu culla della prima e quindi più antica cristianità.
Il genocidio armeno può essere considerato il prototipo dei genocidi del XX secolo. Gli Armeni sono un popolo stanziato nell’Anatolia orientale. Essi hanno popolato l’Anatolia per oltre 3.500 anni. Oggi molti armeni si trovano sparsi per il mondo, alcuni nella repubblica armena (dove rappresentano il gruppo etnico di maggioranza) altri in Russia, Bulgaria, Siria, Iran, Stati uniti e Francia.
È un popolo lontano, di una tradizione millenaria, vissuto in una terra da sempre contesa, crocevia di popoli e culture, tra Asia ed Europa. Le radici storiche di questa popolazione sono antichissime, in origine già nel 93 a.C. gli armeni vivevano in Anatolia dove fondarono il primo impero armeno. Verso il 301 gli armeni erano il primo popolo a riconoscere il cristianesimo come religione di stato, prima ancora dell’impero romano. Queste radici antiche ed una forte compattezza etnica ha portato gli armeni a lottare sempre per salvare la propria identità contro il rischio di assimilazione, consentendo loro di elaborare una cultura unica ed originalissima. Gli armeni hanno una propria lingua e un proprio alfabeto e nel corso dei secoli hanno sviluppato una ricca tradizione culturale e intellettuale.
Ai confini dell’Armenia si sono sviluppati e succeduti nell’egemonia della regione grandi imperi: persiano, macedone, romano, mongolo e infine ottomano. Sono stati pochi e brevi i periodi in cui l’Armenia ha goduto di una incerta indipendenza politica. Insomma un piccolo popolo quasi sempre in minoranza con i potenti vicini. Nel XV secolo il loro paese viene annesso all’impero ottomano, un impero musulmano che all’apice della sua espansione si estese dal Mar Caspio fino alle porte di Vienna. L’impero ottomano è sempre stato un impero multiculturale, cosmopolita e tollerante verso il diverso. È un impero che ha una cultura secolare e un passato fiero e innegabile. Per esempio, furono i selgiuchidi (gli antenati degli ottomani) a salvare gli armeni caduti in loro dominio nel 1071, dalla persecuzione bizantina ed assicurarono loro il diritto di vivere come spetta ad un uomo.
Durante la prima guerra mondiale però questo impero con alle spalle una grande storia si macchia di quello che quasi tutti gli storici ed esperti internazionali definiranno poi uno dei peggiori genocidi della storia del mondo annientando quasi interamente la minoranza armena residente nel suo territorio. In totale vengono messi a morte più di un milione di armeni.
Tutto comincia nel XIX secolo.
Per i turchi è sempre stato importante quanto essenziale conservare una forte identità ottomana, essere armeni ottomani era lecito ma solamente armeni un tradimento. Verso la fine dell’ottocento gli armeni cominciano a chiedere istanze di riforma. Il sultano che era contro qualsiasi tipo di trattativa, si impegnò personalmente a impedire qualunque riforma che facesse perdere all’impero l’identità ottomana, allo scopo di un’indipendenza da esso. Così in risposta alle loro richieste di riforme politiche e sociali, nell’impero ottomano, ebbe inizio una netta persecuzione degli armeni, un’ondata di aggressioni contro essi. Un governo relativamente debole che per mantenere il controllo sulla popolazione locale imponeva la sua autorità attraverso massacri contro qualunque tipo di dissidenza.
Successivamente nel 1908 in Turchia sale al potere un nuovo movimento politico i giovani turchi, con un colpo di stato militare questa organizzazione spodesta il Sultano ottomano, portando l’esigenza imminente di un cambiamento ai fini del progresso dell’impero. Così furono apportate nuove riforme grazie ai giovani turchi positive e favorevoli anche per i cristiani dell’impero.
Però tra il 1912 e il 1913 le nazioni cristiane dei Balcani, come Grecia, Bulgaria, Serbia e Romania si ribellarono cercando di distaccarsi dall’impero e ottenere l’indipendenza, finché il tentativo non ebbe successo. Per la prima volta nella sua storia, il fiero e glorioso esercito ottomano subisce una sonora sconfitta, per mano di “sudditi dell’impero”. Perdendo la maggior parte dei propri territori in Europa, l’impero aveva paura di un collasso. Questo fu il fattore principale che ci può spiegare l’emergere nell’impero del nazionalismo turco.
L’Anatolia così era l’ultimo lembo di territorio rimasto ai turchi e doveva per questo difenderlo a tutti i costi. Ogni mezzo venne ritenuto giustificabile, in poche parole come insegnava il motto europeo “il fine che giustifica i mezzi”. In questo modo aumentarono le tensioni religiose ed insieme ad esse l’animosità verso i cristiani. In quel periodo il sentimento prevalente era la disperazione, più di 100 mila rifugiati musulmani dalla Grecia, dalla Bulgaria si riversarono ad Istanbul. Arrivavano in condizioni miserabili di estrema povertà, disperati per aver perso tutto, affollavano mosche, strade della città. Morivano di fame e l’impero ottomano non era in grado di aiutarli, si dice che i profughi provenienti dai Balcani avevano un numero pari agli abitanti della città.
Arrivati ad Istanbul, raccontavano delle attrocità orribili commesse dai cristiani nei loro confronti. Si diffuse fra il popolo l’idea che i cristiani volessero attaccare i turchi o addirittura sterminare i musulmani. Questa aiuta a spiegare il passaggio dai massacri di stato al genocidio. Il nuovo regime quello dei giovani turchi galoppavano la tragica onda e inneggiavano alla vendetta. Tutto questo nel 1913. Il movimento nazionalista prende il sopravvento sull’opinione pubblica con la scusa del ritorno alla vecchia gloria dell’impero e alla creazione di uno stato turco in Anatolia, di una regione turca per i turchi, dove far ristabilire tutti i profughi conseguenti all’indipendenza dei Balcani. Nasce così una propaganda nazionalista turca.
Quando nel 1914 scoppia la guerra fra la Germania e la Russia, la Turchia deve scegliere con chi allearsi. Ovviamente decide di farlo con la Germania e non con la secolare nemica Russia. Nel dicembre del 1914 i turchi attaccano la Russia subendo una grave sconfitta. La sconfitta è di nuovo dura, migliaia di morti, e le speranze di unificare l’impero vanno miserabilmente in fumo.
Nel contingente Russo, che avanzava verso la Turchia, non vi erano solo russi o armeni russi, arruolati con la leva obbligatoria, ma anche armeni fuggiti dalla Turchia per combattere al fianco dei Russi. Vedendo i loro stessi “sudditi” armeni combattere per il nemico, i leader turchi si infuriano e arrivano a considerare gli armeni ottomani come nemici dello stato. Tutto questo portò ad una cosiddetta assuefazione alla violenza, o meglio a una cultura della violenza giustificata.
Presto venne data loro la colpa della disfatta ai confini della Turchia. Cominciarono così, in tempo di guerra, massacri e stermini di massa degli armeni che sfociarono in deportazioni e poi nel vero e proprio genocidio armeno. L’ellite intellettuale armena viene assolutamente annientata e il governo autorizza le forze dell’ordine ad arrestare e deportare la popolazione armena. L’olocausto armeno portò alla soppressione di circa 2/3 della popolazione armena residente in Turchia. Circa 100.000 bambini vennero prelevati e allevati (dopo le deportazioni o i massacri dei genitori) da famiglie turche o curde, smarrendo così la propria fede e la propria lingua. Nel 1927 il primo censimento della Repubblica turca indicò che la popolazione armena ammontava a sole 123.602 persone.
Il governo Turco si rifiuta tuttora di attribuire a questi massacri lo status di genocidio. È innegabilmente un massacro di proporzioni assurde, indimenticabile ed è e rimarrà uno degli episodi più oscuri del XX secolo.
Ma importante è non mettere in discussione la tolleranza del popolo turco e capire che vi è una fondamentale differenza fra popolazione turca e il governo che ai tempi fomentava odio e ordinava violenza per scopi del tutto personali o per preservare un potere e un egemonia sul popolo.
Written by Amani Salama