«Ma penso che la mia solitudine
dovrebbe avere delle ali».

Nata a Buenos Aires il 29 aprile 1936 e morta suicida per un‘overdose di Seconal il 25 settembre 1972, Pizarnik ha messo alla prova la vita, usando come strumento la parola. Nel periodo di più grande affermazione dello strutturalismo, Alejandra ne esplora il manifesto, benché con evidente distacco e con grande originalità espressiva. La realtà ruota attorno al linguaggio, il respiro è parola, la verità è nel testo. «Cosa significa tradursi in parola?» declamano i suoi versi (Estrazione della pietra della follia, 1968). Il quotidiano ha bisogno di essere espresso liricamente, di vedersi verbalizzato. Le parole diventano frammenti di un discorso intimo, in cui la sensibilità cerca e trova la propria dimora nell’orazione lirica, al punto da divenire l’unica possibilità di vita.
«Mi nasconderò nel linguaggio» (Cold in Hand Blues, L’inferno musicale, 1971) recita la sua poesia, a dimostrazione dell’esigenza intrinseca della poetessa argentina di cogliere la dimensione vitale nell’espressione verbale, nel linguaggio che si fa e fa la poesia. Si parlava di strutturalismo, ma il nesso va considerato con cautela. Benché difatti Alejandra dedichi un’attenzione notevole alla parola, tuttavia la sua ricerca lirica s’appresta a un surrealismo dai contorni sfumati e imprecisati.
I suoi versi sono allora brevi, immediati e siderali – aggettivo che a più riprese compare sia nelle poesie che nei diari. È soprattutto a partire del 1964, data che vede la Pizarnik di ritorno in patria dopo un soggiorno durato quattro anni a Parigi, che la sua produzione poetica si accresce, con la pubblicazione delle raccolte I lavori e le notti, Estrazione della pietra della pazzia, L’inferno musicale e di un testo in prosa, La contessa sanguinaria. È, però, solo nella poesia e nei diari che Alejandra trova e sviluppa le proprie capacità espressive. Sebbene spesso nei suoi scritti faccia allusione al desiderio di redigere un romanzo, la sua forma espressiva rimane prettamente lirica.
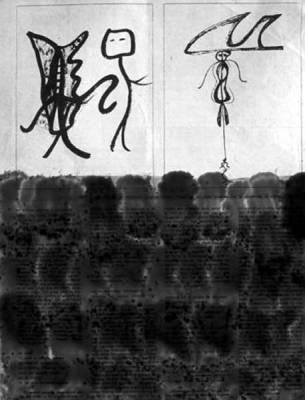
Quella che Pizarnik inscena nei suoi testi è, allo stesso tempo, una lotta per la vita e per la morte. La morte, infatti, incarna l’arché dei suoi versi, una delle tematiche che ricorre con maggiore frequenza, reiterata, ossessiva, tautologica immagine che diventa il filo conduttore del discorso lirico. La morte trova il correlativo oggettivo nella notte, nelle insonnie che perseguitano la scrittura e ne rappresentano la ragione stessa. La Pizarnik ci lascia, quindi, un corpus lirico che rivela pochi ma sintomatici leitmotiv: la morte, la notte e il silenzio interiore.
Al di fuori della scrittura, invece, vige il deserto. Ne sono una prova le pagine del suo diario, tragicamente autobiografiche, tragicamente ripiegate su loro stesse. Non vi sono, infatti, eventi. Pochi sono gli incontri descritti. Gli amori sono raccontati puntualmente nella loro impossibilità. La solitudine divampa nelle pagine che ispessiscono il sentimento di perdita, d’abbandono abissale. Il vuoto chiama tuttavia la materia, che diventa desiderio irraggiungibile e mette in scena la semantica dell’incompiuto. Sembra questa una delle ragioni più plausibili per le quali la poesia di Pizarnik si vorrebbe materiale, fisica, a tratti addirittura animale. Probabilmente poiché è l’unica in grado di esistere, la sua poesia manifestandosi come un surrogato di una vita che non riesce a trovarsi. Materia, quindi. La parola, in Pizarnik, si vuole statua, si vuole pietra.







