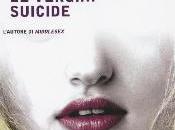mi piace quest’articolo, lo ritaglio e lo incollo…
Se Non Ora Quando
QUALCOSA NON VA NEL “MASCHILE”. E NEL “FEMMINILE”Dietro alla tragedia del femminicidio: il problema è che le immagini di uomo e di donna a cui siamo abituati non funzionano più.(Franca D’Agostini, La Stampa)
Helene von Druskowitz, filosofa austriaca dell’Ottocento, morta in manicomio dopo aver scritto opere geniali e stravaganti, come il Vademecum per gli spiriti più liberi. Proposizioni cardinali pessimistiche, così descriveva «il maschio»: «micidiale per attitudine, violento e invidioso, generatore di guerra, amante del potere, ottuso distruttore della natura e di se stesso». Dal punto di vista di Von Druskowitz tutti i problemi dell’umanità si riducono a uno solo, e semplicissimo: il rissoso individuo ha preso possesso della storia umana, e sta portando rapidamente l’umanità alla rovina. Brillante provocatrice, un po’ come Nietzsche (che conobbe), la von Druskowitz era omosessuale, e principalmente per questo trascorse in manicomio vent’anni della sua vita. Ma era paziente «tranquillissima», dissero i medici; e in fin dei conti oggi si direbbe sanissima, visto che l’unica sua malattia era a quanto pare la «misandria», l’odio per il maschio.
Non c’è bisogno di raggiungere gli eccessi della von Druskowitz per riconoscere che nel «maschile» c’è qualcosa che non va. E correlativamente qualcosa non va nel «femminile» così come si è configurato e modellato, nella prospettiva del maschile. E quel che non funziona, beninteso, non sono gli uomini e le donne, ma appunto il maschile e il femminile, vale a dire: quel che gli uni e le altre si aspettano e devono aspettarsi dal loro essere nel modo in cui si suppone siano.
È questo in definitiva il problema di fondo da cui si genera il fenomeno del «femminicidio». La diagnosi non è difficile: il problema è che le immagini di «uomo» e di «donna» a cui siamo (specie gli uomini) abituati non funzionano più, e a contatto con le nuove realtà esplodono e si traducono in follia. Come notano Loredana Lipperini e Michela Murgia, in L’ho uccisa perché l’amavo: falso! (Laterza 2013), l’amore non c’entra nulla, la vera spiegazione è: «l’ho uccisa perché metteva in crisi la mia immagine di maschio possessore e dominatore». E in Se questi sono uomini, Riccardo Iacona (Chiarelettere 2012) lascia vedere molto bene, ri-narrando i diversi femminicidi, che per lo più le donne uccise erano donne brave, forti, e gli uomini erano deboli, senza lavoro, umiliati nella loro difficoltà di essere «maschi». La malattia si è rivelata dunque in tutta la sua chiarezza. Ed è chiara anche la soluzione. Come hanno ribadito di recente Laura Boldrini su Repubblica, Lorella Zanardo sul Fatto, Simonetta Agnello Hornby sulla Stampa, i provvedimenti devono muoversi in due direzioni: sul piano istituzionale (creando leggi, e aggravanti «di genere»), e sul piano culturale: modificando la visione del maschile e del femminile che ancora circola nelle nostre menti, e nelle immagini propagate dai media.
La direzione numero due è la più profonda e radicale. Ma resta un dubbio. Che cosa mettiamo, esattamente, nelle «nuove» immagini che dobbiamo diffondere, insegnare, difendere? Chi siamo? Siamo diverse, e siamo meglio degli uomini, come ritiene Luisa Muraro ( Non è da tutti, Carocci 2011)? Siamo uguali, se non altro siamo umane come gli altri umani, come dice Catharine MacKinnon ( Le donne sono umane?, Laterza, 2012)? Soprattutto: siamo come erano le nostre madri-nonne, e le nostre figlie-nipoti sono come noi, per cui funzionano le stesse teorie, e gli stessi programmi?
Il ripensamento dell’identità femminile (e maschile) è uno dei compiti primari della filosofia politica femminista. Però, proprio su questo punto, la filosofia oggi è raramente ascoltata, e quel che è peggio fatica a trovare una vera convergenza. Sopravvive la vecchia ruggine che ha sempre percorso la storia del femminismo, tra differenzialismo (le donne sono diverse, e deve essere valorizzata la loro differenza) ed egualitarismo (le donne sono uguali, e deve essere difesa la loro uguaglianza). Sopravvive anche la disputa metodologica: c’è chi ritiene che il «pensiero femminile» da valorizzare e difendere sia pensiero contrario a ogni teoria generale, e forse a ogni teoria, e chi tenta una riconsiderazione fondamentale del problema, a partire da una prospettiva universalista.
Il libro di Nadia Fusini, Hannah e le altre (appena uscito da Einaudi) offre un modo ingegnoso per ripensare l’intera questione, forse proprio perché narra di tre autrici non femministe, ma che hanno evidenziato alla perfezione, come dice Fusini riprendendo Virginia Woolf, «the woman’s angle», il punto di vista femminile. Il libro racconta lo sfiorarsi dei destini di Hannah Arendt, Simone Weil e Rachel Bespaloff: unite non soltanto dal fatto di essere ebree, filosofe ed esuli a New York, ma anche da incontri fortuiti, strane coincidenze; e soprattutto: da un’affinità di pensiero che mette in luce le ragioni del loro essere donne in un modo diverso da come si suppone si debba essere donne.
Lo stile di Fusini, magistrale nelle biografie, consente di vedere all’istante il nucleo essenziale di ciascuna figura, restituendone il pensiero dominante con rapidi accenni concreti. Simone Weil viene sedotta alla teoria e alla pratica della vita difficile dalla fiaba che le racconta sua madre, nel dormiveglia di bambina febbricitante. Hannah Arendt, a cui manca il «tatto del cuore», come le rimproverano Scholem e il suo maestro Jaspers, ha nell’animo «socratico» «un’ironia pungente, che sconfina nell’arroganza». Meno nota la biografia di Bespaloff, musicista e filosofa, afflitta da incombenze famigliari che la imprigionano e la portano al suicidio. Fusini sottolinea la convergenza delle tre posizioni: nell’avversione per la violenza, nell’interesse per i greci e per il Cristianesimo. Tutte e tre sono dotate dell’«altro sguardo»: ma la peculiarità di questo sguardo non è legata a oscuri fattori biologici, e neppure a un «femminile» benevolo e antiviolento. È piuttosto lo sguardo di chi è «senza potere», ed è tanto più evidente in tre personaggi così tipicamente deraciné, sradicati, e capaci di tradurre lo sradicamento in teoria.
Ecco dunque il punto cruciale: le tre autrici partono dall’umanità, dunque da una prospettiva «neutra», e senza genere; ma nelle loro voci si rivela all’istante «l’altro sguardo». La «differenza» affiora, inequivocabile, nel momento stesso in cui il discriminato inizi a parlare, e parli onestamente, a partire dal suo avvertirsi «straniero». Ma se dobbiamo tenere conto di questo, la risposta alla domanda «chi siamo? » cambia radicalmente. Essere donne significa anzitutto un modo particolare (migliore) di essere esseri umani: il modo di chi, uomo o donna che sia, non ama il potere. E in questo senso, come Von Druskowitz, non ama «il maschio».