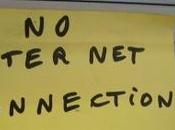Babbo malato
Babbo malato
Un filo invisibile a mezz’aria mi guida lungo il marciapiede, prendo a calci un barattolo che rotola fin sopra un tombino. In mezzo alla strada ragazzi rabbiosi urlano odio e scagliano pietre verso ragazzi in divisa.
Lo stomaco ruggisce, a ogni zaffata la testa gira e le bottiglie di plastica ingiallita popolate da blatte brulicanti prendono vita e mi ruotano attorno, a spirale. Sì, è profumo di pasta dolce, la fiuto come un segugio, e la scia mi porta in un vicolo traverso che mi allontana dalla folla, che avranno poi da gridare, un topo mi si infila tra i piedi e mi tuffo per prenderlo, ma schizza via e non riesco a bloccarlo.
Una fitta al polpaccio, sollevo il brandello di jeans, dannazione, la crosta si è rotta. Prendo a schiaffi l’aria. «Fottuto sorcio! Ci aveva messo due settimane ad asciugare, maledetta infezione.»
Mi piego sulle ginocchia e porto le mani alla faccia; la schiena, appoggiata al bidone, striscia in basso finché non mi trovo col culo per terra. Lo stomaco ulula quando sento di nuovo il fragrante richiamo. Mi rialzo, lo inseguo. È forte, è intenso, è buono, ricopre del tutto il puzzo di piscio che infesta il cavallo dei miei pantaloni. Un prurito urticante mi assale, infilo la mano e mi gratto. Le unghie sfregano l’inguine, l’interno coscia, il fianco. Dannate piattole. No, devo trattenermi, se no dopo è peggio.
Poi la zaffata, la inseguo, come un pesce all’amo. Mi ritrovo in un vicolo chiuso tra alti muri spogli e scrostati, testimoni infelici di mille stupri; la folla non si vede più, anche se posso sentirne l’odore di bile, che sovrasta i miasmi dei bidoni fumanti e allineati come a indicarmi la via, e il lezzo infetto dei miei vestiti. Ma non quel delizioso profumo, quel canto di sirena, che mi attrae come fossi il più audace degli Odissei.
Ancora una svolta, una finestra socchiusa, a ghigliottina, gli infissi chiari tra mattoni scuri, una tenda gialla, la leggera melodia diffusa di un vecchio fonografo. Mozart. Artiglio il battente e lo sollevo, non oppone resistenza, il tepore m’investe come un’onda di speranza; non riesco a trattenermi, infilo la testa e mi tuffo all’interno.
La stanza è accogliente, quanto tempo che non provo tale famigliare domestica ebbrezza. Dentro uno sbiadito schermo un disco gira in bianco e nero suona gli archi e sbuffa sui fiati; la torta, fumante, mi attira dal tavolo, come una calamita la polvere del ferro.
Le dita affondano nella pasta, la bocca si riempie, avida, mi sento male per il piacere, buttò giù bocconi con la foga di uno squalo. Strappo, mastico, sputacchio qualche briciola, tossisco, mezzo affogato.
Bere, devo bere.
Una caraffa sul top della malandata cucina, l’acchiappo e me la ficco in gola ignorando il bicchiere vuoto, il rigurgito mi lava la faccia. Ansimante, mi siedo sul divano. Un rumore cartaceo, infilo la mano sotto il sedere, tasto, trovo la lettera. La leggo:
Caro Babbo Natale,
per piacere, vorrei che portassi quella bottiglia di Giac Daniel per il mio papà, che ogni volta che apre l’armadio e non la trova poi deve andare per strada a cercarla e mi lascia solo con la mamma, che io non ce la faccio a tenerla su quando le viene da cadere e poi finiamo tutti e due per terra e non riusciamo più a rialzarci.
Per piacere, vorrei che portassi tu quelle caramelle che prende lei, perché quando viene quel signore con la valigetta e gliene dà una scatola poi lei non cade più, fino a quando non le finisce, solo che è da un po’ di tempo che lui non ci viene a trovare. La mamma dice che in giro non ce ne sono più, quindi ti chiedo se le puoi portare tu, che sei così buono.
Io per me non voglio nulla, anche se la mamma dice che avrei bisogno anche io delle mie, perché ogni tanto mi manca il respiro, ma poi passa, quindi stai tranquillo.
Ora vado a dormire, lascio la finestra aperta, la TV accesa e la torta che ho preparato per te, mangiala pure tutta, io non ho fame. Ti voglio bene.
Guardo ciò che è rimasto del dolce, la testa gira. Riesco solo a disprezzarmi. Fuori, la folla si avvicina, rumore di vetri infranti, esplosioni, grida selvagge. Mi si svuota la vescica, una chiazza umida si allarga sul divano. Una porta si apre.
Un bimbo di circa sette anni, avvolto in un pigiama a righe più grande di lui, si stropiccia gli occhi e mi osserva pieno di speranza. «Sei Babbo Natale?»
«Vieni qui» gli dico io. Lui si avvicina, esitante. Gli accarezzo una guancia. «No», gli faccio, «ma forse è proprio lui che mi ha mandato.»
Metto mano al portafogli e tiro fuori quel biglietto per la Città di Sopra che non ho mai avuto il coraggio di usare. Non ci sono tagliato, dannazione, quel mondo non fa per me. E poi… sono malato, non ho speranze, che ci vado a fare.
Ma forse… Gli stringo il biglietto nelle mani. «Dallo a tua madre», gli dico, «mi raccomando, non lo perdere.»
Lui mi guarda come se fossi la cosa più bella che gli sia mai capitata, mentre io mi infilo di nuovo nella finestra.
«Ciao, Babbo Natale» sento dire un attimo prima di lasciarmi cadere di fuori.
Il racconto che avete letto è opera di Kapello ed è risultato il migliore tra quelli che hanno partecipato al Laboratorio di Dicembre 2013. Il tema da seguire era stato scelto da Jonfen (vincitore del Lab di Novembre dello stesso anno).
La traccia scelta da Jonfen era: Caro Babbo Natale…
Il genere era libero e il limite di caratteri era di 5000 (spazi inclusi). Unico obbligo: il testo doveva contenere una lettera a Babbo Natale. Il racconto poteva anche essere composto solo dalla lettera a Babbo Natale.

kapello
Chi sonoScribacchino in erba, sperduto nel cemento di una metropoli carente di clorofilla, ballatore legnoso, ben più di un ramo brullo, ingenuo idealista.