Enrico Marià, Cosa resta, puntoacapo editrice, Pasturana, 2015.
Recensione di Lorenzo Spurio
La vita è morte che avanza. (69)
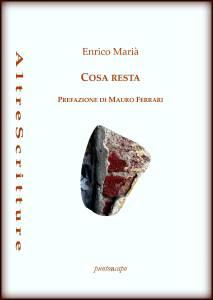 Cosa resta è il titolo della recente silloge di Enrico Marià edita per i tipi di puntoacapo editrice. Il potenziale lettore si introduce nel percorso costituito dalle varie liriche del libro con un rovello iniziale: quella condizione di residualità, di scarto a cui il titolo vuole riferirsi.
Cosa resta è il titolo della recente silloge di Enrico Marià edita per i tipi di puntoacapo editrice. Il potenziale lettore si introduce nel percorso costituito dalle varie liriche del libro con un rovello iniziale: quella condizione di residualità, di scarto a cui il titolo vuole riferirsi.
La poetica di Enrico Marià, livida al punto tale da sprofondare nei toni meno lucidi, rifiuta la dimensione melensa e retorica del mondo per arginare i dilemmi e le problematiche del vivere mediante un linguaggio estremamente vivido e incalzante, con l’impiego di una sintassi spesso a-poetica e più in linea a un raccontare in prosa, alla cronaca propriamente detta.
Nella libertà del verso che Marià adotta è svincolato, così, dal tracciare sulla carta –quasi come un estemporaneo taccuino di un’esistenza travagliata- momenti di angoscia e depressione, vedute ciniche dinanzi a un mondo dove la miseria e la debolezza sembrano far da padroni.
L’universo del disagio esistenziale ben riconducibile al cancrenoso fenomeno della droga si ravvisa in un gran numero di componimenti, quasi una catena di episodi cruciali che hanno significato delle vere e proprie discese a baratri più o meno fondi, più o meno privi della luce del giorno.
La citazione in esergo di Vittorio Sereni ben traccia il tragitto che Marià intende farci fare con la restituzione di fotogrammi di momenti di delirio e di asfissia della ragione, in momenti di vita vissuti tra un incalzante abbandono sociale e una frenetica, ripiegata fuga da sé stessi. L’impossibilità della definizione spazio-temporale dell’uomo, la sua indicibile fisicità, la scivolosa immanenza nel Creato sono, per dirla alla Sereni, una condizione di impossibilità che, in quanto tale, grava ancor più sull’uomo provocando o incrementando un fiaccante senso di imperscutabilità, inettitudine e di impermanenza.
Il linguaggio, come si è già detto, è assai istintivo e iconico, fotografico e dolente, a trasmettere le scene di una domesticità che non si vive nel calore di una famiglia o nella rassicurante compagnia di persone amiche, piuttosto è l’assordante e inclemente periferia, quale spazio di per sé difficilmente mappabile e vivibile e dove lo scempio, la sregolatezza, la devianza si compiono e prolificano.
La sensazione più forte che si prova dinanzi a tale opera di Marià – che, pure è attento in una nota finale al libro nell’asserire: “l’empatia nei confronti di un forte e universale sentire declinato in fatti appartenenti ad uno spaccato di mondo che ho visto, respirato, toccato, conosciuto” – è quella di sentirci continuamente in balia di un vento freddo che ci scompiglia i capelli, ci infastidisce e non ci dà tregua. Non è tanto il freddo a pungere e a rappresentare l’elemento di fastidio maggiore, piuttosto è lo stesso sommovimento dell’aria che, puntualmente, ci fa barcollare, distogliere le attenzioni, che ci obbliga a ricevere gli influssi di queste ondate impetuose.

Enrico Marià, l’autore del libro
Nelle liriche di Marià troviamo quasi sempre la vita fronteggiata alla morte, le due vengono spesso citate in antitesi, altre volte l’una contiene l’altra in maniera infingarda e totalizzante come quando asserisce “la morte è l’unica vita/ che io conosca” (15).
Il messaggio che sembra provenire da simili lapidari versi, mai idilliaco e nemmanco speranzoso, incrementa ancor più quel senso di tormento dell’io lirico che sperimenta una condizione di anomalia esistenziale, automatismo, nichilismo e vero e proprio vittimismo indotto.
Perplessità e una vaghezza ampia di sentimenti coinvolgono l’io lirico nei confronti del genitore paterno, figura a tratti assente a tratti descritta come odiosa, a rappresentare un continuo duello psicologico tra negazione e desiderio di riconoscimento.
Marià, come un arcano premonitore, avverte la vita morente e passata che si vive al presente, ne dà manifestazione, l’attesta, vi riflette, conscio che la morte non sia un episodio ultimo che riguarda la dimensione celeste, ma un qualcosa di abituale che riguarda chi, proprio come ciò di cui lui scrive, ha un percorso accidentato, che svia verso la perdizione, che fa difficoltà a immettersi in un cammino meno problematico. La morte sta nell’errore che si compie senza avvedersene, sembra dirci il Nostro così come la violenza non è l’adozione di un comportamento irruento e manesco, istintivo dinanzi a sé stessi o al mondo, ma è esso stesso una via salvifica (pur nel paradosso) per risparmiarsi ulteriori tribolazioni. Non va dimenticato che la poesia è sempre qualcosa di molto personale e che diventa difficile poter dare un giudizio critico, obiettivo e pacato, dinanzi alla lettura di un testo che contiene in sé un percorso esistenziale, morale ed educativo che ha una sua genesi e sviluppo. Dinanzi alla dicotomia incalzate di morte-vita, di disperazione ineluttabile e di tranquillità il Nostro sembra focalizzato maggiormente a concettualizzare il complesso che fa riferimento a un inabissamento delle possibilità sebbene non manca di gettare un disperato SOS che, in mezzo a tanto deperimento morale e dissipazione esistenziale, va sicuramente colto: “Mi piacerebbe scegliere la vita” (34).
Tra rincorse verso illusori paradisi artificiali, abusi di droghe e difficili riscatti, indigenza e ripiegamento su sé stesso, il Nostro lancia il suo disperato e pure indefesso “grido della carne” (55) scoraggiato da una verità pesante come un macigno che innalza “la morte [a] unico riparo” (57) dando sfoggio a un inesauribile spirito apollineo che incalza con nettezza ogni tentativo di riparazione, rivincita e di sana resilienza.
Per accentuare il tono di asprezza e la netta composizione di spiriti di morte, Marià impiega un linguaggio preso in prestito alla politica parlando di “dittatura della vita” (62) e di “fascismo della bellezza” (67) costruendo definizione quanto mai ricche e dense nelle loro possibili accezioni nell’analisi esegetica.
L’abbiamo già detto, quella di Marià è una poetica ventosa. Non fumosa, vacua, leggera né sospesa. È il prodotto di un sommovimento impetuoso che coinvolge l’io lirico, una sorta di fenomeno shock dove l’onda d’urto, ancor meglio che da un punto di vista contenutistico, è data da quel verso secco e tagliente, insindacabile e imperituro, di una asciuttezza seriosa ed intemperante. Non il vento luziano, nemmanco quello verde di García Lorca, ma refoli che ostacolano ma al contempo instillano coscienza.
Jesi, 11-03-2016
