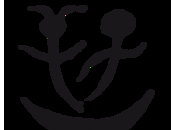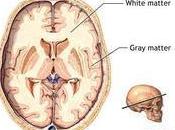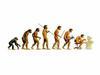Risale a questo ottobre 2012 alla Frankfurter Buchmesse il rapporto dell’Associazione Italiana Editori riguardo allo stato generale dell’editoria nel Bel Paese. Nello sconforto generale che ha visto il mercato del libro italiano calare di un 8,7% rispetto allo scorso anno e vantare una percentuale di lettori tra le più basse rispetto a quelle degli altri “big” europei (Gran Bretagna, Francia e Germania), un dato è sembrato però rincuorante, quello legato allo stato dell’editoria digitale: più di mezzo milione di persone in Italia sono i lettori abituali di ebook, una percentuale che dallo scorso anno è aumentata al 2,3% della popolazione.
Risale a questo ottobre 2012 alla Frankfurter Buchmesse il rapporto dell’Associazione Italiana Editori riguardo allo stato generale dell’editoria nel Bel Paese. Nello sconforto generale che ha visto il mercato del libro italiano calare di un 8,7% rispetto allo scorso anno e vantare una percentuale di lettori tra le più basse rispetto a quelle degli altri “big” europei (Gran Bretagna, Francia e Germania), un dato è sembrato però rincuorante, quello legato allo stato dell’editoria digitale: più di mezzo milione di persone in Italia sono i lettori abituali di ebook, una percentuale che dallo scorso anno è aumentata al 2,3% della popolazione.
Entusiasmante. Quasi si sarebbe portati a immaginare un normale vagone di tram in una normale giornata lavorativa con i passeggeri abituali che, anziché quotidiani stropicciati e brossure usa e getta, fissano eleganti scatolette nere sfiorandole ogni tanto con le dita. Il fatto è che l’entusiasmo da percentuali vale poca cosa, e la scena descritta rimane per ora solo un sogno (o un incubo, per taluni), perché l’Italia resta de facto uno dei mercati del libro forti dove gli ebook hanno meno peso in assoluto. Ma anche se si prendessero in esame gli USA, dove gli ebook hanno raggiunto quota 25% del mercato del libro, una constatazione generale indugia comunque testarda oltre il buzz dei pronostici editoriali: è da tempo che gli analisti del mercato ripetono che in pochi anni l’editoria vedrà la fine della carta stampata. Ogni anno però siamo sempre qua, a leggere le nostre brossure e – possibilmente su tablet – gli articoli millenaristici sulla fine della carta, a partire esattamente dal prossimo anno.
Attenzione, questa non vuole essere una riflessione da stadio pro/contro ebook/carta e viceversa. Credo che chiunque – addetti ai lavori e non – si fermi a fare il punto della situazione sullo stato della digitalizzazione dei contenuti dell’industria editoriale possa arrivare a una conclusione evidente: il fallimento di ogni approccio manicheo all’analisi del problema.
Ebook: pericolosa tecnologia Cylon venuta a mettere fine al libro di carta e alla lunga e nobile tradizione della sua produzione, trasformando il lettore in un utente connesso in contemporanea a decine di social network e privato dell’autentica e solitaria esperienza della lettura e della pienezza del contatto con l’artefatto materiale – non più venduto nelle librerie ormai morte; oppure ebook come la definitiva liberazione dalla tirannia della cellulosa, pesante, scomoda, environmentally-unfriendly, costosa nonché la reale causa della lentezza di diffusione della cultura del libro.
Posizioni emotive, queste, legate spesso agli interessi dei singoli attori della catena del libro (lettori in primis) e del come lo vorrebbero vedere nel prossimo futuro. Il mercato però è un sistema complesso, e come tale si nutre anche di contraddizioni e paradossi. Uno di questi è proprio quello che vede l’Italia – la cui editoria ancora è composta da un microcosmo di piccole-medie case editrici indipendenti – negare (volontà attiva) o scoraggiare (blocco “ideologico”) le enormi possibilità del digitale. Da una parte si invita alla crociata contro il Mercato, il mostro dei grandi gruppi a caccia di best-seller spazzatura, quello che fa il gioco delle catene di distribuzione e fa fallire gli editori indipendenti; dall’altra ci si dimentica che la componente strutturale che permette queste disfunzioni è esattamente l’enorme limite del sistema distribuzione in sé, che in Italia più che altrove non è capillare per ragioni logistiche e di difficoltà del territorio ed è elitario, nella misura in cui i grandi pesci fissano l’entrata in gioco a prezzi che quelli piccoli non si possono permettere.
Questo perché? Esattamente perché il libro di carta è materiale. Un’ovvietà di cui spesso ci si dimentica di analizzare le conseguenze. Il libro è un oggetto prodotto in luogo A che dev’essere portato fisicamente in X altri luoghi per adempiere alla sua funzione sia di mercato che culturale; un oggetto che in questi luoghi deve trovare spazio fisico a discapito di altri oggetti della stessa natura: una responsabilità, un costo e un rischio per tutti gli addetti ai lavori e una condizione intrinseca di forte competizione tra le parti in gioco (si rilegga la “Long Tail”, Chris Anderson; 2004).
Perché dunque l’Italia e la sua miriade di piccoli editori talvolta operanti in territori logisticamente svantaggiati, tagliati fuori dalla grande distribuzione libraria e a cui i gradi venditori online non prendono i libri in conto deposito, non si butta a capofitto su una tecnologia e una nuova cultura del libro che gli permetterebbe di ignorare tutta questa serie di costrizioni fisiche che de facto li emargina dal mercato su larga scala o dalla semplice minima circolazione del proprio prodotto? Possibile che non si consideri l’offerta come generatrice della domanda? Che si difenda a spada tratta l’utilizzo esclusivo e testardo della carta in un paese con storici e cronici problemi di analfabetismo, dove l’allargarsi della cultura della lettura sarebbe da celebrare anche se avvenisse tramite graffiti sui monumenti? Che non sia in realtà il desiderio di rimanere una élite culturale ristretta il vero motore inconscio della ritrosia da parte dei canali tradizionali di fare editoria nei confronti del digitale, e questo atteggiamento non sia in fondo la vera ragione che causa gli scompensi di cui però ci si lamenta? Affascinante.
Di contro, incredibile sembra che i promotori del “da ora in poi solo digitale” non considerino che lo spacciare il cambio di supporto come un mero cambio di scatola per un contenuto, è una chimera. È paradossale che le implicazioni semiotiche del concetto di paratesto siano così ignorate dai tecnici della rivoluzione editoriale. Nessuna “scatola” è un canale espressivo neutro rispetto al suo contenuto. Il mezzo tramite il quale un messaggio raggiunge il ricevente diviene parte integrante del significato del messaggio stesso (in Linguistica: diamesia). Le dinamiche per cui un testo è percepito in un modo piuttosto che in un altro, apprezzato in un modo piuttosto che in un altro, desiderato, non si risolvono nel rapporto univoco tra lettore e parole lette, ma travalicano in quell’infinità di varianti contestuali rappresentate dal come il testo raggiunge il lettore. Leggere un ebook non è la stessa cosa che leggere un libro cartaceo, esattamente come leggere un libro cartaceo non è la stessa cosa che leggere un ebook. Leggere un libro prima in cartaceo, poi in digitale, non è un atto semioticamente equiparabile, e darebbe vita a due esperienze di lettura differenti anche se riguardo allo stesso testo. Il lettore è una macchina di emozioni complessa, complesso è il suo rapporto con i contenuti culturali e con i supporti tecnologici (che sono di per sé cultura). E la complessità si nutre di paradossi.
Se tutte le rivoluzioni tecnologiche dell’animale homo sapiens sapiens avessero un filo logico e il nostro scegliere una tecnologia piuttosto che un’altra fosse un solo freddo calcolo di “comodità” secondo ideali criteri oggettivi, non staremo qua a scrivere il nostro molto rumore per nulla firmato Web 2.0 con tastiere di tipo QWERTY, ovvero la combinazione di lettere più lenta e irrazionale che potesse mai essere studiata da un progettatore di tastiere, datata 1873 e così apposta perché, mettendo vicine tra loro le successioni di lettere più comuni nelle lingue romanze e germaniche, gli scrittori cliccavano i tasti troppo in fretta e le macchine si inceppavano (Diamond; 1997). Ci sono gli ebook, ma scriviamo ancora a pedali e non abbiamo intenzione di cambiare.
Digital back-thoughts: forse, anno dopo anno, anziché giocare a fare i Nostradamus e i contro-Nostradamus del nuovo mercato del libro, si potrebbero considerare finalmente gli ebook come la pacifica ovvietà che sono: un mercato “complementare” e non “sostitutivo”, per l’unico bene del leggere. Fare più cose insieme anche se apparentemente in contraddizione tra loro: molto umano e più che normale, come anche l’incapacità di accettarlo.
Media: Scegli un punteggio12345 Nessun voto finora