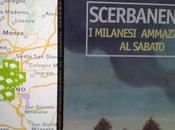Federico De Roberto
Ci siamo già occupati di De Roberto (nato a Napoli il 16 gennaio 1861, morto a Catania il 26 luglio 1927) scrivendo de “I Viceré” nel libro “Generazioni a confronto nella letteratura italiana”, uscito per Marco Valerio editore nel 2006.
“Ermanno Raeli” precede di cinque anni “I Viceré”, considerato il suo capolavoro, e fa seguito ad una raccolta di poesie, “Encelado” del 1887, e due raccolte di novelle, entrambe uscite nel 1888: “La sorte” e “Documenti umani”. La prima edizione di “Ermanno Raeli” riporta la data della sua ultimazione: “Autunno del 1887”.
In occasione della ricorrenza del ventennale dalla morte, uscì su “Il Mattino di Sicilia” del 3 agosto 1947 un articolo intitolato “Federico De Roberto”, a firma di Francesco Geraci, nel quale, circa la personalità dello scrittore, si legge: “Egli apparteneva al valido manipolo dei più personali scrittori italiani del secondo Ottocento – il gran secolo della nostra civiltà – Scrittori di primo piano, robusti e delicati, insieme, che erano anche degli aristocratici nel pensiero, nel costume e nella vita: Verga, De Roberto, Capuana, Bracco, Praga, Pirandello, Fogazzaro, Rovetta, Fucini, Zuccoli, e due donne, la Serao e la Deledda. Romanzieri, novellatori e autori drammatici che riscattarono il romanzo e il teatro dal servaggio straniero.
… [De Roberto] trascorse tutta la sua vita a Catania da dove, di tanto in tanto, si assentava per andare a trovare a Milano gli amici delle comuni prime battaglie d’Arte. Ugo Ojetti, che lo conobbe nel 1894 a Milano – e proprio alla vigilia di pubblicare «I Viceré» – così lo descrive: «È un giovane di appena trent’anni, bruno, elegante, ha il monocolo. Parla con accento siciliano… in questo mio soggiorno egli è stato uno dei tre o quattro compagni più cortesi e più cari e più assidui… De Roberto mi dice: «Il lettore che apre un libro per leggerlo e non per anatomizzarlo e criticarlo, in tutti i moderni romanzi, specialmente nei romanzi così detti psicologici, ritrova sempre presso a poco la stessa cucina, lo stesso tema, e se ne annoia: e dal suo punto di vista ha ragione. Quindi io credo che non vi sia salvezza che nel romanzo di costume e il romanzo che sto per pubblicare è un romanzo di costume: «I Viceré».
[...] Al contrario (di Verga. bdm), De Roberto più si avvicinava al turbinoso vivere mondano e più sentiva il bisogno di isolarsi per trovare e sviluppare gli elementi essenziali alla sua opera. Egli era uno studioso. L’isolamento dalla vita effimera gli aveva permesso di farsi una cultura, vasta, solida, organica e profonda, letteraria e filosofica. Questa preparazione culturale lo rendeva spesso alquanto scettico al momento di terminare un romanzo. Egli si sentiva sempre perplesso di fronte al pubblico. Sentiva – forse esageratamente – la grande responsabilità dell’opera d’arte. Ecco perché il nostro romanziere possiede la speditezza e la disinvoltura del Verga, la incomparabile e piana semplicità del Capuana, e qualche volta può anche sembrare monotono. Perché il De Roberto è sempre preoccupato, e la sua analisi psicologica meticolosa, rigidamente pensata, e controllata, al pari dello stile che egli cura con una pazienza da umanista, riflette appunto la personalità dello scrittore.”
Parole che valgono tanto per “I Viceré”, quanto per “Ermanno Raeli”.
Il quale Ermanno Raeli, piccolo di statura, ma non brutto, “di salute malferma e cagionevole fino all’adolescenza”, nel suo carattere paga lo scotto di essere figlio di padre siciliano e di madre tedesca, per cui in lui agiscono due personalità diverse, che lo rendono indeciso in tutto, perfino nel parlare giacché gli si presentano sempre alla mente i due differenti modi di esprimersi nelle lingue che conosce: l’italiano e il tedesco: “Di qui, una difficoltà di rendere con evidenza molte impressioni, di definire precisamente molte idee, e particolarmente una mancanza di carattere e di colorito nel suo dire.”
Il narratore ci racconta dell’incontro avuto con questo personaggio, che lo interesserà a tal punto da seguirne la vita: “A poco a poco, riuscii a conquistare la sua intimità, a leggere in quell’anima ed a comprenderne i modi d’essere e di sentire.”
Ermanno vive un dramma che appartiene, è appartenuto e apparterrà a chissà quante generazioni: “Ciò che mi aveva detto circa le intenzioni poetiche delle quali era pieno e l’inattitudine all’espressione, aveva particolarmente attirata la mia attenzione”.
Non riuscire ad esprimere ciò che si muove dentro di noi è uno di quei fenomeni psicologici che possono condurre alla follia, e sempre conducono all’irrequietezza e ad una sorta di menomazione. La vita si trasforma in un continuo inseguimento dietro ad un fantasma di belle forme, che non riusciremo mai a raggiungere e dunque a toccare e possedere.
Ermanno, per di più, è incline alla poesia. Compone versi che non lo soddisfano. La sua tendenza è quella di sfuggire alla realtà.
Viaggia. Va anche a Parigi, dove si parla di Zola e di Dumas figlio. Il romanzo di quest’ultimo lo colpisce, avverte il fascino e la bellezza dell’amore, che, anziché gioia e entusiasmo, gli genera, in un primo momento, malinconia.
Le lettere che scrive all’amico narratore sono intrise di un romanticismo che attinge al Foscolo e a Stendhal.
De Roberto lo asseconda con una scrittura, tuttavia, sorvegliata, quasi che voglia darci il segnale di uno spirito di morte che può essere contenuto in quella pericolosa corrente di pensiero. Ermanno, infatti, non è dissimile, in quegli anni della sua vita, dai molti giovani che fanno della malinconia il filo conduttore della propria esistenza, una specie di passaggio obbligato, di prova cui si è tenuti, e da cui si potrebbe essere vinti. Non dimentichiamo che Byron e Shelley erano già divenuti autentici eroi romantici.
L’incontro a Vienna con la bella Stefania Woiwosky, “Slava ardente e spregiudicata”, provoca in lui un capovolgimento delle proprie convinzioni. Preso dal fascino della donna, come accade quando ci si è sempre cullati in un pensiero avverso, egli si lascia irretire e trascinare dalla novità del proprio sentimento: “Tutto era per lui ragione d’amarla, ed egli l’amò con la veemenza del temperamento paterno accresciuto dalla lunga castità, e con tali invenzioni di sentimento, con tanta squisitezza di pensieri, con tanta poesia d’espressione, che ella, avvezza ad un mondo molto diverso, ne restò stupefatta ed estasiata, benché senza troppo capirle.”
S’instaura presto un amore ad una sola direzione, quello di Ermanno, a cui la donna corrisponde non come egli vorrebbe, anzi, sempre più stancamente. Ma la nuova esperienza è così forte e totalizzante nel giovane che egli, pur avvertendo il crescente distacco della donna, si sforza di nasconderlo ai suoi occhi per paura di essere travolto dalla delusione e dallo smarrimento. Egli “negava talvolta la stessa evidenza.”
Il romanzo mette al centro della sua storia la disperazione dell’amore, o meglio ancora la possibilità di crederci e di riconoscerlo. E così Ermanno vive la vita come continua ricerca e negazione dell’amore. Si domanda se esso non si riduca al solo “appagamento dell’appetito bestiale” e “Riconosceva finalmente la sua illusione, l’inganno di qualche cosa che era soltanto dentro sé stesso, nella sua immaginazione, nel suo desiderio, nella sua pazzia, e che mai, mai, avrebbe potuto afferrare…” Avverte, ossia, un tremendo abisso tra ciò che sente e ciò che può offrirgli la realtà: “e una ruga precoce, indelebile traccia della tempesta, solcò la sua fronte.”
Ma l’amore non si arrende di fronte a questo ostinato misogino (“era troppo singolare, usciva troppo dall’ordinario”) e due donne affascinanti gli compaiono innanzi al suo ritorno a Palermo. Una è la contessa Rosalia di Verdara, moglie dell’amico conte Giulio di Verdara; l’altra è una sua giovane amica venuta da Parigi, Massimiliana (Maxette) di Charmory.
Non vi è dubbio che si respira un’aria stendhaliana sempre più intrigante in questo romanzo, in cui lo stile pressoché sorvegliatissimo, sicuro, ben temperato rende piacevole la lettura. Nel dramma di Ermanno si inserisce, ossia, una certa qual musicalità delle forme, siano esse costituite dalle figure dei personaggi, o dalle vaporose atmosfere degli ambienti eleganti della società siciliana. Un esempio del riuscito controllo sulla scrittura – in questo libro tendenzialmente romantica – può essere dato dal seguente brano: “La muta armonia del tramonto, dell’adorabile mistica ora nella quale, come a lenti giri, la luce sembra ascendere le cerule scale degli spazii infiniti, riecheggiava in lui; tutto l’essere suo vibrava come in un’ebbrezza.”
Conosciuto specialmente per il suo capolavoro “I Viceré”, De Roberto mette a segno con questa sua precedente opera un risultato per niente disprezzabile, e resta una qualche amarezza ove si pensi che essa è pressoché caduta nell’oblio. Devo all’amico Giorgio Bárberi Squarotti, incomparabile conoscitore della nostra letteratura, se sono arrivato a scoprire questo piccolo gioiello, rientrando nel novero di coloro che ne hanno potuto gustare i pregi.
Nonostante il suo scetticismo nei confronti dell’amore, la presenza e la frequentazione della giovane Massimiliana di Charmory introduce in lui delle piccole ma costanti modificazioni a cui, pur tentando di sottrarvisi, soggiace a poco a poco. Il pensiero di lei è già di per sé sufficiente a farlo sentire “diventato veramente un altro uomo.” Ma per colmo di sventura, i rossori, le timidezze di Ermanno vengono scambiate dalla contessa Rosalia Verdara quali segni inconfondibili dell’amore del giovane per la sua persona, “poiché, suo malgrado, ella si era accesa d’amore per lui.” La contessa ha avuto numerosi ammiratori, ma vi ha sempre fatto fronte acquistandosi la fiducia del marito e una reputazione, come la signora de Renal de “Il rosso e il nero”, “di rigida onestà e quasi di frigida indole, che aveva contribuito anch’essa a preservarla da attacchi ulteriori.”
De Roberto, a riguardo delle schermaglie e degli intrecci psicologici tra i personaggi invischiati in una storia d’amore e di gelosia, quale, appunto, quella che lega tra loro Rosalia, suo marito (“Indifferente in apparenza, il conte si era accorto da un pezzo della simpatia di sua moglie per l’amico”), Massimiliana ed il conteso Ermanno, non ha niente da invidiare a Stendhal. I risvolti psicologi sono, pur nella loro sottigliezza, densi di umore e di passione. Ermanno non ne è, tuttavia, ancora preso. Ciò che avverte, specialmente nei riguardi di Massimiliana, è un desiderio di accordo spirituale, di “unione delle anime. La sola cosa della quale avesse bisogno era comprendere ed esser compreso da un’altra creatura”; “L’idea dell’amplesso fisico era per lui insoffribile; egli non poteva ammettere che il candore del giglio fosse macchiato, che la purezza della fronte adorata fosse offesa.”
Un po’ dell’amore cortese, una eco degli stilnovisti medioevali arricchiscono il crescere di un sentimento che, dall’abisso in cui il protagonista era sprofondato, lo riporta alla vita. Ciò che avverte Ermanno a fianco di Massimiliana è una sorta di rinascita che lo colloca al principio di un percorso che egli deve di nuovo intraprendere con tutta l’innocenza e il candore propri di una giovinezza che era stata da lui dissipata se non addirittura disconosciuta. Vi si muove con una esperienza nuova, anzi, rinnovata, e tuttavia adolescenziale, esposta a tutti i pericoli, senza le pur minime difese che accompagnano, invece, la crescita di una gioventù che, tanto più è serena e spensierata, tanto più è spavalda e sicura.
Massimiliana gli resiste non perché non l’ami, ma in forza di un segreto che non ha ancora la forza di confidare né a lui né alla contessa. È un segreto che si porta dietro da tempo e che l’opprime e suscita in lei il convincimento: “che ella è indegna di quell’amore, che mai ella avrebbe potuto accostarsi all’altare!…” Un segreto che l’ha gettata nello sconforto e nella tristezza, negandole la felicità. Si tratta di un stupro, della violenza subita dal padre della viscontessa d’Archenval, il duca Gastone di Précourt, un giocatore e un vizioso incallito che, dopo aver consumato il suo proposito, è sparito. L’amore sincero di Ermanno, di cui si è accorta sin dai primi sguardi e a cui ha tentato di non corrispondere, ora le procura un’angoscia insostenibile. Dovrebbe confessargli tutto, o altrimenti sarebbe complice di un terribile inganno.
Una fosca aria di tragedia s’insinua a poco a poco nel romanzo. Noi avvertiamo nitidamente che il romanticismo che nutre il suo autore è della specie più crudele. Ci accorgiamo di essere costretti da De Roberto ad addentrarci dentro uno dei mali sociali non ancora – ai giorni nostri – risolto: la violenza nei confronti della donna, moltiplicatasi in ragione del prolificare del progresso e delle occasioni. Circa sessant’anni dopo, il romanzo di Anna Banti, “Artemisia”, uscito nel 1947, riprenderà lo stesso drammatico tema.
In tutto questo intrigo, la contessa Rosalia diventa il focus, l’elemento in grado di far prendere agli avvenimenti una direzione o la contraria. In lei ragioni di gelosia e di una sottile malvagità la indurrebbero a svelare ad Ermanno il segreto confidatogli da Massimiliana con una lettera disperata, ma la trattiene il pensiero del dolore che una tale rivelazione provocherebbe nel giovane. La trattiene inoltre “la naturale sua rettitudine” che “le rappresentava come un’indegnità il trarre profitto per sé, per i suoi fini inconfessabili, della confidenza che un momento di terribile angoscia aveva strappato alla disgraziata…”
Nulla accade al momento e Massimiliana è presa sempre di più d’amore verso Ermanno, che ancora non sa: “Spirito ingenuo, che le prove dell’esperienza impressionavano senza ammaestrarlo”. Di questa momentanea quiete sembra beneficiare la mente della giovane che si lascia accarezzare da speranze e sogni.
Pare di rivivere le atmosfere inquietanti di “Tess dei d’Urberville”, che Thomas Hardy scriverà nel 1891, ossia appena due anni dopo.
C’è un confronto che De Roberto pone tra l’ambiente frivolo da una parte (Palermo è chiamata “porta dell’Oriente”), in cui i due innamorati arrivano a parlarsi e che dà la possibilità ad Ermanno di fare la sua dichiarazione d’amore e, dall’altra, l’intensità e la drammaticità di un rapporto tra i due che Massimiliana, pur non desiderandolo, cerca di fuggire.
La storia continua a giocarsi molto sulle qualità e sensibilità di rappresentazione psicologica raffinata proprie del loro autore. I personaggi si muovono, infatti, come camminando su di un filo sospeso a mezz’aria da cui si può cadere da un momento all’altro: “si leggeva nell’imbarazzo del suo contegno, nell’amarezza espressa dall’increspamento di un angolo del labbro, la lotta interiore che si combatteva in lei.”
In particolare, Massimiliana, Rosalia ed Ermanno sono composti più che di carne, di complessi ed indistricabili labirinti della mente. Paure, gelosie, indecisioni, dubbi li restituiscono al lettore senza una loro precisa fisionomia fisica, bensì unicamente attraverso una loro identità spirituale ed intima.
Compare una frase, nell’ultimo capitolo, quando il romanticismo delle espressioni si fa più accalorato, che dà la chiave dei processi psicologici che si intrecciano nella tragica storia. È la domanda che Massimiliana pone a se stessa: “C’era dunque qualche cosa di più terribile del dolore; l’idea del dolore del quale si è causa?” Sarà questo convincimento, infatti, a sciogliere gli intrecci e a permeare il romanzo di un cupo e amaro sapore, che non troveremo così intenso nemmeno nel capolavoro di De Roberto: “I Viceré”, di appena cinque anni dopo.
Un’appendice, proposta sotto la finzione di una lettera inviata all’autore da un anonimo, riporta in una manciata di pagine “la vera fine di Ermanno Raeli” ed alcune sue poesie (quelle che poi confluiranno nell’”Encelado”). Il finto anonimo ad un certo punto scrive: “Non avete voi taciuto la verità vera per il torto che essa può fare alla memoria del nostro amico?” Così che si può concludere che l’appendice proposta da De Roberto nell’edizione Mondadori del 1923, ci vuol mostrare quanto la risposta che ciascuno di noi può dare alla vita sia sempre incerta ed enigmatica.