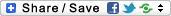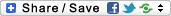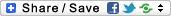Il termine “vuoto” ha un’etimologia controversa. Taluni lo fanno risalire alla parola latina “viduus” che significa: “privo di qualcosa”. Altri, invece, alla parola “voito” che significa “rovesciato”, quindi, svuotato.
Pare che Viduus fosse anche un dio minore, deputato a separare l’anima dal corpo dopo la morte.
Letteralmente, era il dio che divide.
Se penso a Giorgio De Chirico, l’unica parola che sento risuonare dappertutto è “vuoto”, qualunque sia la sua derivazione.

L’ossessione per i dettagli era sempre stata per lui talmente imponente, da realizzare l’effetto contrario rispetto a quello della corrente realista: lo allontanava dalla realtà, in quelle pose plastiche e irrazionali che hanno dominato molte delle sue opere.

De Chirico fu il primo ad associare il termine “metafisica” ad un’opera d’arte. L’idea era quella di costruire un’arte leggibile senza il contributo dei sensi. Un’arte silenziosa, misteriosa ed inquietante, intrisa di solitudine, priva di confusione.
Ogni colore, nell’arte del pittore italo-greco, resta al suo posto, incasellato nelle rigide strutture dell’architettura classica, pienamente sotto controllo.
Sono colori che non osano, che non oltrepassano limiti, che riescono solo nei passi indietro.
Il risultato è una staticità da spavento, un’immutabilità senza alternative.
Egli voleva descrivere l’uomo-automa del suo tempo. Ne è la perfetta dimostrazione il fatto che per uomini De Chirico intendesse dei manichini senza volto.

Una delle vicende più appassionanti della storia antica viene rappresentata da due teste senza occhi, senza naso, senza parole.

Grazie alla metafisica De Chirico poté sperimentare accostamenti di ogni tipo: prospettive quattrocentesche assieme a colori dal timbro giovane; statue antiche collocate in spazi con architetture moderne. Era questo la metafisica: una ricerca oltre la realtà, un misto di figure che a primo impatto definiremmo oniriche, ma che in realtà mantengono sempre la loro dimensione di fermezza, di controllo.

Mai come per questo artista le vicende autobiografiche sono rilevanti. In lui si intrecciano la passione per l’arte classica e per la mitologia (l’artista è nato in Grecia da genitori italiani) e quella per lo sviluppo industriale e tecnologico derivante dai suoi studi in ingegneria. Una combinazione esplosiva che lo portò ad avere sempre una certa diffidenza nei confronti di coloro che dipingevano la realtà nelle sue semplici forme, nel modo più fedele possibile.
Egli scriveva: “Un pessimo sistema è quello usato oggi di far lavorare il giovane allievo direttamente dal vero. Al Politecnico di Atene si facevano quattro anni di disegno e di studio del bianco e nero da sculture, prima di lavorare direttamente da un modello vivo. Nel primo anno si copiavano figure stampate, nel secondo sculture, ma solo teste e busti, nel terzo e quarto ancora sculture, ma di corpi interi o gruppi di figure”.
L’atteggiamento metodico dell’artista, la rigida scuola a cui in Grecia era stato abituato, l’amore per le pose classiche e per i classici miti gli impedirono per molto tempo di acquisire uno stile personale, di dare un’impronta di carattere alle opere.

Era sempre troppo abbottonato, troppo rigido, troppo immobile. Arrivò però anche per lui il momento in cui questa ingombrante formazione classica prese ad interagire con l’avanguardia. Il risultato fu strabiliante. L’arte finalmente si vestì di sentimento. Non importa se fosse solo inquietudine o una malinconia nietzschiana. Qualcosa era comunque profondamente cambiato.
Le Piazze D’Italia sembravano essere diventate un grido d’aiuto, una devastante dichiarazione di sofferenza, un’ammissione di colpe. Finalmente era sparito quel rifiuto per il mistero, quella chiarezza priva di effetti che aveva fatto da padrona nel primo periodo della sua vita artistica.

Solo così si è riempito il vuoto, solo con una moderata apertura al sentimento si è placata la sua incessante sensazione di inadeguatezza.
Di Adriana Lagioia