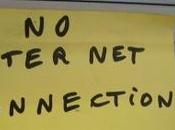di Jessica Vasile
Ciao, sono Peter, ho ventiquattro anni, il mio colore preferito è il rosso… e sono un immigrato!
Sono nato in Nigeria del Sud, a Okere, il 19 settembre del 1990. Mio padre, Sunday, è il pastore di una chiesa pentecostale a Benin City e mia madre, Mary, vendeva il pesce affumicato nel suo chiosco. Dico “vendeva” perché quando ero piccolo lei se n’è andata di casa per crearsi una nuova famiglia, io invece sono rimasto con papà. Lui mi ha insegnato a perdonare la mamma.
La mia infanzia è trascorsa serena, non avevo tutti i videogiochi o i giocattoli costosi che hanno adesso i ragazzini, a me serviva solo un pallone per essere felice. Ogni giorno, dopo la scuola, io e i miei amici andavamo al campetto vicino l’aeroporto a giocare a calcio. Ogni volta che dall’aeroporto vedevamo spuntare qualche turista europeo, lasciavamo la palla e iniziavamo a correre verso la novità: “l’uomo bianco” a noi non faceva paura, anzi ci piaceva.
A Benin City, ogni martedì mattina, allestivano il mercato della frutta, io e mio padre ci andavamo spesso per comprare la migliore frutta fresca della città, la cosa che più mi piaceva erano i colori degli Ishi AGU (i vestiti tradizionali) e i profumi che emanavano le arance. Purtroppo le compagnie petrolifere come la Shell, Eni o la Total, a causa dei lavori di trivellazione, inquinano i nostri fiumi e di conseguenza stanno irrimediabilmente causando danni alle nostre attività primarie: la pesca e l’agricoltura.
Qui la crisi si avvertì solo dopo pochi mesi dall’inizio della guerra civile, iniziata nel gennaio del 2006, quando un gruppo di militanti, originari della zona del Delta del Niger, si unì in un’organizzazione conosciuta col nome di MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta = Movimento per l’emancipazione del Delta del Niger). Il MEND si impegnò a combattere lo sfruttamento dell’ambiente naturale che le compagnie petrolifere stavano attuando attraverso l’estrazione del petrolio. Per questo motivo anche io scendevo in strada a protestare.
Una mattina di aprile però la protesta si trasformò in rivolta, in un’imboscata infatti vennero uccisi due militari nigeriani. Io riuscii ad allontanarmi ma alcuni miei amici furono catturati, seviziati e indotti a parlare contro la loro volontà. Durante un interrogatorio fecero il mio nome. La notizia dell’imboscata venne trasmessa in tv e io scoprii di essere ricercato. La cosa migliore da fare era lasciare la città finché le acque non si sarebbero calmate. Il giorno dopo partii, uno zaino in spalla conteneva qualche vestito e una coperta, pochi soldi e niente documenti. Presi la corriera e mi lasciai dietro la città in cui ero cresciuto. Quella fu l’ultima volta che vidi King’s Square, il campetto di calcio vicino l’aeroporto, casa mia. Ero solo, avevo quindici anni e soltanto undicimila Naire (poco più di cinquanta euro). Iniziai a lavorare e a conoscere un sacco di persone.
La decisione di partire per la Libia la presi di notte, quando rimuginai sulle parole del mio amico Jalil, su quanto questo stato fosse ricco. Organizzammo una vera e propria gita, e arrivammo in Libia. Tripoli. Zuara. Tutte le promesse fatte da Jalil non erano vere. La Libia è un paese sì ricco, ma non è un paese libero. C’era la dittatura di Gheddafi a rovinare il nostro, il mio sogno. Passarono tre lunghi anni da quando arrivai a Zuara, ma io ero sempre spaventato per la mia vita e mi mancava sempre più la mia famiglia. Non ero più felice e, soprattutto, non ero libero.
Un giorno il mio datore di lavoro mi disse che suo fratello era uno di quei “Human Smuggler” (trafficanti di umani) e che se avessi voluto sarei potuto andare in Italia in 24 ore senza pagare il viaggio. Accettai.
Il 24 luglio 2008 salii su quel gommone bianco assieme ad altre trentatré persone. Non avevamo né cibo né acqua. Soltanto un cuore pieno di speranza. Il “comandante”, poco prima di partire, ci aveva detto: “Questo viaggio durerà giusto il tempo di chiudere e riaprire gli occhi”. Si sbagliava.
Dopo due giorni eravamo ancora in mare aperto, avevamo caldo, sete e fame, ed eravamo tutti spaventati. Uno di noi si gettò in mare per la disperazione e non lo vedemmo più. Quella notte pregai. Nelle mattinate Dio volle che andassimo a finire nella traiettoria di una nave passeggeri, il capitano diede l’ordine di farci avere cibo e acqua sufficienti per tutti. Quel giorno pregai ancora. Durante le prime ore dell’alba del quarto giorno del nostro viaggio, un peschereccio tunisino si avvicinò al nostro gommone. Ci sfamarono e ci dissetarono. Ci chiesero dove fossimo diretti, e il nostro comandante rispose che la nostra meta era l’Italia, ma che la nostra bussola si era rotta e quindi vagavamo da giorni. L’uomo rimase perplesso e in silenzio per un paio di minuti, poi esordì: “Siete diretti a Est, fate in modo che il sole batta sempre sul vostro orecchio destro”. Tre giorni dopo, esattamente il 31 luglio, arrivammo a Lampedusa. Erano le tre di notte.

Dopo due giorni mi trasferirono ad Alcamo, dove conobbi quello che adesso è il mio migliore amico, Giuseppe, e suo padre Gaetano, il presidente del centro di accoglienza. Tutto quello che ho adesso lo devo solo a loro, all’umanità che mi hanno dimostrato, all’impegno e al duro lavoro.
Giuseppe mi fece inoltrare la richiesta di Asilo Politico. Poi mi recai a Salina Grande per il riconoscimento della protezione internazionale, mi intervistarono e alla fine mi rilasciarono il verbale: avevo ottenuto il permesso di soggiorno. Lasciai il centro di accoglienza e mi trasferii a Messina dove trovai lavoro come manovale. Questa prima esperienza di lavoro mi diede l’opportunità di imparare il dialetto siciliano, adesso “sugnu troppu forte, e quannu parlo cu l’avutri chistiani, iddri mi taliano cu l’occhi sbarrachiati!”.
Ho conquistato la fiducia di molte persone, ho incontrato gente meravigliosa e gente cattiva con atteggiamenti razzisti nei miei confronti. Ho trovato perfino l’amore. Adesso sono in attesa del permesso di soggiorno illimitato che mi potrà permettere di rimanere in Italia e in tutti i paesi dell’Unione Europea a tempo indeterminato. Nell’attesa sto cercando di avviare il mio nuovo lavoro di imprenditore. Adesso ho anche la partita iva e non manco di pagare le tasse. In futuro mi auguro di avere una famiglia e con essa passare le vacanze di Natale dai miei parenti in Nigeria.
——————–
thepostinternationale.it scrive:
Lo Stato, nel 2012, ha ottenuto 16,5 miliardi di euro dagli stranieri. Di questi, la maggior parte derivano dal pagamento dell’Irpef (il gettito è stato di 4,9 miliardi di euro), seguito dall’imposta sui consumi (1,4 miliardi), sugli oli minerali (0,84), su Lotto e lotterie (0,21) e per tasse e permessi (0,25). A questi 7 miliardi totali vanno aggiunti 8,9 miliardi di contributi previdenziali. Il totale delle entrate è stato quindi di 16,5 miliardi, che coprono con scarto i 12,6 miliardi di spesa pubblica. I cittadini stranieri hanno quindi fruttato 3,9 miliardi di euro all’economia del Paese.
Gli immigrati creano anche lavoro. In Italia possiedono l’8,2 per cento delle aziende totali e, grazie a queste, producono 85 miliardi di valore aggiunto.
Gli immigrati:
Ignoranti.
Non vogliono lavorare.
Infidi.
Ipocriti.
Razzisti.
Medioevali.
Religiosi fanatici.
Vanno in altri paesi a rubare il lavoro che non hanno.
Non si sanno adattare.
Parlano una lingua strana dovunque vadano.
Fanno caciara e sono incivili.
Mafiosi.
Dicono sempre “minchia”.