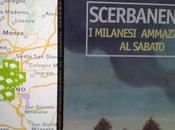Non sono più molti i fotografi che usano abitualmente il banco ottico, cioè la derivazione diretta della primissima macchina fotografica, consistente in una semplice scatola con un forellino al centro di una parete, dove la luce, penetrando all’interno, riproduceva sulla parete opposta un’immagine capovolta: è quell’apparecchio piuttosto voluminoso, e dotato di un soffietto posto a chiudere la camera oscura, in cui l’obiettivo è contrapposto a un vetro smerigliato, che serve per la messa a fuoco. Le immagini vengono impresse su speciali pellicole di grande formato, corrispondenti già in negativo alle dimensioni delle fotografie tradizionali, da cui si possono quindi ottenere ingrandimenti molto superiori alla norma.
Non sono più molti i fotografi che usano abitualmente il banco ottico, cioè la derivazione diretta della primissima macchina fotografica, consistente in una semplice scatola con un forellino al centro di una parete, dove la luce, penetrando all’interno, riproduceva sulla parete opposta un’immagine capovolta: è quell’apparecchio piuttosto voluminoso, e dotato di un soffietto posto a chiudere la camera oscura, in cui l’obiettivo è contrapposto a un vetro smerigliato, che serve per la messa a fuoco. Le immagini vengono impresse su speciali pellicole di grande formato, corrispondenti già in negativo alle dimensioni delle fotografie tradizionali, da cui si possono quindi ottenere ingrandimenti molto superiori alla norma.
Il banco ottico viene utilizzato generalmente su cavalletto, per realizzare quel genere di inquadrature che richiedono lunghi tempi di posa, sia in studio che all’aperto.
Tra i fotografi contemporanei che ne fanno abitualmente uso, troviamo Gabriele Basilico (Milano, 1944), da tempo considerato uno dei più importanti e celebri documentaristi europei che, a differenza di molti suoi celebri colleghi che nel corso delle loro carriere hanno fotografato i soggetti più disparati, spaziando indifferentemente dalla moda ai reportage di viaggio, appartiene alla categoria degli autori che si possono definire “monotematici”.
Dopo aver studiato architettura, Basilico inizia infatti molto presto a interessarsi di fotografia, scegliendo come pressoché unico soggetto il “paesaggio urbano”: milanese di nascita, si dedica dapprima a fotografare le aree industriali della sua città, le zone affollate di capannoni che già alla fine degli anni ’70 venivano lentamente abbandonati, sia per la necessità di trasferire le attività produttive più all’esterno della metropoli in espansione, sia per il declino della grande industria in favore del terziario. Queste costruzioni, che mostravano degli stili ben precisi, tipici dei primi decenni del ‘900, sembrano affascinarlo in modo particolare: il risultato diventa un libro pubblicato nel 1982 per Sugarco, “Ritratti di fabbriche”, che gli procura subito una discreta notorietà.
In seguito buona parte del suo lavoro viene fatta su commissione: aziende private, case editrici ed enti pubblici gli chiedono di realizzare ricerche particolari su edifici di vario genere e più in generale sulle continue trasformazioni del territorio.
Partecipa anche, su invito del governo francese, al grande lavoro di documentazione sui cambiamenti del paesaggio transalpino che impegna noti fotografi, provenienti da vari paesi, negli anni 1984 e 1985, i cui risultati vengono poi esposti in una grande mostra collettiva nel 1985 a Parigi.
In seguito, ai lavori per i committenti si affiancano le ricerche personali: dopo Milano, di cui documenta gli aspetti meno consueti, le sue esplorazioni continuano in altre città europee, per poi approdare nella Beirut martoriata dalla guerra civile, dove realizza un memorabile reportage nel 1994, che diventa uno degli svariati volumi dedicati ai “luoghi” e divenuti in poco tempo veri oggetti di culto fra gli appassionati di fotografia.
Quelle di Basilico sono immagini rigorosamente in bianco e nero, realizzate con il banco ottico, in cui le strade appaiono sempre completamente deserte, così che non ci siano personaggi, neppure colti in modo casuale, a distrarre l’attenzione di chi guarda dagli edifici, che devono costituire l’unico soggetto.

La passione costante per l’architettura lo porta a vagare per le città in cerca di similitudini fra un luogo e l’altro, fra una prospettiva o un edificio e i loro corrispettivi situati a migliaia di chilometri di distanza, così che a volte, sfogliando le pagine, l’osservatore s’imbatte in immagini che gli appaiono falsamente familiari. Come ha scritto in uno dei suoi libri (“Nelle altre città”, 1997), in cui spesso le fotografie sono affiancate da diari di lavoro e da importanti riflessioni teoriche, “Riflettendo a posteriori su tutti i miei viaggi, su questi paesaggi urbani, questo andar per luoghi, mi sembra che una condizione costante sia stata l’attesa di ritrovare corrispondenze ad analogie.”
Non a caso uno dei suoi lavori più recenti, la serie di fotografie della Ferriera, edificio progettato nel centro di Locarno dall’architetto svizzero Livio Vacchini secondo criteri in controtendenza rispetto alle “mode” correnti, sembra riportarci alle immagini di architettura industriale dei suoi esordi.