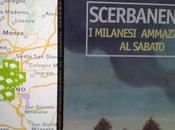“Comunicava con strumenti non verbali: i silenzi, anzitutto, gli sguardi, i movimenti delle mani, il modo di trafficare intorno alla pipa”.
“Comunicava con strumenti non verbali: i silenzi, anzitutto, gli sguardi, i movimenti delle mani, il modo di trafficare intorno alla pipa”.
Così Ernesto Ferrero descrive Giulio Einaudi, nello splendido romanzo del 2005 dedicato “agli einaudiani” ma, più in generale, ad una indimenticabile stagione della cultura italiana, “I migliori anni della nostra vita” (Feltrinelli, pagg. 214).
Ferrero entra nell’Olimpo di via Biancamano nella primavera del 1963, come responsabile dell’ufficio stampa, poi diventa direttore letterario e, dal 1984 all’89, direttore editoriale. Dall’interno riesce benissimo a radiografare quell’idea einaudiana “d’essenzialità e leggerezza” personificata dall’Editore e dalle sue case con tanto bianco alle pareti che erano “il prolungamento delle sue copertine, o viceversa”.
Giulio Einaudi, appena ventunenne, il 15 novembre del 1933, fonda la casa editrice. Una passione, quella per i libri, che nasce nella villa di famiglia, a Dogliani, e in particolare nella biblioteca di suo padre, il presidente: “lì Giulio ventenne aveva trovato la sua vocazione, aprendo i pacchi destinati al padre, annusando la carta e gli inchiostri appena impressi, stampandosi in mente gli impianti di pagina dei volumi dei Laterza, quegli Einaudi pugliesi”.
Dinanzi al lettore si spalanca una galleria di ritratti, da cui emerge l’uomo prima che lo scrittore o l’editore.
Tre grandi dirigenti: Giulio Bollati, il Maestro, alter ego di Einaudi, cui si deve in gran parte l’impronta delle scelte editoriali; Daniele Ponchiroli, redattore capo e Roberto Cerati, direttore commerciale, entrambi simboli dell’ala francescana dello Struzzo, sempre al lavoro, senza alcuna mania di protagonismo.
Poi gli scrittori: Elio Vittorini, Norberto Bobbio, Natalia Ginzburg, la zia che “tutto vede e capisce senza mai alzare gli occhi dal cestino di lavoro”, l’ingegner Gadda, Calvino, - “l’ho riconosciuto dal silenzio” - disse di lui Borges. Pur di poche parole, scopriamo che Calvino scriveva migliaia di lettere “agli ignoti che non entreranno nelle storie letterarie”, spiegando con pazienza gli errori e dando consigli di scrittura.
Leonardo Sciascia, che arrivava da Palermo col capotto nero non più di una volta l’anno; Elsa Morante, i suoi gatti e l’abbigliamento di una zingara; Lalla Romano, - la “cattiva” – come la chiamava l’Editore; Mario Rigoni Stern, che si faceva vedere molto raramente.
Le pagine più emozionanti sono dedicate a Primo Levi e al suo incontro con Philip Roth nel settembre del 1986, pochi mesi prima della morte. Una perdita che avrebbe cambiato per sempre il volto della famiglia Einaudi, insieme ad altri “sacrifici umani”, come quello di Cesare Pavese - l’editore non voleva parlarne, l’unica cosa che disse di lui fu che era un “uomo di dubbi” - e di Beppe Fenoglio: “verso la metà di febbraio di quel 1963 Calvino entrò in ufficio sconvolto, dominando a stento le lacrime”, - scrive Ferrero – per annunciare la morte dello scrittore.
Leggendo di quegli anni si è colti da un forte desiderio di partecipare, anche solo ad uno, dei famosi “teatrini” del mercoledì, quando, alle 18, “redattori, consulenti, collaboratori esterni e ospiti occasionali” si riunivano intorno al tavolo ovale o ai “ritiri spirituali” tra la fine di giugno e i primi di luglio, in montagna, in Valle d’Aosta. Un’occasione, tra salite e pranzi, per fare un bilancio dell’anno passato e previsioni per il nuovo.
Purtroppo, come succede a molte famiglie, anche quella einaudiana, nella primavera 1978, “si sfasciò”, l’Editore era più a Roma e a Milano che a Torino e lentamente il lessico famigliare che teneva tutti uniti divenne incomprensibile, lasciando, anche a chi legge, una grande nostalgia per un pezzo della storia d’Italia, per un mondo delle lettere che non è più e tanto manca.
Media: Scegli un punteggio12345 Nessun voto finora