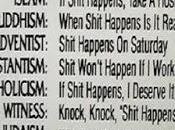“Cerco cappotto usato, colore giallo ocra , taglia 44, tessuto bouclè, doppia abbottonatura, manica raglan, sagomato in vita e svasato, lunghezza sopra ginocchio”. Questa l’inserzione che avevo lasciata al giornale, nella speranza che qualcuno rispondesse. Sarei stata disposta a pagarlo per nuovo, quel cappotto.

Oltre ad essere affezionata agli abiti degli altri, mi affeziono anche a quelli che compro nuovi, ma solo quando il tempo li ha collocati in un lontano passato.
In ogni caso sono così affezionata al mio guardaroba che nel fare i cambi di stagione, difficilmente riesco ad eliminare qualcosa. Non ne ho il coraggio e continuo a conservare le mie robe come file zippati negli armadi, nelle cassettiere, nei bauli.
Una volta soltanto, pensando ai poveri, sono riuscita, senza indugiare troppo nei ricordi, a riempire un grande sacco nero di plastica, e via! Un colpo di testa di cui dovevo pentirmi qualche tempo dopo. Avrei potuto aiutare i poveri in mille altri modi, e meglio.
E’ stato un pomeriggio di domenica piovosa che avrei trascorso in casa da sola ad annoiarmi da un vetro all’altro, quando mi sono ricordata del vecchio album di foto che mia madre aveva voluto affidarmi, e ho deciso di andarvi a guardare.
La storia della famiglia e in parte della mia vita era tutta dentro quelle immagini, e soprattutto erano gli abiti indossati a raccontarla. Gioivo e sorridevo ritrovando quel giacchino, quel foulard, quella maglietta, quello spolverino che sapevo di conservare in fondo ad un baule. Il tempo aveva portato via con sé ogni fattezza, ogni lineamento, a volte le presenze stesse, ma almeno gli involucri, i miei, li avevo conservati per quanto possibile. Scorrendo quelle foto a tratti ero presa dal dubbio che una camicetta o un tailleur fossero andati persi e allora non resistevo. Lasciavo l’album sul divano e mi precipitavo a rovesciare bauli e armadi finchè non ritrovavo quella cosa, e solo dopo tornavo tranquilla alle foto. E da una foto di una gita al lago in cui ero insieme a mia zia , è spuntato fuori il mio vecchio cappotto giallo ocra. Mi sono fermata ad osservare quanto ero bella a diciannove anni e a riflettere sul fatto che di quella immagine conservavo solo il cappotto, intatto, a sfidare il tempo. – Ma è sicuro che lo conservo ancora? – mi sono chiesta subito. – Si, è nell’armadio in mansarda, l’ho visto quando ho riempito il sacco per i poveri – ho ricordato. Per un po’ mi sono messa tranquilla, ho continuato a sfogliare l’album con l’idea di masterizzare tutte quelle foto per riversarle su un compact disk. Sul tavolinetto c’era il portabonbon e non ho resistito dal prendere un cioccolatino. Mentre lo scartavo il profuno della vaniglia e del cioccolato mi riporta di nuovo alla mente quel cappotto giallo. Mia sorella mi diceva sempre che il mio cappotto odorava di vaniglia e cioccolato. Io in verità non sentivo nessun odore, ma ripensandoci poteva aver ragione lei. Con il cioccolatino in bocca salgo in mansarda, apro l’armadio, guardo, sposto, sgancio, ma il cappotto non lo trovo. Ho smontato tutta la casa per cercarlo. Ho ripetuto la ricerca nei giorni seguenti ma del cappotto nessuna traccia.
Ogni giorno che passava cresceva in me un senso di vuoto, di dolorosa perdita, come se un pezzo della mia vita fosse precipitato irrimediabilmente nel vuoto. Non riuscivo a rassegnarmi alla perdita del cappotto giallo ocra che sicuramente, durante quel maledetto cambio di stagione, per errore, era finito nel sacco nero. Così ho deciso di pubblicare una inserzione sul giornale, nella speranza che qualcuno avesse potuto darmene notizia.
Sono passati mesi, non ci speravo più ormai, quando oggi pomeriggio ricevo una telefonata. E’ la padrona di un negozietto di abiti usati, che mi assicura di disporre di un cappotto giallo ocra anni ‘70, e che in base alle descrizioni fornite nell’inserzione, potrebbe trattarsi proprio del cappotto che cerco.
- sì, giallo ocra , taglia 44, tessuto bouclè.
- doppia abbottonatura, manica raglan, sagomato in vita?
- Esattamente!
- Grazie dell’informazione, spero davvero sia quello! Intanto me lo tenga da parte, entro domani verrò a visionarlo. Mi scusi ancora, può ripetermi l’indirizzo e il nome del negozio?
- Certo! “Da un armadio all’altro” su via degli Incontri, dietro la stazione, è facile trovarlo.
- Grazie tante, e a domani!
Avevo appena parcheggiato la macchina nell’area dell ’ipermercato per fare la spesa, una lunga lista di rifornimenti, ma ripensandoci ho considerato che la spesa avrei potuto farla l’indomani. Ero smaniosa di vedere quel cappotto, perché aspettare? Così riprendo la macchina e mi dirigo verso la stazione.
Sarà un cappotto giallo, sarà simile, ma non sarà quello. Quasi impossibile, pensavo per strada preparandomi alla delusione.
Via degli Incontri, un vicoletto cieco scarsamente illuminato, doveva essere la strada dell’amore, un tempo, non l’avevo mai attraversata. Trovo il negozio, un buco, entro e mi perdo tra montagne di vestiti che mi sembra di stare dentro un armadio. Intorno diverse persone frugano entro casse di indumenti dai colori più assurdi, tutto a cinque euro. Il mio cappotto non poteva stare lì, in mezzo a quei cenci.
Poi, guardandomi intorno, con il giallo negli occhi, prima ancora di avvicinarmi alla commessa, scorgo il lembo di una manica che fuoriusciva da una fila zeppa di abiti appesi lungo un’asta. E’ bastato il colpo d’occhio per riconoscere il mio cappotto e mi sono sentita attraversare da una tale emozione vedendolo, che ho voluto indossarlo subito.
Come vuole – mi ha detto la signora. – Forse solo un leggero tanfo di chiuso che andrà via presto. Basta tenerlo all’aria aperta un giorno, ma è pulito, posso assicurare che qui ogni capo è già passato in lavanderia. – ha aggiunto compiaciuta per la mia soddisfazione, ma anche un po’ sconcertata dalla mia inspiegabile ansia di indossarlo subito.
Vestita di giallo, un pugno nell’occhio di chi guarda, faccio tutta la strada a piedi per tornare alla macchina e camminando mi sembra di aver recuperato la stessa disinvoltura e la leggerezza di quando ero ragazza. Questa sensazione si fa più intensa mentre percorro il vecchio corso della città. Gli stessi edifici imponenti, gli stessi portoni severi, la stessa pavimentazione di quando andavo a scuola. Tutto sembrava immutato nel tempo, o tutto sembrava tornato al proprio posto; il panificio del signor Mario, la latteria, la pasticceria di Veronica. Sento il profumo del pane appena sfornato, dei maritozzi all’anice e delle bombe fritte alla crema. A parte le vetrine rinnovate, niente mi sembrava cambiato e guardando all’interno dei negozi riconoscevo le stesse persone di un tempo. Forse i figli dei vecchi titolari che nei movimenti, nei gesti, nei timbri delle voci, vestivano ormai le sagome dei padri.
L’aria è gelida, è già buio e l’orologio della torre segna le diciassette. Mi torna in mente quell’inverno rigido quando ho cominciato a lavorare nella fabbrica di dolciumi.
- Ora ci vuole un cappotto come si deve! – ripeteva ogni giorno mia madre. – Non puoi uscire d’inverno alle sette di mattina e intirizzirti ad aspettare l’autobus con quell’impermeabile mezza stagione che hai comprato al negozio dei cenci. Ti devi vestire dignitosamente ora che lavori, stai in mezzo alla gente! E poi rischi di ammalarti se non ti copri bene. Stai cominciando adesso e non faresti una bella figura con i padroni ad ammalarti subito.
- Si, mamma. Ma i soldi? Chi sa quando mi daranno lo stipendio e poi, quanto credi che mi daranno? Abbiamo debiti con il padrone di casa, con il lattaio, il panificio e il macellaio. Mi vergogno perfino a passarci davanti.
- Io non mi vergogno, non ho mai fatto la puttana. – rispondeva mia madre.
- Io invece mi vergogno più che se facessi la puttana – replicavo cercando di provocarla con una dose di spudoratezza che lei sapeva non appartenermi.
- Non ci pensare, vedrai che piano piano rimedieremo e tu un giorno completerai gli studi, ne sono sicura. Diventerai una professoressa! – concludeva ogni volta lei , sicura di non potersi sbagliare sul mio conto.
Mi vergognavo specialmente di Mario il panettiere, e quando lo vedevo sulla soglia del negozio lo schivavo cambiando marciapiede. Sul lato opposto dovevo stare attenta a schivare il lattaio. Quando andavo a scuola mi fermavo ogni mattina da Mario, e lui: – allora signorina , come va questo latino? Sa che anch’io ho studiato il latino? Mi piaceva tanto il De Bello Gallico! “Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani…” Allora , Maritozzo o bomba? – mi chiedeva. Pagavo, prendevo la colazione e felice me ne andavo a scuola.
Alle cinque di una sera di dicembre, mia madre si era fatta trovare davanti al cancello della fabbrica per andare insieme a comprare il cappotto. La fabbrica era nella periferia della città e a piedi avevamo raggiunto il centro dove il clima natalizio già si respirava nelle luminarie che addobbavano le strade e le vetrine. La gente affollava le vie del centro, entrava ed usciva dai negozi come fosse di casa, mentre noi due non avevamo il coraggio nemmeno di avvicinarci a guardare quel tripudio di festa e di felicità offerto dalle vetrine.
– E’ meglio che cerchiamo qualche piccolo negozio nelle retrovie, qui non è per noi – disse subito mamma. Così uscimmo dal corso principale e ci incamminammo in direzione dell’ippodromo. Le strade erano meno illuminate, i marciapiedi erano piuttosto sconnessi e nessuno andava a passeggio. Casalinghe uscivano dal supermercato con le buste della spesa, seguite da bambini frignanti, uomini davanti ai bar discutevano di calcio tra intese di sguardi maliziosi al passaggio di giovani donne. Voci cavernose, puzza di pesce e di grassi fritti. Di tanto in tanto, modeste vetrinette mostravano su mezzi busti e lunghe gambe di plastica, collants e reggiseni impolverati, qualche pullover lavorato a mano, stelle comete e bambinelli, tra gomitoli di lana colorati e sciarpe sgargianti. Stavamo per tornare indietro stanche e deluse, quando dall’altro lato della strada ci richiamò una insegna con la scritta Babele. Ci avvicinammo, era una merceria, ma in vetriva una mannequin senza volto indossava un bel cappotto giallo. Me ne innamorai subito, anche a mia madre piacque e decidemmo di entrare. Lo provai, mi guardai allo specchio e sorrisi compiaciuta della mia immagine. Appena svasato, lungo fin sopra il ginocchio, manica raglan, collettino piccolo che si poteva tenere alzato a coprire il collo, il tessuto bouclè morbido e carezzevole. Sarebbe stato quello il mio cappotto, già mi sentivo un’altra all’idea di indossarlo. Ma quando vidi il prezzo sull’etichetta mi si smorzò il sorriso.
- allora, avete deciso per questo? – Chiese la commessa. – altrimenti possiamo provarne altri! –
- Sì, questo giallo ci piace proprio – rispose mia madre – ma il prezzo è un po’ alto – aggiunse avvicinandosi alla ragazza come a tirarla in disparte. – Si potrebbe pagarlo in tre rate? – chiese poi sommessamente evitando di farsi sentire da altre signore che attendevano il loro turno sbirciando i vari abiti infilati sull’attaccapanni.
La ragazza alzò le sopracciglia e un po’ le spalle alla richiesta, senza dire niente. Era imbarazzata anche lei.
- Veda un po’ se può venirci incontro, – insiste mia madre – Siamo persone serie, abbiamo avuto una sfortuna. Ma ora la ragazza lavora e ci sarà il suo stipendio per pagare.
- Non sono io la padrona, signora,- risponde alla fine la commessa, mantenendo basso il tono della voce. Non posso dirle niente. In genere qui non si fanno rate, ma può provare a parlarne con la titolare che ora non c’è. Ripassi più tardi, oppure domani mattina, la troverà certamente. Io tengo in sospeso la vendita fino a domani. Di più non posso fare, capisce?-
- Grazie assai signorina, lei è davvero molto gentile ed anche umana. Facciamo allora che io ripasso domani sperando che la cosa si possa fare. – Mia madre aveva nella voce umile ed incerta il senso della piena riconoscenza. Continuò a salutare e a ringraziare avviandosi all’uscita, mentre io contenevo il disagio fremendo con la mano sulla maniglia della porta per andare via a più presto. Mi sentivo mortificata dalla richiesta di mia madre e con un filo di voce dissi solo “buonasera”.
Quando tornai dal lavoro la sera dopo, trovai il cappotto nuovo sul mio letto, avvolto nel sacco di cellophane. Lo provai di nuovo, lo rimirai e lo appesi con cura nell’armadio senza riuscire ad immaginare il giorno in cui l’avrei indossato. Era bello, ma troppo nuovo per andarci al lavoro. D’altra parte non lavoravo negli uffici della fabbrica, ma nel laboratorio di confezionamento ad incartare torte e bonbons. Il mio cappotto nuovo sarebbe rimasto appeso all’attaccapanni comune sulla parete, ad impregnarsi dell’odore di vaniglia, cioccolato e cannella.
Mia madre ogni giorno insisteva perché lo indossassi dicendomi che nel laboratorio potevo proteggerlo con l’involucro di cellophane, ma io trovavo sempre una scusa. – oggi piove e mi si bagna, oggi nevica , certo uno di questi giorni lo indosserò! -
Arrivò Natale e andai alla messa della mezzanotte insieme alla mia amica Ida, finalmente con il cappotto nuovo. Tranne Ida, nessuno fece caso al mio cappotto quella notte, né negli altri giorni di festa. Così mi passò l’imbarazzo della cosa troppo nuova e il due gennaio indossai il cappotto anche per andare a lavorare. Era una mattina rigida, una patina di ghiaccio appannava ancora i vetri delle macchine ferme sulla strada quando varcai il cancello della fabbrica. Correvo, l’autobus per via del ghiaccio aveva fatto ritardo e già non c’era più nessuno nel cortile della fabbrica. Così presi di corsa le scale anch’esse ghiacciate e scivolai ai primi gradini battendo il ginocchio destro. Rialzandomi mi guardai intorno. Per fortuna non c’era nessuno tranne Gigi che mi aveva vista cadere. Gigi era un operaio del servizio spedizioni, non più giovane, che conoscevo di vista. Era molto schivo e silenzioso, diventava rosso quando una donna lo salutava, si impappinava e rispondeva con un cenno della testa e un mormorio di parole incomprensibili.
Cercando di fare l’indifferente, ho ripreso a salire le scale senza piegare il ginocchio che aveva battuto e mi bruciava. Ma Gigi era già lì a soccorrermi e a quel punto sentivo più vergogna che dolore. Vergogna di Gigi, l’ultimo operaio dell’azienda, un po’ scemo e deriso da tutti, che si stava prendendo cura di me.
Con tutta la sua premura mi aiutò a salire le scale sostenendomi per il braccio e ripetendo ad ogni gradino Oplà, oplà. Poi finite le scale e rimasto a corto di parole, mi mostrò un bottone che penzolava dalla manica del cappotto. – penso io, penso io – continuò lungo tutto il corridoio mentre con l’indice della mano libera mi additava la porta del cucinotto adibito anche ad infermeria. Non l’avevo mai sentito così sicuro di sé e quasi fiero del ruolo di soccorritore che si trovava a svolgere. Una volta nella stanza mi aiutò a sfilarmi il cappotto controllando con lo sguardo se non vi fossero altri danni e lo sistemò per bene sopra una sedia. Intanto io mi ero seduta e guardavo il mio ginocchio insanguinato attraverso la calza rotta. Sembrava solo escoriato. – Ma che stupida, potevo stare più attenta, e che figura sto facendo con Gigi! – Mi rimproveravo mentre lui tirava fuori dalla cassetta dei medicinali cotone, garze e disinfettante. Mi medicò senza chiedermi di togliere la calza, ma allargandone il buco. Poi imbottì il ginocchio come un manicaretto di garze inbevute di disinfettante e infine vi avvolse una lunga fascia che non finiva mai di srotolare. Impiegò più di mezz’ora nell’operazione in cui impegnò tutto se stesso. Io lo lasciavo fare dandogli fiducia, cogliendo tanta dolcezza nei suoi occhi tondi e sporgenti come quelli di un ranocchio, e in quel suo sorriso straripante tra i grossi denti che gli sfuggivano dalla bocca. Alla fine prese da una scatolina ago e filo e fermò con cura anche il bottoncino penzolante. Seppi poi che Gigi da giovane era stato per qualche tempo nella bottega di un sarto ad imparare il mestiere.
In tanti anni non mi è mai tornato in mente Gigi e la sua immagine mi ricompare solo ora, uscita fuori come una matrioska dal mio vecchio cappotto giallo ocra.
Ma che fine avrà fatto Gigi? A quest’ora sarà un vecchietto in pensione che porta a spasso il suo cagnolino ai giardinetti.
Se ora lo incontrassi e seppure lo riconoscessi sarebbe comunque un estraneo la cui immagine verrebbe a contaminare irrimediabilmente il mio ricordo. Preferisco conservare dentro questo cappotto la dolcezza dei suoi occhi tondi e sporgenti, il suo sorriso inquieto e accidentato e questo bottoncino della manica riattaccato con un filo di colore leggermente diverso dall’ocra.
foto tratta dal web