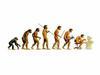José Luís Peixoto è nato in Portogallo nel 1974, l'anno della Rivoluzione dei garofani. Non lo dico per pedanteria biografica; le date possono rivelarsi spie di qualcos'altro. Per alcuni, quella fu l'ultima rivoluzione d'occidente: chiuse la fase delle barricate ottocentesche e diede inizio al postmoderno, “whatever the f... you want it to be” (cito dall'articolo di Carlotta Susca che cita da questo video). Quando le campagne intorno al suo paese venivano occupate dai contadini “sem terra”, Peixoto dava i primi vagiti; ma quando cominciava a parlare, il Paese era già avviato verso la “normalizzazione”. Crescerà in un Portogallo membro della CEE e pubblicherà le sue prime cose negli anni di Lisbona meta prediletta del turismo internazionale. Insomma un esemplare perfetto di scrittore che Antonio Scurati definirebbe “dell'inesperienza”. Cioè uno scrittore che non solo non ha visto (come Ungaretti o Fenoglio) una guerra mondiale, ma nemmeno i fucili silenziati dai garofani nella quasi incruenta rivoluzione di casa sua.
José Luís Peixoto è nato in Portogallo nel 1974, l'anno della Rivoluzione dei garofani. Non lo dico per pedanteria biografica; le date possono rivelarsi spie di qualcos'altro. Per alcuni, quella fu l'ultima rivoluzione d'occidente: chiuse la fase delle barricate ottocentesche e diede inizio al postmoderno, “whatever the f... you want it to be” (cito dall'articolo di Carlotta Susca che cita da questo video). Quando le campagne intorno al suo paese venivano occupate dai contadini “sem terra”, Peixoto dava i primi vagiti; ma quando cominciava a parlare, il Paese era già avviato verso la “normalizzazione”. Crescerà in un Portogallo membro della CEE e pubblicherà le sue prime cose negli anni di Lisbona meta prediletta del turismo internazionale. Insomma un esemplare perfetto di scrittore che Antonio Scurati definirebbe “dell'inesperienza”. Cioè uno scrittore che non solo non ha visto (come Ungaretti o Fenoglio) una guerra mondiale, ma nemmeno i fucili silenziati dai garofani nella quasi incruenta rivoluzione di casa sua.
Fin qui, absit injuria verbis. Si cerca solo di osservare e, nei limiti del possibile, ordinare un certo sapere minimo intorno a un certo fenomeno letterario. Perché Peixoto è senza dubbio un fenomeno. I suoi libri vantano eccellentissime bandelle griffate: si va da Muñoz Molina alla buonanima di Manuel Vázquez Montalbán passando per Luis Sepúlveda, che non bada a spese e lo paragona a Borges, Calvino, Cortázar... In Italia ha incantato, fra gli altri, Marco Lodoli e Filippo La Porta, mentre Paolo Collo lo propone come alternativa a chi volesse andare oltre Saramago. Non a caso, dopo i primi titoli pubblicati da La Nuova Frontiera, è approdato a Einaudi con “Il cimitero dei pianoforti” (trad.: G. Boni).
Il romanzo è vagamente ispirato alla vicenda storica di Francisco Lázaro, carpentiere e maratoneta. Lungi dalla solita geremiade sullo sport sano di un tempo, pare che Lázaro sia stato un caso aurorale di doping in età moderna, quando ancora gli intrugli includevano uova, cognac, trementina e persino stricnina. Il risultato fu che, tra i favoriti alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912, l'atleta non vide mai il traguardo. Al 29º km barcollò, cadde e si spense poche ore dopo in ospedale. Il referto medico attribuirà il decesso a insolazione. Perlomeno strano che un portoghese si sia fatto fregare dal sole svedese in tempi in cui l’ozonosfera non doveva essere neanche tanto bucata.

Ma un tema così scarno può dar vita tutt'al più a una poesia o a un libriccino lirico come quello del 2000, struggente e imbarazzante nella sua indifesa nudità. Un romanzo non lo regge. L'autore non sembra avere altro da offrire se non una scrittura che si mostra nuda perché si crede bella, ma è solo incapace di abbigliarsi. Nei momenti più ispirati, leggere Peixoto è un po' come leggere Metastasio: ogni aspetto peculiare della storia sfuma in odi astratte a grandi sentimenti universali (Amor filiale o coniugale, Lealtà, Coraggio...). Nelle frequenti cadute di gusto, c'è da sopportare mattine chiare come il sorriso della moglie che ci dorme accanto, uccellini alla finestra, la parola “tempo” disseminata qua e là come chi si sente l'incarnazione fadista di Martin Heidegger... Il tutto condito da un uso stucchevole dei due punti: “Resta il tempo: tempo: tempo che passa senza esistere”, oppure: “Domenica: domenica”.

Per concludere, devo solo confessare che, come mi capita spesso, cito dall'originale e ignoro l'edizione italiana. Può essere un limite, perché le traduzioni sono sempre libri un po’ diversi. Non so se all'Einaudi, almeno nella punteggiatura, non abbiano sottoposto il testo a un discreto editing. Mi piacerebbe saperlo, come pure vorrei conoscere il trattamento che riserverebbero al dattiloscritto di un anonimo esordiente che scrivesse così. JLP scrive invece con la sicurezza di chi è dappertutto salutato come l'erede di Saramago. Messa sottovetro dall’immediato successo di critica, ogni frase è lì per essere ammirata. Duchamp, dall'alto della sua provocatorietà intellettuale, ci ha insegnato che, posto in un museo, anche un orinatoio può esser visto come un'opera d'arte. Noi, più terra terra, ricordiamo, col professor Bellavista di Luciano De Crescenzo, che ogni tanto un cesso rimane un cesso.