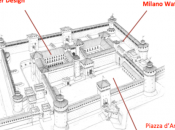Le donne sono circa la metà della popolazione mondiale, ma la loro presenza media nei parlamenti dei vari paesi si aggira intorno al 16,6%[2]. Inoltre continuano a essere soggette a segregazione “verticale” (soffitto di cristallo) e “orizzontale” (pavimento di pece). Nel primo caso incontrano difficoltà nell’avanzare di carriera e ricoprire mansioni dirigenziali, nel secondo rimangono confinate in determinati settori tradizionalmente “femminilizzati” e non riescono a occuparne altri. Questa terminologia si utilizza soprattutto in ambito lavorativo, ma è applicabile anche alla politica. Qui si adoperano più spesso, in sostituzione dell’espressione “soffitto di cristallo”, quelle di Iron Law (legge di ferro) e Lag (intervallo). Con la prima si descrive la percentuale di rappresentanza femminile che decresce all’aumentare della gerarchia del potere, con la seconda si intende la necessità che le donne eleggibili si stabilizzino a ogni livello della gerarchia prima di poter accedere a quello successivo, che raggiungono, tra l’altro, quando questo diventa meno appetibile per gli uomini[3].
L’uguaglianza di genere è stata “inseguita” dalle istituzioni attraverso due tipologie di politiche: “della parità” e, successivamente, “delle pari opportunità”. Le prime hanno cercato di garantire la parità attraverso il corretto funzionamento delle regole universali. Il principio è stato quello di applicare norme identiche per tutti, senza considerare le disparità di partenza. Ma l’uguaglianza è rimasta formale e le differenze sono rimaste inalterate. Le donne, come si è detto, hanno continuato a subire discriminazioni sia nel lavoro che in politica. Sono state introdotte pertanto le politiche delle pari opportunità. Per garantire concretamente uguali possibilità di partecipazione si è ricorso a forme correttive: le azioni positive. Queste ultime consistono in trattamenti disuguali (che dovrebbero essere temporanei) a favore dei gruppi in minoranza (le donne) per riequilibrare le condizioni di accesso ai diritti (e di conseguenza la presenza nei luoghi di lavoro e nella politica in particolare) e rendere effettiva l’uguaglianza dei risultati[4].
Anche l’Unione europea, dopo aver sollecitato gli stati membri all’attuazione di politiche di uguaglianza e di pari opportunità[5], ha adottato quest’ultimo principio nel Quarto Programma di azione (1996-2000)[6]. Il piano «propone delle linee di intervento per le pari opportunità in tutti i settori della vita pubblica e privata: nel lavoro, nell’istruzione, nell’equa partecipazione ai livelli decisionali e nella corresponsabilità nella vita privata»[7]. Si afferma così, come sottolinea Conti Odorisio, il principio che «la parità di trattamento e la parità di opportunità tra le donne e gli uomini è un elemento integrante della democrazia europea»[8]. Il programma redatto dopo la Conferenza di Pechino ne adotta gli stessi obiettivi: l’empowerment e il mainstreaming. Con il primo termine «si intende l’attribuzione di maggiore potere alle donne rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla attiva partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita pubblica e privata»[9]. Con mainstreaming s’intende una trasformazione nella cultura di governo, volta a valorizzare la specificità di genere in tutte le politiche comunitarie.
* Il presente post è tratto dal volume L. Di Viggiano, R. Bufano, Donne e società. Partecipazione democratica e cittadinanza digitale, Trento, Tangram, 2013.[1] B. Gelli, Psicologia della differenza di genere, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 320.
[2] Cfr. ivi, p. 297.
[3] Cfr. ivi, pp. 298, 299.
[4] Cfr. tra gli altri A. Donà, Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità, Milano, Mondadori, 2007.
[5] Varie le direttive in tal senso, dalla 1975/117 CEE per la parità delle retribuzioni, alle leggi contro le discriminazioni, alla 84/635/CEE 6 per spingere gli stati membri ad azioni a favore delle donne.
[6] «Le pari opportunità per le donne e gli uomini costituiscono il compito principale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri»: G.U. delle Comunità europee, 30/12/1995.
[7] G. Conti Odorisio, Ragione e tradizione, Roma, Aracne, 2005, p. 243.
[8] Ibidem.
[9] Ivi, p. 236.