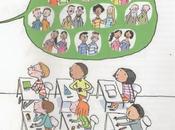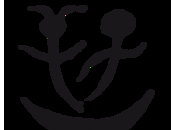Qualche giorno fa mi rammaricavo del fatto che spesso a scuola si indugi troppo sulla storia più lontana, a scapito delle vicende che hanno coinvolto le ultime generazioni.
L'evento di cui oggi ricorre il 33esimo anniversario, laStrage di Bologna, fa parte di quella parte di storia che viene appunto trascurata: non so voi, ma io non ho mai studiato né questo brutto episodio né il più ampio contesto del terrorismo e delle stragi avvenute in Italia dagli Anni di Piombo[1] ai massacri di mafia.

La stazione di Bologna il 2 agosto 1980
Alle 10.25 del 2 agosto 1980 in una sala d'attesa della Stazione di Bologna centrale l'esplosione di un ordigno di 23 kg provocò la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200 fra coloro che attendevano il treno, transitavano lungo i binari e nella piazza antistante l'edificio, restituendo uno dei bilanci più gravi della storia del secondo Dopoguerra nel nostro Paese.
I cittadini bolognesi diedero prova di un forte senso umano e civico, prodigandosi nei soccorsi e nell'aiuto agli specialisti, ma non altrettanto efficaci e ammirevoli furono le indagini e le azioni processuali: nonostante l'individuazione di una matrice di estrema destra fin dalle ore successive alla strage furono messi in atto depistaggi molto gravi, denunciati anche dagli stessi magistrati, e a tutt'oggi non si è giunti ad individuare i mandanti della strage.
Come per molte altre vicende italiane (fra cui gli attentati mortali a Falcone e Borsellino), sugli atti terroristici degli Anni di Piombo grava una cortina di disinformazione, omertà e complicità pericolose. A questo alludeva Pier Paolo Pasolini quando, nel 1974, all'indomani delle stragi di Milano, Gioia Tauro, Gorizia e Brescia[2], affermava:
"Io so. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe (e che in realtà e una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere). Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974 [...]. Io so i nomi di coloro che, tra una Messa e l'altra, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali (per tenere in piedi, di riserva, l'organizzazione di un potenziale colpo di stato), a giovani neo-fascisti, anzi neo-nazisti [...] e infine criminali comuni [...]. Io so tutti questi nomi e so tutti quanti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli. Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. [...] Probabilmente, se il potere americano lo consentirà, magari decidendo 'diplomaticamente' di concedere ad un'altra democrazia ciò che la democrazia americana si e concessa a proposito di Nixon, questi nomi prima o poi saranno detti." [3]
Un anno dopo Pasolini venne trovato morto a Ostia, e le circostanze della sua morte sono ancora oggi poco chiare. Che la morte dello scrittore e regista si leghi o meno a certe sue scomode dichiarazioni, è certo che vicende della portata di questi attentati non sarebbero rimaste irrisolte così a lungo se non vi fosse stato un concorso di forze contrarie alla fuoriuscita di indizi e notizie.

L'autobus 37, che servì come mezzo di trasporto dei feriti della strage
Non ricordare gli ultimi, drammatici avvenimenti italiani è un fatto gravissimo. Non insegnarli, non spiegarli, non dare la giusta importanza a livello mediatico e istituzionale ai frammenti di storia più recente significa assecondare l'atteggiamento degli ancora anonimi mandanti di stragi e attentati. Sono disgustata nel vedere che in una giornata come questa, divenuta per volere dell'Associazione dei familiari delle vittimeGiornata della memoria di tutte le stragi terroristiche, l'attenzione dei giornalisti, gli approfondimenti e le tavole rotonde siano dedicate alla vicenda privata di un uomo politico: come può far più clamore un processo per evasione a carico di un personaggio di spicco che la morte di decine e decine di persone di portata nazionale e comunitaria?
"Come si fa a dimenticare un numero di stragi cosi esteso e cosi recente? Per la maggior parte dei cittadini italiani queste stragi sono state eventi di cronaca: abbiamo letto le liste con i nomi dei morti e dei feriti pubblicate sui maggiori quotidiani nazionali, le abbiamo anche scorse con l'ansia di trovare qualche nome noto. Eppure anche fra i cittadini piu scolarizzati e difficile trovare un livello di conoscenza elementare di questi eventi: le date e i luoghi si confondono, alcune stragi non si ricordano nemmeno più.
Un'amnesia collettiva di simile portata non può essere liquidata sulla base di responsabilità personali, ma si può spiegare soltanto individuando i meccanismi sociali che hanno prodotto quotidianamente l'inconsapevolezza generalizzata. C'è una sorta diblackout nel discorso pubblico nazionale, un cortocircuito semantico e cognitivo che ci spinge ad ignorare il fatto che le stragi hanno segnato fortemente la coscienza democratica di questo paese. E come se questi eventi sanguinosi e traumatici ci fossero scivolati addosso, senza che nessuno (o almeno soltanto pochi) ne traesse le implicite conseguenze. Perché non ci siamo interrogati sulla natura e sulla consistenza del tessuto democratico della societa italiana di quegli anni e del presente? [...] Le stragi non sono mai divenute a livello nazionale un argomento pubblico di massa: è per questo che stentiamo a ricordare." [4]
L'oblio e la scarsa attenzione che riguardano a livello nazionale[5] i drammi della nostra storia recente sono un fatto vergognoso. Io sono alquanto diffidente nei confronti delle Giornate dedicate al ricordo di questo o quel fatto, non in quanto occasioni di commemorazione (in questo senso le ritengo sacrosante e intoccabili), ma in quanto eventi pericolosamente esposti alla pessima abitudine di molti esseri umani a sfruttarle come occasione per pulirsi la coscienza. Il ricordo delle stragi mafiose, degli attentati neri e rossi così come i più osceni genocidi del passato o le persecuzioni religiose di ieri e di oggi non possono essere consegnati a qualche celebrazione formale e alla penna dei privati cittadini che decidono di scrivere qualche riga commemorativa: occorre un coinvolgimento attivo della società, a cominciare dalle generazioni più giovani. Smettiamo di ripetere a menadito nelle scuole i più assurdi dettagli della Guerra dei Cent'anni e facciamo in modo che i diciannovenni arrivino all'esame di Stato degni della qualifica di maturità che solo l'analisi critica e attenta del nostro passato può alimentare. E smettiamola una volta per tutte di badare ai sedicenti perseguitati dalla giustizia e offriamo invece rispetto e attenzione ai morti che giustizia attendono da anni.
Solo a quel punto l'orologio della nostra storia civile riprenderà a scandire il tempo.

L'orologio antistante la Stazione di Bologna,
fermo sull'ora della strage in memoria delle vittime
"Il meditato ricordo di quegli anni che hanno insanguinato il Paese non solo costituisce un doveroso e commosso omaggio alle vittime, ma è volto a diffondere e condividere con le giovani generazioni, che non hanno vissuto quelle vicende, consapevolezza storica, sensibilità civica, convinta mobilitazione a tutela dei principi democratici sanciti dalla nostra Costituzione." [6]
C.M.
NOTE:
[1] Gli Anni di Piombo sono il periodo compreso fra la fine degli anni '60 (dalla Strage di Piazza Fontana nel 1969) all'inizio degli anni '80, caratterizzato da continue lotte armate ed episodi terroristici riconducibili all'azione di gruppi estremisti di destra e di sinistra; l'espressione deriva dal titolo di un film di Margarethe von Trotta, ambientato in una Germania che stava vivendo contemporaneamente un'esperienza simile a quella italiana.
[2] Mi riferisco ai massacri di Piazza Fontana e della Questura a Milano (1969, 17 morti e 1973, 4 morti), alla strage di Gioia Tauro (1970, 6 morti), alla trappola di Peteano (1972, 3 morti), all'attentato bresciano in Piazza della Loggia (1974, 8 morti) e alla strage dell' Italicus (1974, 12 morti).
[3] Pier Paolo Pasolini, Che cos'e questo golpe?, Corriere della Sera (14 novembre 1974).
[4] Anna Lisa Tota, Se una nazione cessa di ricordare: lo spazio del passato nelle identità nazionali, Annali d'Italianistica, 24 (2006) p. 330.
[5] Localmente, le comunità - Bologna in primis - sono invece molto coinvolte nella difesa del ricordo.
[6] Giorgio Napolitano nel messaggio inviato a Bologna per le celebrazioni odierne.