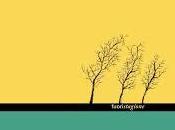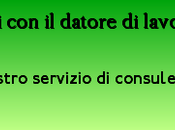Il Western è sempre stato il genere in assoluto più impermeabile a vere o presunte opere di rinnovamento. Il canone linguistico del cinema western, con il suo corposo bagaglio di convenzioni stilistiche e narrative, ha dimostrato in più di una occasione di respingere ogni tentativo di destrutturazione. Finita l’epoca d’oro dei Ford, Mann, Hawks, la generazione ribelle e iconoclasta dei vari Peckinpah, Altman, Penn, Aldrich è riuscita a modellare il genere sulle suggestioni e sugli umori che quegli anni di rinnovamento esigevano dalla società americana. Esauritasi quella spinta ideale, sembra che il cinema western abbia conosciuto lungo i decenni ’70 e ‘80 un periodo di oggettiva distanza dal presente. Negli ultimi 20 anni, con sporadiche puntate e frequentazioni, il cinema western è stato (ri)visitato da singoli autori, difficilmente uniformabili a gruppi omogenei, che hanno inscritto pagine importanti della loro “poetica” all’interno delle regole e dei canoni del genere. E’ accaduto per Costner con “Balla coi lupi”, per Eastwood con “Gli spietati”. E’ accaduto per Joel e Ethan Coen con “Il Grinta”. Con una importante variante: il loro film è un calco di un altro (vecchio) film western, del 1969, con lo stesso titolo, e con un crepuscolare John Wayne in sella nel ruolo ora interpretato da Jeff Bridges. Quel film, di Henry Hathaway (buonissimo cineasta, mai assurto a nume tutelare del genere) nasceva “vecchio” e fuori tempo massimo già nel 1969. In quello stesso anno, mentre Hathaway filmava con l’occhio benevolo e placido di un nonno affettuoso le avventure di una ragazzina ispirata da sentimenti di purezza e innocenza, Peckinpah scardinava la grammatica filmica e sconvolgeva gli spettatori con orge lisergiche di sangue e violenza. E’ quindi singolare, e dovtebbe far riflettere, il fatto stesso che i Coen abbiano scelto un film del genere come spunto per la loro personale rilettura del western americano. Io ho provato a darmi un paio di risposte in merito. Come è ovvio, non è detto che siano quelle giuste. E non è detto che siano le uniche possibili.
Come detto “Il Grinta” di Hathaway è un film invecchiato prima ancora di vedere la luce. Lontanissimo da ogni forma di revisionismo, decisamente buonista, interpretato da un attore storicamente “conservatore” giunto al capolinea della sua carriera, retorico e naif nella sua semplice linearità espressiva e nella sua celebrazione dei buoni sentimenti trans-generazionali. E’ probabile che ai Coen servisse proprio un punto di partenza come questo per articolare, nella prospettiva tipica del loro cinema, un discorso sulla purezza, sulla morte e sulla fine. Del genere “classico” (una analoga operazione i Coen la hanno portata a compimento per il noir con “L’uomo che non c’era”), di una America che fu e non solo. Il loro film, incastonato nello splendido finale, è l’epitaffio postumo scritto sulla tomba di qualcosa (o qualcuno) che è trapassato da molto tempo. E’ il ricordo scritto nella pietra di un funerale già celebrato, in un altrove indistinto e in un tempo lontano. E’ la rievocazione di un lutto. Ed è a mio parere nei minuti del finale del film che Joel e Ethan Coen hanno scolpito il senso profondo della loro ultima opera. E’ lì che bisogna cercare per scoprire il perché di una operazione che, altrimenti, rischierebbe di apparire come un vuoto esercizio di maniera. Di Mattie Ross adulta nel film del 1969 non c’è traccia. Dal momento in cui lei appare nel “Grinta” coeniano capiamo quindi di non trovarci più davanti ad un remake ma ad un sequel. La morte, la mutilazione, sono già passate. Persino l’assassinio del padre (una delle scene di apertura del film del ’69) è già avvenuto quando il film dei Coen (tramite la voce narrante di Mattie) ce lo racconta. Nel finale Mattie cerca le tracce del suo ricordo dove l’epopea della frontiera ha celebrato il suo canto del cigno: tra i carrozzoni colorati di un circo ambulante come quello (altmaniano) di Pecos Bill. Rooster Cogburn non è nemmeno lì. Il suo tempo è il passato remoto, e la sua presenza sopravvive solo nel ricordo, mutilato, di una orfana. Come già il film di Hathaway, il “True Grit” coeniano accentua quel sentore di morte e disfacimento che era già avvertibile, allora, tra le foglie autunnali illuminate da Lucien Ballard. E si conclude, il film del 2011 come quello del ’69, con il fermo-immagine di un salto che è anche una dipartita. L’ultima, prima che anche questa si sottragga definitivamente al nostro sguardo e al nostro culto.
Potrebbe esserci dell'altro. Qualche ulteriore, importante ingrediente deve aver condotto due geni della scrittura cinematografica come Joel e Ethan Coen verso il romanzo di Cahrles Portis su cui è basato il film. A pensarci bene, rivoltando il punto di vista del film, la storia di Tom Chaney, balordo senza grandi aspirazioni che per necessità di denaro e per un accidente improvvido uccide il padre di Mattie, che per futili motivi si rende responsabile della morte di un senatore del Texas e del suo cane e che per bizzarre coincidenze di eventi si ritrova braccato da un altrettanto bizzarro terzetto di inseguitori, non è poi tanto dissimile dalle vicende di molti altri personaggi dell’antologia coeniana. Il suo essere incastrato dentro una serie di sfortunati eventi ricorda i destini “esemplari” di diversi suoi degni predecessori, dal drugo Lebowski a Ed Crane. E anche la principale novità del film (il punto di vista della narrazione, coincidente con la visione del mondo di Mattie) ha un antecedente importante nel personaggio interpretato da Frances MacDormand in “Fargo”. Marge è animata dalla stessa stolida, incrollabile, marmorea fiducia femminile che sostiene Mattie. Entrambe delineano l’archetipo di donna americana strong and reliable ,pietra angolare invisibile su cui si sono costruite le basi di una società spesso “rappresentata” da maschi deboli e corrotti. Quello che è più esplicitato in Mattie Ross, rispetto a Marge, è l’aspetto religioso, fideistico e puritano, su cui poggia la sua insopprimibile intima convinzione: in fin dei conti tutti, prima o poi, dovranno pagare per le loro colpe. Perchè niente è gratuito a questo mondo, eccetto la grazia di Dio. Le risposte ad un determinismo esistenziale in apparenza arbitrario e insensato che Larry Gopnik cercava nella sapienza rabbinica, Mattie le ha trovate nel libro dei Proverbi. The wicked flee when no man pursueth: but the righteous are bold as a lion. E neanche la notte del cacciatore può spaventarlo. Di portentosa grandezza l’interpretazione di Jeff Bridges (pura immensa gloria etilica), la colonna sonora di Carter Burwell e la fotografia di Roger Deakins. Nel caso tutto quello di cui si è parlato prima vi sembrasse poco.
[**** ½]