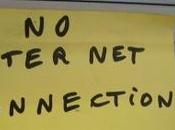Và che bèl!
La mia nonna aveva un letto con una testata in ferro. Uno di quei letti di quel tempo povero in cui già si considerava un lusso quel fondale scuro con sopra dipinte due rose e qualche fregio, tutto bordato da una bacchetta di metallo nero. Io ero piccolo e me lo ricordo altissimo quel letto, dove la mia nonna dormiva sola, ormai vedova da molti anni. E’ curioso, perché non mi ricordo niente altro di quella camera e neanche di quella casa all’interno. Forse soltanto il grande secchiello di alluminio, con un mestolo lungo lungo e pesante, con cui si andava in cortile a pompare l’acqua dal pozzo prima di riportarla in casa, due o tre volte al giorno, un po’ come fanno oggi le donne d’Africa. Io ero lì solo d’estate e non avendo mai conosciuto neppure in città, il mistero del frigorifero, quell’acqua mi sembrava meravigliosamente fresca e desiderabile, bevuta direttamente dal mestolo. Questo provocava sempre le ire della nonna, che tuttavia si limitavano alle invettive come diceva De André.
Si lamentava con mia mamma, che per la verità non le dava affatto retta, dicendo che ero troppo sparsià, vocabolo ahimè intraducibile, mi dispiace, direi un misto tra il turbolento monello e l’irrecuperabile cerca guai, che soprattutto non dà retta ai rimproveri e che non avrei combinato mai niente nella vita, cosa su cui non ha poi avuto torto, anche se invece ero di certo un bambino piuttosto tranquillo. Era un po’ rude e burbera la mia nonna, con me ma anche con gli altri e non ricordo particolari momenti di affettuosità nei miei confronti, ma forse allora si usava così. La mia mamma invece mi coccolava molto devo dire, si può dire che ero proprio un figlio unico viziatello. Comunque quelle estati di Valle San Bartolomeo avevano un sapore particolare, col gabinetto nel cortile e quelle raccomandazioni, attento a non cadere nella tampa, già mi ha sempre fatto paura quel buco nero e maleodorante. Sotto il pergolato di uva americana faceva un bel fresco, anche se quell’uva dal gusto particolare non mi è mai piaciuta, con grande scorno della mia famiglia che la magnificava ogni volta e io facevo finta di mangiarla, ma poi lasciavo sempre lì gli acini dalla buccia dura e pruinosa, schiacciati come fossero mangiucchiati.
Nelle sere di fine estate mi toccava stare seduto in cortile alla luce fioca di una piccola lampada a petrolio azzurra che conservo ancora adesso, anche se il bel tubo di vetro originale si è sbrecciato sulla estremità, a sgranare le pannocchie di granoturco, cosa che detestavo moltissimo perché il Maranino ha chicchi piccoli, tondi e infissi profondamente nel tutolo e faceva un male cane quando tentavo di staccarle con le mie ditine tenerelle di bimbo di città. Preferivo di certo andare a giocare con gli amici in giro, ma ero ancora troppo piccolo per uscire alla sera, anche se allora in campagna non succedeva niente, neanche ai bambini sparsià. La mia nonna se ne andò verso la fine dell’estate. Era caduta tornando dalla messa lungo la scalinata di mattoni e allora le fratture del femore non perdonavano quasi mai. Per la verità, non mi ricordo molto di come e di cosa successe, ho solo davanti agli occhi quel grande letto di ferro appoggiato al muro, così alto che non riuscivo a vederci sopra.
Se ti è piaciuto questo post, ti potrebbero anche interessare:
Purilli e Vov Agnolotti di Natale. La stagione secca. Caffelatte Pioggia ai baracconi. L'orologio della ferrovia.