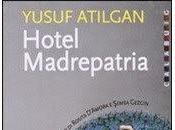Balla coi lupi è un kolossal molto particolare costruito, più che sull’efficacia delle singole scene, sull’amalgama compatto di tutta la vicenda narrata. Il ritmo del racconto è lento e cadenzato; la storia si evolve gradualmente, a volte in grandi scene collettive, a volte in brevissimi scorci lirici. Nessuno di questi passaggi è casuale, anzi tutti rientrano nella trama principale e la arricchiscono, come affluenti dello stesso fiume. Sono infatti le pause la chiave del film; sono i silenzi delle grandi praterie, gli spazi aperti e sconfinati; è il rumore del vento sull’erba. È proprio su questi elementi che indugia la regia, come se volesse estendere la sua analisi non soltanto ai personaggi, ma anche agli ambienti in cui in cui vivono e si muovono. Nel film non c’è spazio per un’indagine psicologica vera e propria: tutto è risolto in esterno, attraverso le azioni e i fatti. Per questo la pellicola mantiene intatto il suo fascino, il fascino cioè della grande avventura, senza mai risultare scontata né banale: l’esteriorità delle azioni non è fine a sé stessa, perché contiene già al suo interno le ragioni necessarie al suo procedere. È il caso, per esempio, dell’arrivo di Balla Coi Lupi (Kevin Costner) e Uccello Scalciante (Graham Greene) in una zona sacra per gli indiani, un bosco fitto dai colori autunnali, incastonato in una valle profonda e solcato da un limpido fiume. I due uomini lo osservano dall’alto di un promontorio, e sono rapiti dalla sua bellezza. Uccello Scalciante commenta: “Si dice che tutti gli animali siano nati qui; che da qui si sparsero nella prateria per fornire cibo agli uomini. Perfino i nostri nemici dicono che è un luogo sacro”. I nemici, gli indiani Pawnee, riconoscono e rispettano la sacralità del luogo. Per loro la guerra non conduce al possesso, ma soltanto all’usufrutto. Stessa cosa non può dirsi per il popolo cui appartiene per nascita l’ufficiale John Dunbar, ribattezzato Balla Coi Lupi nella lingua sioux: la sua tattica è la terra bruciata, ogni conquista lo fa sentire in diritto di disporre a piacimento delle risorse nemiche, del nemico stesso; può distruggere per un semplice capriccio. I due uomini proseguono e si inoltrano nel bosco. A un certo punto, inaspettatamente, si imbattono nei resti di un accampamento. Non è certo una visione incoraggiante: pali infissi nel terreno, tronchi abbattuti; pelli stese al sole ad asciugare; cadaveri di animali lasciati lì a marcire, cumuli di bottiglie e altra sporcizia. Le riprese si adattano immediatamente a questa nuova situazione; il linguaggio visivo si fa più essenziale, incisivo. Se un attimo prima i campi erano medi o lunghi, adesso la visuale si restringe: ai primi piani degli attori si alternano i particolari di quello sfacelo; la cinepresa è instabile, gli stacchi sono frequenti. Alla fine, quando i due si allontanano dal bosco, mortificati, li vediamo allontanarsi in campo medio, di spalle, in controluce: i colori di prima sfumano in un chiaroscuro indistinto, e i due uomini non sono altro che figure curve e nere, nere come i loro pensieri. I dialoghi, come si vede, sono stati ridotti al minimo; non sappiamo esattamente che cosa i personaggi abbiano pensato. Eppure, in questa breve sequenza si è scavato molto più a fondo di quanto non sembri a prima vista. Balla Coi Lupi si è definitivamente reso conto dell’abisso infinito che separa quei due popoli; un abisso che comprende gli usi, i costumi e la visione stessa del mondo. Per i bianchi, il mondo è un mezzo e non un fine, uno strumento con il quale migliorare continuamente la propria vita; per gli indiani, al contrario, è il fine ultimo, il modello eterno cui rapportarsi. Tutto questo lo denota principalmente il linguaggio. Se, per l’uomo bianco, il nome è sempre legato ad un passato, a una genealogia, che in qualche modo trascendono l’individuo, per gli indiani non è così: esso corrisponde solamente a quella persona, la rispecchia unicamente per quello che fa. “Non avevo mai saputo chi fosse veramente John Dunbar. Quel nome per me forse non aveva mai significato nulla. Invece, sentendo gli indiani scandire il mio nome sioux, per la prima volta in vita mia capii veramente chi ero”. Ecco dunque, di nuovo, l’importanza dell’azione. Il linguaggio dei Sioux è in fondo anche il linguaggio del film. L’azione basta a rivelare tutto, è lo spettro ampio della nostra persona. Non contano i trascorsi familiari, la nobiltà, i titoli: noi siamo solo ciò che facciamo. Come giudicare, allora, chi ha distrutto il bosco sacro? Per azioni come queste, non c’è dubbio, non esistono parole. Così è nel cinema e così è nella vita.
Balla coi lupi è un kolossal molto particolare costruito, più che sull’efficacia delle singole scene, sull’amalgama compatto di tutta la vicenda narrata. Il ritmo del racconto è lento e cadenzato; la storia si evolve gradualmente, a volte in grandi scene collettive, a volte in brevissimi scorci lirici. Nessuno di questi passaggi è casuale, anzi tutti rientrano nella trama principale e la arricchiscono, come affluenti dello stesso fiume. Sono infatti le pause la chiave del film; sono i silenzi delle grandi praterie, gli spazi aperti e sconfinati; è il rumore del vento sull’erba. È proprio su questi elementi che indugia la regia, come se volesse estendere la sua analisi non soltanto ai personaggi, ma anche agli ambienti in cui in cui vivono e si muovono. Nel film non c’è spazio per un’indagine psicologica vera e propria: tutto è risolto in esterno, attraverso le azioni e i fatti. Per questo la pellicola mantiene intatto il suo fascino, il fascino cioè della grande avventura, senza mai risultare scontata né banale: l’esteriorità delle azioni non è fine a sé stessa, perché contiene già al suo interno le ragioni necessarie al suo procedere. È il caso, per esempio, dell’arrivo di Balla Coi Lupi (Kevin Costner) e Uccello Scalciante (Graham Greene) in una zona sacra per gli indiani, un bosco fitto dai colori autunnali, incastonato in una valle profonda e solcato da un limpido fiume. I due uomini lo osservano dall’alto di un promontorio, e sono rapiti dalla sua bellezza. Uccello Scalciante commenta: “Si dice che tutti gli animali siano nati qui; che da qui si sparsero nella prateria per fornire cibo agli uomini. Perfino i nostri nemici dicono che è un luogo sacro”. I nemici, gli indiani Pawnee, riconoscono e rispettano la sacralità del luogo. Per loro la guerra non conduce al possesso, ma soltanto all’usufrutto. Stessa cosa non può dirsi per il popolo cui appartiene per nascita l’ufficiale John Dunbar, ribattezzato Balla Coi Lupi nella lingua sioux: la sua tattica è la terra bruciata, ogni conquista lo fa sentire in diritto di disporre a piacimento delle risorse nemiche, del nemico stesso; può distruggere per un semplice capriccio. I due uomini proseguono e si inoltrano nel bosco. A un certo punto, inaspettatamente, si imbattono nei resti di un accampamento. Non è certo una visione incoraggiante: pali infissi nel terreno, tronchi abbattuti; pelli stese al sole ad asciugare; cadaveri di animali lasciati lì a marcire, cumuli di bottiglie e altra sporcizia. Le riprese si adattano immediatamente a questa nuova situazione; il linguaggio visivo si fa più essenziale, incisivo. Se un attimo prima i campi erano medi o lunghi, adesso la visuale si restringe: ai primi piani degli attori si alternano i particolari di quello sfacelo; la cinepresa è instabile, gli stacchi sono frequenti. Alla fine, quando i due si allontanano dal bosco, mortificati, li vediamo allontanarsi in campo medio, di spalle, in controluce: i colori di prima sfumano in un chiaroscuro indistinto, e i due uomini non sono altro che figure curve e nere, nere come i loro pensieri. I dialoghi, come si vede, sono stati ridotti al minimo; non sappiamo esattamente che cosa i personaggi abbiano pensato. Eppure, in questa breve sequenza si è scavato molto più a fondo di quanto non sembri a prima vista. Balla Coi Lupi si è definitivamente reso conto dell’abisso infinito che separa quei due popoli; un abisso che comprende gli usi, i costumi e la visione stessa del mondo. Per i bianchi, il mondo è un mezzo e non un fine, uno strumento con il quale migliorare continuamente la propria vita; per gli indiani, al contrario, è il fine ultimo, il modello eterno cui rapportarsi. Tutto questo lo denota principalmente il linguaggio. Se, per l’uomo bianco, il nome è sempre legato ad un passato, a una genealogia, che in qualche modo trascendono l’individuo, per gli indiani non è così: esso corrisponde solamente a quella persona, la rispecchia unicamente per quello che fa. “Non avevo mai saputo chi fosse veramente John Dunbar. Quel nome per me forse non aveva mai significato nulla. Invece, sentendo gli indiani scandire il mio nome sioux, per la prima volta in vita mia capii veramente chi ero”. Ecco dunque, di nuovo, l’importanza dell’azione. Il linguaggio dei Sioux è in fondo anche il linguaggio del film. L’azione basta a rivelare tutto, è lo spettro ampio della nostra persona. Non contano i trascorsi familiari, la nobiltà, i titoli: noi siamo solo ciò che facciamo. Come giudicare, allora, chi ha distrutto il bosco sacro? Per azioni come queste, non c’è dubbio, non esistono parole. Così è nel cinema e così è nella vita.
Magazine Cultura
 Balla coi lupi è un kolossal molto particolare costruito, più che sull’efficacia delle singole scene, sull’amalgama compatto di tutta la vicenda narrata. Il ritmo del racconto è lento e cadenzato; la storia si evolve gradualmente, a volte in grandi scene collettive, a volte in brevissimi scorci lirici. Nessuno di questi passaggi è casuale, anzi tutti rientrano nella trama principale e la arricchiscono, come affluenti dello stesso fiume. Sono infatti le pause la chiave del film; sono i silenzi delle grandi praterie, gli spazi aperti e sconfinati; è il rumore del vento sull’erba. È proprio su questi elementi che indugia la regia, come se volesse estendere la sua analisi non soltanto ai personaggi, ma anche agli ambienti in cui in cui vivono e si muovono. Nel film non c’è spazio per un’indagine psicologica vera e propria: tutto è risolto in esterno, attraverso le azioni e i fatti. Per questo la pellicola mantiene intatto il suo fascino, il fascino cioè della grande avventura, senza mai risultare scontata né banale: l’esteriorità delle azioni non è fine a sé stessa, perché contiene già al suo interno le ragioni necessarie al suo procedere. È il caso, per esempio, dell’arrivo di Balla Coi Lupi (Kevin Costner) e Uccello Scalciante (Graham Greene) in una zona sacra per gli indiani, un bosco fitto dai colori autunnali, incastonato in una valle profonda e solcato da un limpido fiume. I due uomini lo osservano dall’alto di un promontorio, e sono rapiti dalla sua bellezza. Uccello Scalciante commenta: “Si dice che tutti gli animali siano nati qui; che da qui si sparsero nella prateria per fornire cibo agli uomini. Perfino i nostri nemici dicono che è un luogo sacro”. I nemici, gli indiani Pawnee, riconoscono e rispettano la sacralità del luogo. Per loro la guerra non conduce al possesso, ma soltanto all’usufrutto. Stessa cosa non può dirsi per il popolo cui appartiene per nascita l’ufficiale John Dunbar, ribattezzato Balla Coi Lupi nella lingua sioux: la sua tattica è la terra bruciata, ogni conquista lo fa sentire in diritto di disporre a piacimento delle risorse nemiche, del nemico stesso; può distruggere per un semplice capriccio. I due uomini proseguono e si inoltrano nel bosco. A un certo punto, inaspettatamente, si imbattono nei resti di un accampamento. Non è certo una visione incoraggiante: pali infissi nel terreno, tronchi abbattuti; pelli stese al sole ad asciugare; cadaveri di animali lasciati lì a marcire, cumuli di bottiglie e altra sporcizia. Le riprese si adattano immediatamente a questa nuova situazione; il linguaggio visivo si fa più essenziale, incisivo. Se un attimo prima i campi erano medi o lunghi, adesso la visuale si restringe: ai primi piani degli attori si alternano i particolari di quello sfacelo; la cinepresa è instabile, gli stacchi sono frequenti. Alla fine, quando i due si allontanano dal bosco, mortificati, li vediamo allontanarsi in campo medio, di spalle, in controluce: i colori di prima sfumano in un chiaroscuro indistinto, e i due uomini non sono altro che figure curve e nere, nere come i loro pensieri. I dialoghi, come si vede, sono stati ridotti al minimo; non sappiamo esattamente che cosa i personaggi abbiano pensato. Eppure, in questa breve sequenza si è scavato molto più a fondo di quanto non sembri a prima vista. Balla Coi Lupi si è definitivamente reso conto dell’abisso infinito che separa quei due popoli; un abisso che comprende gli usi, i costumi e la visione stessa del mondo. Per i bianchi, il mondo è un mezzo e non un fine, uno strumento con il quale migliorare continuamente la propria vita; per gli indiani, al contrario, è il fine ultimo, il modello eterno cui rapportarsi. Tutto questo lo denota principalmente il linguaggio. Se, per l’uomo bianco, il nome è sempre legato ad un passato, a una genealogia, che in qualche modo trascendono l’individuo, per gli indiani non è così: esso corrisponde solamente a quella persona, la rispecchia unicamente per quello che fa. “Non avevo mai saputo chi fosse veramente John Dunbar. Quel nome per me forse non aveva mai significato nulla. Invece, sentendo gli indiani scandire il mio nome sioux, per la prima volta in vita mia capii veramente chi ero”. Ecco dunque, di nuovo, l’importanza dell’azione. Il linguaggio dei Sioux è in fondo anche il linguaggio del film. L’azione basta a rivelare tutto, è lo spettro ampio della nostra persona. Non contano i trascorsi familiari, la nobiltà, i titoli: noi siamo solo ciò che facciamo. Come giudicare, allora, chi ha distrutto il bosco sacro? Per azioni come queste, non c’è dubbio, non esistono parole. Così è nel cinema e così è nella vita.
Balla coi lupi è un kolossal molto particolare costruito, più che sull’efficacia delle singole scene, sull’amalgama compatto di tutta la vicenda narrata. Il ritmo del racconto è lento e cadenzato; la storia si evolve gradualmente, a volte in grandi scene collettive, a volte in brevissimi scorci lirici. Nessuno di questi passaggi è casuale, anzi tutti rientrano nella trama principale e la arricchiscono, come affluenti dello stesso fiume. Sono infatti le pause la chiave del film; sono i silenzi delle grandi praterie, gli spazi aperti e sconfinati; è il rumore del vento sull’erba. È proprio su questi elementi che indugia la regia, come se volesse estendere la sua analisi non soltanto ai personaggi, ma anche agli ambienti in cui in cui vivono e si muovono. Nel film non c’è spazio per un’indagine psicologica vera e propria: tutto è risolto in esterno, attraverso le azioni e i fatti. Per questo la pellicola mantiene intatto il suo fascino, il fascino cioè della grande avventura, senza mai risultare scontata né banale: l’esteriorità delle azioni non è fine a sé stessa, perché contiene già al suo interno le ragioni necessarie al suo procedere. È il caso, per esempio, dell’arrivo di Balla Coi Lupi (Kevin Costner) e Uccello Scalciante (Graham Greene) in una zona sacra per gli indiani, un bosco fitto dai colori autunnali, incastonato in una valle profonda e solcato da un limpido fiume. I due uomini lo osservano dall’alto di un promontorio, e sono rapiti dalla sua bellezza. Uccello Scalciante commenta: “Si dice che tutti gli animali siano nati qui; che da qui si sparsero nella prateria per fornire cibo agli uomini. Perfino i nostri nemici dicono che è un luogo sacro”. I nemici, gli indiani Pawnee, riconoscono e rispettano la sacralità del luogo. Per loro la guerra non conduce al possesso, ma soltanto all’usufrutto. Stessa cosa non può dirsi per il popolo cui appartiene per nascita l’ufficiale John Dunbar, ribattezzato Balla Coi Lupi nella lingua sioux: la sua tattica è la terra bruciata, ogni conquista lo fa sentire in diritto di disporre a piacimento delle risorse nemiche, del nemico stesso; può distruggere per un semplice capriccio. I due uomini proseguono e si inoltrano nel bosco. A un certo punto, inaspettatamente, si imbattono nei resti di un accampamento. Non è certo una visione incoraggiante: pali infissi nel terreno, tronchi abbattuti; pelli stese al sole ad asciugare; cadaveri di animali lasciati lì a marcire, cumuli di bottiglie e altra sporcizia. Le riprese si adattano immediatamente a questa nuova situazione; il linguaggio visivo si fa più essenziale, incisivo. Se un attimo prima i campi erano medi o lunghi, adesso la visuale si restringe: ai primi piani degli attori si alternano i particolari di quello sfacelo; la cinepresa è instabile, gli stacchi sono frequenti. Alla fine, quando i due si allontanano dal bosco, mortificati, li vediamo allontanarsi in campo medio, di spalle, in controluce: i colori di prima sfumano in un chiaroscuro indistinto, e i due uomini non sono altro che figure curve e nere, nere come i loro pensieri. I dialoghi, come si vede, sono stati ridotti al minimo; non sappiamo esattamente che cosa i personaggi abbiano pensato. Eppure, in questa breve sequenza si è scavato molto più a fondo di quanto non sembri a prima vista. Balla Coi Lupi si è definitivamente reso conto dell’abisso infinito che separa quei due popoli; un abisso che comprende gli usi, i costumi e la visione stessa del mondo. Per i bianchi, il mondo è un mezzo e non un fine, uno strumento con il quale migliorare continuamente la propria vita; per gli indiani, al contrario, è il fine ultimo, il modello eterno cui rapportarsi. Tutto questo lo denota principalmente il linguaggio. Se, per l’uomo bianco, il nome è sempre legato ad un passato, a una genealogia, che in qualche modo trascendono l’individuo, per gli indiani non è così: esso corrisponde solamente a quella persona, la rispecchia unicamente per quello che fa. “Non avevo mai saputo chi fosse veramente John Dunbar. Quel nome per me forse non aveva mai significato nulla. Invece, sentendo gli indiani scandire il mio nome sioux, per la prima volta in vita mia capii veramente chi ero”. Ecco dunque, di nuovo, l’importanza dell’azione. Il linguaggio dei Sioux è in fondo anche il linguaggio del film. L’azione basta a rivelare tutto, è lo spettro ampio della nostra persona. Non contano i trascorsi familiari, la nobiltà, i titoli: noi siamo solo ciò che facciamo. Come giudicare, allora, chi ha distrutto il bosco sacro? Per azioni come queste, non c’è dubbio, non esistono parole. Così è nel cinema e così è nella vita.
Possono interessarti anche questi articoli :
-
Hotel Madrepatria, di Yusuf Atilgan (Calabuig)
Anatolia, terra ponte fra Asia e Europa, luogo di contaminazioni e ibridazioni storiche, epiche, territorio in cui si è compiuto uno degli eterni confronti tra... Leggere il seguito
Da Angeloricci
CULTURA, LIBRI -
3 Days to Kill con Kevin Costner: la recensione
3 Days to Kill: Kevin Costner è Ethan Renner e Ethan Renner è Kevin Costner. Tra attore e personaggio c’è perfetta identità. Entrambi sono alla soglia dei... Leggere il seguito
Da Onesto_e_spietato
CINEMA, CULTURA -
It’s a long way to the top… Puntata n.2, David Brin
Torna la rubrica “It’s a long way to the top”, Fralerighe è lieta di presentarvi David Brin, uno dei più famosi autori di fantascienza contemporanei! 1)... Leggere il seguito
Da Rivista Fralerighe
CULTURA -
Film stasera in tv: L’UOMO D’ACCIAIO (dom. 26 apr. 2015, prima tv in chiaro)
L’uomo d’acciaio, Italia 1, ore 21,20. Prima tv. L’uomo d’acciaio (Man of Steel), un film di Zack Snyder. Con Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin... Leggere il seguito
Da Luigilocatelli
CINEMA, CULTURA, PROGRAMMI TV, TELEVISIONE -
Harry potter tag!
Buongiorno amici lettori!E buon lunedì! Oggi è proprio caldo, mi ero messa un po' fuori ma mi sono dovuta mettere all'ombra perché stavo per evaporare... Leggere il seguito
Da Eliza
CULTURA, LIBRI -
Terra di confine – Open Range
Quando l’ingiustizia regna sovrana ce chi decide di lottare rischiando tutto. Titolo: Terra di confine – Open Range Regia: Kevin Costner Cast: Robert Duvall,... Leggere il seguito
Da Sbruuls
CINEMA, CULTURA