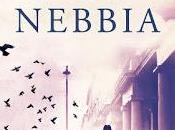In fondo, dovevamo saperlo anche noi che non era modo di svegliarlo così, tirandolo dal sonno come un secchio dal pozzo. Così, senza la promessa di una gita o uno svago, ma solo con la minaccia di levarti le coperte di schiena e l’uovo dal pane di mezzogiorno. Matteo brontolava tutte le volte come il ragazzino che era, però si metteva a sedere, gli occhi ancora piombati dalla cispa mentre con la mano cercava i calzini del giorno prima nel tiepido delle lenzuola. Non gli piaceva trovarli freddi e cominciare la sua giornata con quella malagrazia nelle scarpe. Faceva così da sempre, anche quando andava a scuola, ma da lì mio padre lo aveva tolto appena fuori la quinta elementare e a niente era servito che il vecchio professore, il maestro, il prete e poi una guardia del comune avessero fatto la strada fino a casa.
In fondo, dovevamo saperlo anche noi che non era modo di svegliarlo così, tirandolo dal sonno come un secchio dal pozzo. Così, senza la promessa di una gita o uno svago, ma solo con la minaccia di levarti le coperte di schiena e l’uovo dal pane di mezzogiorno. Matteo brontolava tutte le volte come il ragazzino che era, però si metteva a sedere, gli occhi ancora piombati dalla cispa mentre con la mano cercava i calzini del giorno prima nel tiepido delle lenzuola. Non gli piaceva trovarli freddi e cominciare la sua giornata con quella malagrazia nelle scarpe. Faceva così da sempre, anche quando andava a scuola, ma da lì mio padre lo aveva tolto appena fuori la quinta elementare e a niente era servito che il vecchio professore, il maestro, il prete e poi una guardia del comune avessero fatto la strada fino a casa.
Mio padre aveva rischiato due volte di dare i polsi alla galera e alla fine aveva piazzato un forcone dietro la porta, per chiunque venisse a preoccuparsi ancora del figlio grande. Era andata avanti per settimane, finché non venne il giorno che l’arnese lo imbracciò Matteo, e quello fu anche l’ultimo che si vide gente in casa. In seguito a mio fratello non è che gli fosse dispiaciuta quella mossa ma di non avere un pomeriggio per tirare le biglie contro il muro, questo sì che lo toccava dentro, e abbastanza in fondo da farlo patire come un adulto. La faccenda stava messa così: c’era chi andava in chiesa a pregare il suo dio all’ora della messa grande, invece Matteo il suo creatore ce l’aveva in casa, ci mangiava a gomito, gli portava gli attrezzi da lavoro e il calcestruzzo della betoniera per dodici ore a giornata, e lo temeva. Matteo temeva la collera del padre come gli egiziani della dottrina davanti alle piaghe del castigo.
La penitenza più grossa era d’alzarsi presto, solo quello. Poi, avviato il giorno, il sangue gli si drizzava e si sentiva leggero, più di quando andava a scuola sul pulmino comunale, coi quaderni nella schiena e in testa i sacramenti di nostro padre da ripetere al primo che gli dava del tardivo scrutandogli la testa rasa. Dicevano che mio fratello teneva una piega strana nel cervello, se a dodici anni voleva solo coricarsi con le mani nere e la stanchezza nelle ossa: altrimenti gli pareva di rubarsela, la giornata. Perciò quando al cantiere qualcuno mise il nome di nostro padre tra quelli che potevano infilare le braccia nella camicia e tornarsene in strada, Matteo s’abituò a saltare la scuola e ad accettare lavori da niente, in certe case e cortili dove la gente ti guardava da servo e ti controllava il passo per capire se rubavi.
Anche per questo mio padre accettò d’alzare quel muro che gli altri mastri avevano schivato come la morte. Messo di petto alla proposta, aveva guardato lontano, come per trovare la cima della montagna di cose che non andavano, s’era schiarito la gola e all’uomo che era venuto a domandare aveva detto semplicemente:
«Si può fare».
Solo quando di sera mise il lucchetto alla porta, profittando che la moglie era nella camera in fondo, si voltò verso Matteo per dirgli: «Verrai anche tu». E andò a letto senza fargli una carezza né un saluto, come se ci fosse del male a scambiarsi un po’ d’amore.
Il muro non era alto, anzi, se in certi punti si fermava alla cintola in altri era quanto uno stinco di cane. Andarono a vederlo di giorno e fu subito chiaro a tutti che una riparazione sarebbe servita da tempo. Finché era rimasto vivo don Niccolò, il nipote confinante s’era guardato bene dal fargli richiesta di recupero, ma adesso che il vecchio se n’era andato e il figlio aveva tutta l’aria di infischiarsene del podere, del coltivato, e dei mezzadri che ne avevano cura, adesso sembrava il momento buono.
«In avanti lo dovete spostare il confine», aveva detto il nipote di Niccolò, brusco come l’acqua di marzo, «avanti almeno di due metri ». Poi s’era preparato da fumare usando una cartina: con due dita aveva disposto una striscia di tabacco, il filtro e aveva arrotolato con cura prima di inumidire il bordo perché aderisse: «Buttate giù il muro vecchio di giorno e tornate di notte a far salire le pietre», aggiunse pulendosi le dita contro i vestiti. «Con tutta la sterpaglia e il pruneto in rovina da quelle parti chi volete che s’accorga di dove parte e dove finisce il bene mio?»
Mio padre aveva accettato senza fatica, perché di lavorare a giorno s’era stancato e voleva una cifra seria sotto il cuscino, da poterci fare al minimo un mese di tregua. Si doveva andare in fretta, però, prima che venisse pioggia, prima che il cielo si mettesse contro: soprattutto prima che la luna grossa sfilasse via e non si vedesse a un braccio per lavorare.
«Non oltre il prossimo plenilunio», assicurò fissando il calendario, pur sapendo che mancavano pochi giorni.
Quella notte Matteo e mio padre avevano piegato la schiena sotto una luna che mandava tanto chiaro da scoperchiare le cose. S’erano dati poche parole e di striscio, perché quel silenzio era diverso dagli altri e troppe volte la campagna aveva dato segnali, come se avesse occhi e braccia e denti. Il muro, che aveva camminato in avanti, già si sollevava e loro continuavano. In fondo non mancava nemmeno tanto per finire la commessa. Poi avremmo tirato tutti un respiro. Saremmo stati di nuovo gente da trattare con rispetto e mai più su questa terra e in questa vita qualcuno ci avrebbe squadrati dall’alto.
Neanche quando i rumori erano diventati indiscreti e Matteo aveva alzato la testa, neanche allora il padre s’era rassegnato a smettere la fatica: aveva ripreso il figlio colpendogli una mano per farsi capire meglio. Di sicuro l’aveva chiamato come gli altri potevano permettersi, come un fratello forse, o un ragazzo di strada può fare, ma non un padre.
«Tra poco la fortuna cambia», gli aveva detto continuando a spostare pietre. «Ci compriamo tutto…»
Se anche aveva pensato di domandargli cosa avrebbe voluto lui, Matteo, alla fine non l’aveva fatto, e s’era chinato a impastare il cemento con la cazzuola finché la luna durava.
Intorno era venuto silenzio. Ma per poco. Come di quando si prepara una rovina. Poi tutto era successo in fretta: un’ombra tra gli alberi, un ramo spezzato da un passo e in lontananza l’abbaiare d’un cane.
Forse Matteo stava pensando alla festa di paese e che ci sarebbe andato col meglio vestito. Che lavorare era una cosa buona e che senza, lui si sarebbe sentito peggio nell’anima. Forse stava pensando a nostra madre e al suo vestito che sapeva di cucina e lavandino, quando mio padre d’improvviso gli ordinò di correre colpendogli la spalla col pugno. Matteo ci mise un po’ a capire, perché era sempre stato pigro di mente. Perse del tempo a imbroccare la direzione giusta, ché tutte gli parevano buone e cattive assieme. Quel tempo lo pagò caro. Il proiettile arrivò mentre correva, lo trovò di schiena e lo lasciò a terra come un animale sbandato, fermandogli addosso due cose: una fama da disonesto e una gamba indurita nei pantaloni. Non aveva pianto, aveva solo chiamato una volta sua madre, come quando in cortile, d’estate, si spellava un ginocchio.
Io sono diventato grande e inutile quella notte di sedici anni fa: mentre Matteo e mio padre cercavano di guadagnarsi anche per me il diritto a essere uomini e vivi. Rimasi a letto, nonostante le voci in corridoio, perché il giorno dopo c’era scuola, e se Matteo aveva il dovere di saltarla a me era destinato il riscatto d’una famiglia: la camicia stirata di fresco, le ore giuste da dormire, e i pensieri miseri che mi passavano i maestri. Alla fine abbiamo fatto il nostro dovere, Matteo e io.
Adesso ci vediamo poco, perché le nostre vite hanno preso pieghe diverse. Delle due è la mia quella più piegata. Credono tutti ch’io sia felice, che negli uffici asettici dove mi rinchiudo per giornate intere, dietro le scrivanie sgomberate di polvere, io abbia trovato un rimedio. Una risposta. Una cura. Nessuno sa niente di come vivo, delle mie notti di vergogna, che quando c’è luna grossa non riesco a dormirla né a stare con una donna. Certo, ho un lavoro pulito. Che Matteo nemmeno se lo sogna. Lui continua con le pietre, la calce, la rena da impastare, le giornate di schiena al sole e di faccia al vento. Però la notte dorme, assicura mia madre quando chiamo per mandarle un aiuto. Dorme, come avesse il cuore in pace.
Come avesse perdonato.
L’ultima volta che l’ho visto è stato alla festa di paese, giocava a biglie con certi ragazzini che ridevano della sua testa girata sempre sui venerdì, e si sgomitavano nei fianchi a ogni tiro. Perché alla sua età Matteo non accetta di perdere con le creature e quando succede s’incorna come un toro.
Non l’ho chiamato nemmeno: a un certo punto m’è mancato il coraggio di vedermelo davanti intero, come il muro disonesto che vidi una volta sola prima che fosse tirato giù e indietro. Su questo sì che ci aveva pianto, mio fratello. Nel suo letto da ragazzo e poi in quello da marito: ogni notte di luna piena.
Le mie serate, invece, sono d’un’altra pasta: vago per le camere, guardo fuori, ascolto. Le case nere dei vicini. Le lavatrici che girano. Le strade. Le poche macchine di chi lavora o va a inventarsi l’amore. Sono nottate lente e senza sbocco. Poi al mattino tiro alte le tapparelle e la luce nella stanza, mi vesto con cura, prendo la borsa e come niente fosse vado a lavorare.
Elisa Ruotoloè nata nel 1975 a Santa Maria a Vico (Caserta), e vive ancora lì. Laureata in Lettere Classiche, insegna italiano e storia in un istituto superiore. Ha pubblicato racconti in due antologie Fernandel e su varie riviste tra cui Nuovi Argomenti. Ho rubato la pioggia (Premio Renato Fucini, finalista al Premio Cocito-Montà d’Alba) è il suo primo libro, pubblicato nel 2010 presso l'editore Nottetempo. Un suo racconto inedito è stato tradotto in tedesco e inserito in A Casa Nostra - Junge italienische Literatur, un'antologia dei tipi di Wagenbach a cura di Paola Gallo e Dalia Oggero.
A cura di Sara Gamberini e Giovanni Ragonesi
Media: Scegli un punteggio12345 Nessun voto finora