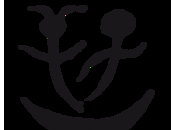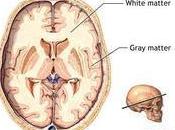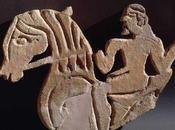Innanzi tutto, se non diamo per scontato il fatto che Machiavelli escluda la politica dal campo della morale e che quindi la sua scienza politica sia da considerarsi a-morale, vuol dire che abbiamo letto cose diverse e non abbiamo un argomento comune di cui parlare.
Bada bene, dico a-morale e non immorale, sono due cose completamente diverse, e ti faccio notare che, con una leggerezza che mi ha non poco stupito, definisci Machiavelli immorale.
Egli non infrange la morale, non la irride ma, semplicemente, afferma che l’applicazione delle sue categorie non è compatibile con la politica, che è di conseguenza a-morale, e che il Principe, con VIRTU’, debba affrontare la NECESSITA’ e prevedere gli alterni casi della FORTUNA (termini il cui significato non credo che io debba spiegare a una conoscitrice ed estimatrice del pensiero machiavellico).
Machiavelli non solo riconosce i limiti della natura umana ma, in virtù della sua visione pessimistica e immanentista, li codifica, in modo da ottenere il meglio del peggio, in forma tale che essi non possano che perpetuare se stessi, limitandosi a proporre quel “Remedium iniquitatis” di cui, francamente, mi sfugge quella potenzialità, quello “Sprone a migliorarci” di cui parli.
Più che di un limite della natura umana parlerei, piuttosto, di un limite di Machiavelli che, rivolgendosi esclusivamente a una “realtà effettuale” e immanente, la ritiene insuperabile e ne propone, solo ed esclusivamente l’ottimizzazione.
Una visione che non può essere condivisa da chi, viceversa, si riferisca a una verità trascendente e a una soteriologia e a un’escatologia cristiana.
Con ciò, ovviamente, non affermo che noi si sia così ingenui, o così folli da proporre il paradiso in terra e non si sia perfettamente consapevoli dei limiti della nostra natura. Limiti, però, che sono assai più estesi e possono tendere alla perfezione attraverso la sinergia tra fede e ragione.
Una visione cui sono estranee la ragion di stato o la statolatria (concetti cari a un Machiavelli che si era nutrito di cultura pagana) e secondo la quale, pur riconoscendole, le ragioni di Cesare vengono sempre dopo quelle di Dio, cui tutto, anche la politica, deve essere sottomesso.
Federico Bernardini