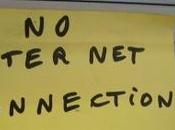Care amiche, oggi pubblico nel blog un mio scritto “alternativo”. E’ un mio racconto, inserito all’interno di una serie di racconti dedicati alle donne, che spero di pubblicare presto. Ma è ancora tutto in itinere.
Perché pubblico questo scritto proprio qui, proprio oggi?
Perché su Facebook ho letto, grazie a Rita Saraò della Rivoluzione Gentile, di una gran bella iniziativa: a Rieti, il 13-14-15 luglio si discuterà di Invidia, Competizione e Cooperazione tra donne. Per info: http://www.rivoluzionegentile.it/
E allora mi è venuto in mente il mio racconto. Un caso di mobbing al femminile, vissuto sulla pelle. Ve ne propongo una parte.
Credo che possa far nascere qualche piccola riflessione, in ciascuna di noi.
QUEL BREVE, TRANQUILLO…. CASO DI MOBBING
“….. Non ricordo neppure più come, un giorno mi ritrovai lì. Il mio primo giorno di lavoro in un palazzo enorme, moderno, con vetrate e ascensori ovunque. Area industriale.
In uno dei piani alti del palazzo stile New York City c’erano gli uffici della holding che mi avrebbe accolto nel suo staff. Probabilmente, dopo una settimana di prova, avrei avuto l’incarico di assistente del direttore. Cercavano quella figura. E avrei dovuto dare anche disponibilità a viaggiare, con il medesimo direttore e personale tecnico di contorno.
Mi presentai quindi sul luogo di lavoro, puntuale come un orologio svizzero e fui affidata ad una tutor molto gentile ed esperta: la ragazza avrebbe dovuto erudirmi sulle conoscenze e competenze necessarie ed indispensabili, per rendermi autosufficiente nel giro di sette giorni, sette.
Ma già da quel primo giorno, mi resi conto che c’era qualcosa di strano intorno a me.
Le vetrate, gli arredi modernissimi, le attrezzature tecnologiche: tutto faceva pensare ad un mondo di perfezione ed efficienza. Ma nell’aria c’era qualcosa di pesante.
Percepivo sopra di me sguardi fissi, costanti, inquisitori.
Sentivo bisbigliare il mio nome.
Vedevo gruppi di persone che si fermavano a pochi passi dalla mia scrivania, con la faccia di chi sta testando il nemico.
“Forse è perché sono nuova. E’ il primo giorno e devo darmi pazienza. Domani andrà meglio!” e con questo pensiero incoraggiante mi trascinai fino all’ora di pranzo. Un’ora circa di pausa (o poco meno) da utilizzare alla mensa interna, al piano terra del palazzo.
La mia tutor, sempre gentile ed educata, mi accompagnò appunto nell’area bar-ristorante-buffet.
“Scegli pure un piatto. Paga l’azienda. I pasti sono compresi nei servizi che ci offre la holding. Bello vero?” e la mia tutor, entusiasta del fatto di poter godere di tanta magnanimità, mi mostrò la vetrina del bancone bar.
“Vorrei quella fetta di torta. Grazie” timidamente avevo fatto la mia scelta.
Una fetta di torta con le mele. Lo ricordo ancora. Piccola. Unica e solitaria. L’ultima fetta di torta con le mele rimasta in quel vassoio di plastica tondo.
“Non si può. Quella no!” e con un piglio deciso e molto aggressivo il donnone con camice dietro il banco continuò “Vuole altro?”
In quel preciso istante, una ragazza intravista più volte negli uffici dei piani alti, si avvicinò sicura e sfrontata al banco e il donnone, senza esiti e senza parlare, le porse quella fetta di torta con le mele.
“Allora? Deve ancora pensarci su oppure ha deciso? Vuole qualcosa?” mi apostrofò ancora la donna.
“No, grazie….” e io con un certo nodo in gola dalla rabbia uscii dalla mensa, lasciando lì la mia tutor che nel frattempo si era seduta ad un allegro tavolo di colleghe.
Mi ricordo che l’unica cosa che riuscii a pensare fu: “magari domani mi porto dei crackers.”
Povera stupida bambina. Vent’anni. Me lo facessero oggi a quaranta, penserei “magari domani porto della candeggina e la verso sulla torta….”
Il pomeriggio trascorse come la mattinata: in un’atmosfera meravigliosamente pesante.
La sera a casa, non avevo neppure la forza di parlare. Era come se mi avessero spento il cervello: perché avevo dovuto utilizzare tutte le possibili sinapsi per il lavoro e per difendermi dal nemico.
“Non chiedermi niente, per favore….” dissi laconica a mia madre che mi guardava preoccupata e certa del “qualcosa che non va”. Le madri hanno un sesto senso. E pure un settimo. Ma a volte è meglio tenerle a distanza di sicurezza, perché sennò c’è da consolare noi stesse e loro. Troppa fatica.
Il secondo giorno andò uguale al primo, se non peggio. L’unica variante fu il pacchetto di crackers che mangiai nella mia automobile, parcheggiata nell’area appositamente e logisticamente adibita per le vetture dei dirigenti e degli impiegati della magnifica holding. Piccolo tetrapak di succo di frutta e via.
Se i primi due giorni potevo sospettare di soffrire di manie persecutorie, tale ipotesi sfumò come neve al sole, in qualche nano secondo all’avvio della terza giornata di lavoro.
Adesso anche la tutor sembrava acida come una mozzarella andata a male. Mi piazzava quintali di fogli con dati da inserire nel p.c., senza concedere spiegazioni o informazioni, senza parlarmi, senza emettere un fiato. Tutto sbattuto seccamente sulla scrivania: non più la sua, ma un banchetto messo di traverso in una sorta di corridoio. Un banchetto traballante, con qualche chiodo che spuntava qua e là.
Ma non era la holding delle meraviglie? Com’è che avevo quel misero banchetto da sette nani?
E ora che nessuno mi rivolgeva più la parola, come facevo a capire ciò che avrei dovuto fare?
Allora tentai un approccio gentile e mite alla tutor, ma ormai anche lei sembrava passata dalla parte nemica. Sembrava posseduta da una sfinge egizia.
“Scusami, questi dati li inserisco in questo file?” provai a domandare.
“Lasciami lavorare per favore. Non posso farti da bay sitter in eterno!” e con ciò la tutor aveva preso la sua bella decisione. Aveva fatto la sua scelta. Una scelta certamente indotta, decisa da altre.
Sì, altre. Perché esattamente al terzo giorno, capii (e fu una vera epifania) che le mie nemiche, guarda un po’, erano tutte donne. Gli uomini, pochi (due o tre), stavano lì come merluzzi ad ascoltare il bisbiglìo sommesso e ad osservare le gomitate e gli sguardi di fuoco contro la mia scrivania-banchetto. Ma poi, alla fin della fiera, si facevano i fatti loro.
Il gruppo di Erinni era costituito da una dozzina di giovani donne, più o meno trentenni. Più o meno eleganti, veloci, efficienti, ciarliere. Più o meno terribili.
Certo, avevo inquadrato il nemico. Ma il motivo di tanta guerra mi era ancora ignoto.
Andai avanti così, per i sette giorni sette di prova.
E al settimo giorno lavorativo (numero principe della cabala) fui convocata dal direttore. La cosa strana è che io non l’avevo ancora visto in faccia, né gli avevo parlato.
“Allora attiviamo la pratica per lei? Si procede. E’ d’accordo?” mi chiese subito il direttore senza guardarmi negli occhi, con una penna nella mano destra e il telefono nella mano sinistra.
E a quella domanda, mi apparvero davanti, scorrendo molto velocemente, le immagini, i fotogrammi di quegli ultimi terribili giorni.
“Ma io dovrei lavorare con questa gente folle?” semplice domandina da porsi. Minimo sindacale.
“Io me ne vado!” dissi con una certa sicurezza. Erano circa le dieci della mattina di quel fatidico giorno del risveglio della mia fiammella di autostima.
Non ricordo la faccia del direttore, né quello che mi disse nel salutarmi garbatamente.
Ricordo però il gruppetto di donne davanti all’ascensore.
Erano lì per un’autoglorificazione?
Erano lì per godere della loro vittoria?
Erano lì per ridere di me in modo finalmente aperto e godereccio?
No. Assurdo. Molto più assurdo.
Le cospiratrici, tutor compresa (con lacrima da coccodrillo agli occhi), erano lì per chiedermi scusa.
“Sai, forse ti sei accorta che siamo state un po’ scostanti con te. Credevamo che tu fossi qui per rimpiazzare una nostra collega in malattia. Temevamo che tu le rubassi il posto!” dichiarò in un solo fiato la “capa” del gruppo.
“E non avevate capito che io ero qui, in prova, per il posto di assistente del direttore?” esplosi io, ormai noncurante di toni di voce, sguardi e anatemi vari.
“No. Scusaci. Non avevamo capito….”
Non avevano capito.
E la tutor che mi insegnava a fare l’assistente dirigenziale? Lei tentò di giustificarsi dicendo: “ma io ho avuto l’incarico di doverti insegnare cose generiche d’ufficio. Nessuno mi ha mai specificato il tuo ruolo….”
Ah ecco. Un “qui pro quo”. Una sciocchezza. Una bazzecola trasformata in un inferno di sette giorni.
Mi allontanai da loro.
Poi, all’ascensore, mi girai e guardai la tipa che si era presa la mia fetta di torta di mele. Le sorrisi: “Sai, quella fetta di torta? Ci ho pianto tutta la sera. Non per la torta. Semplicemente, sei riuscita a farmi sentire…. inesistente.” Lei mi guardò con gli occhi spalancati, come persa: aveva dipinto sul volto un devastante senso di colpa.
Ora gli occhi di quelle ex spavalde erano tutti abbassati a terra, a guardare quella moquette grigia e perfetta, della holding perfetta, del palazzo perfetto.
Uscii da quel luogo, felice di respirare una fantastica aria inquinata di smog.”