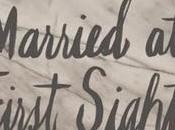Centro commerciale di periferia
Centro commerciale di periferia
La cellula fotoelettrica ti manda a sbattere sulle porte ancora chiuse, l’entrata a pareti di vetro e plexiglass è afosa come una serra tropicale, le scale mobili sono rotte.
Sono rotte da mesi.
Le cicche si sono infilate nelle scanalature del nastro metallico e sembrano bossoli di cartucce pronti a sparare. Gli spazi per i cartelloni vuoti o con i manifesti strappati e scivolati giù.
È caduta una puntina, nessuno l’ha sostituita. Un lembo del cartellone pende come un brandello di pelle.
Il pavimento di piastrelloni color avorio è sporco del nero coca cola, evaporata e calpestata da mille suole di scarpe: ognuna ha lasciato la sua impronta gommata a zig zag diversi. Nei corridoi vetrati il caldo sembra non finire mai. Le macchinette delle bibite sono mezze vuote, come distributori di benzina nel deserto dell’Arizona.

Finalmente si passa la porta automatica che mette nella galleria dei negozi, si spera di fare un salto termico di dieci gradi, invece la temperatura è quasi la stessa. Niente più vecchi signori col bastone a presiedere le brutte panchine a doghe di legno, parcheggiati da nipoti e figli per i quali fare la spesa è uno svago, azzuffarsi nella calca alle file dei formaggi e della carne una vittoria sul nemico.
Il bar è assediato da persone assetate, la ragazza che fa il caffè ha fatto il lifting alle labbra, è canottata anche lei come Alba Parietti. Il suo caffè non sembra più tanto desiderabile. I pavimenti sono ancora sporchi, ma nessuno li vede, tutti gli sguardi sono diretti alle vetrine. Montature e occhiali da sole impilate in torri di plastica bianchissima, dietro ognuna ci potrebbe essere un Vashta Nerada che ti fissa in attesa di cannibalizzarti.

Abiti in colori sgargianti, magliettine scollate per giovani veline di provincia, manichini neri e senza occhi, capezzoli finti e seni perfetti che ti puntano come baionette innestate. Montagne di mutande con pizzi colorati, borse di coccodrillo vero o finto, non si sa, profumi e bestseller del momento. Cartacce, volantini, pubblicità.
IPER, il tuo sito fa orrore? Stay up, never hide, enjoy, don’t panic, love, wear, water, sweater, better.
L’uomo è dio, recita il cartello di benvenuto, se letto attraverso la deformazione del vetro d’ingresso.

Ragazze con i sandali a zeppa color verde pavone fluo a strisce nere. Viaggiano in gruppi di tre, la meno bella sempre qualche passo indietro, i loro corpi vibrano di quell’illusione di libertà concessa dalla società alle ragazze, ma nessuno le guarda, sono malvestite, senza eleganza. La donna troppo piena, stanca e flaccida persino per far la parte della “Signorina Gradisca”, spinge un carrello con dentro un pargolo urlante. I ragazzi si muovono veloci, a scatti, palestrati, non guardano intorno, hanno fretta.
Tutti bisbigliano tra loro, altri camminano urlando, ma non è facile capire: il suono arriva deformato, come filtrato da un Babelfish al contrario. Il grande assente: il cellulare. Dentro il centro commerciale non c’è campo.
Tutto è sempre lo stesso. Qui La squadra riparazioni non ci ha mai messo piede.
È doloroso ma pietoso, raramente bello: solo al di fuori, i carrelli abbandonati vicino ai mucchi di travi in ferro, nella parte più lontana del parcheggio, e il sole che muore languendo di un rosso strappacuore tra le chiome degli alberi. I bordi d’erbe bruciati, una vigna poco distante, con i pampini tutti coperti del verde smeraldo del rame. Due galline protette da una rete.

Perché qui una volta era tutta campagna.
Ciò che vive nel dolore ha il potere di sommuovere i nostri cuori, ma questo è il regno dell’indifferenza. I manichini osservano con sguardo superiore il brulichio indistinto delle persone, soppesano i loro desideri con la lungimiranza di chi è fatto di plastica non biodegradabile: ne ho viste di cose…

Archiviato in:Conoscenza, agnizione, ricerca Tagged: centro commerciale, iper, la gru siderno, Siderno, supermercato