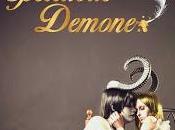Ho scritto questo racconto anni e anni fa, non ricordo nemmeno quanti, di preciso.
Ricordo però lo stato d’animo che mi animava durante la stesura: rassegnazione; era un periodo di lotte burocratiche: con il mio datore di lavoro, con le segreterie universitarie, con la sanità pubblica, con gli uffici comunali.
Quelle piccole, infinite, fastidiosissime lotte quotidiane che tutt* quant* conosciamo così bene.
E la storia del campo del calcio è, circa, vera.
Ovviamente ci ho ricamato sopra, altrimenti che racconto sarebbe, ma prende spunto da un fatto reale: un campo da calcio costruito con fondi europei in pochissimi mesi…un ecomostro venuto su al margine di un bosco (in un paesino dove mancano le scuole, tanto per dirne una); a me, sinceramente, due domande mi sono sorte in proposito.
Anche la data in cui ho deciso di pubblicarlo non è casuale: il 2 giugno; che poi dovrebbe – e sottolineo il condizionale – essere la festa della repubblica italiana.
Ma quale festa?
Che c’è da festeggiare?
Una repubblica di cui io, sinceramente, mi sento ben poco parte; anche ‘sti festeggiamenti mica mi convincono tanto…una parata militare.
Ma sul serio?
Con tutti i problemi e i debiti che abbiamo andiamo a spendere soldi per sta cosa?
Ma spendiamoli meglio…che so, un servizio pubblico in più, ma anche solo una cosa più bella e partecipata…no?
Insomma, in sostanza, il succo è che siamo tutt* dei Mario Rossi; siamo tutt* in balia di un sistema dove essere zelanti e onesti non paga; dove l’intopatore[1] di turno ci passa sempre avanti e ha sempre ragione.
Siamo sicuri di volere proprio un paese così, dove vivere?
E famosele, due domande…
[1] termine dialettale toscano; letteralmente una persona che vive di intrallazzi, imbrogli, accordi; colui che entra, come le pantegane, passando dai buchi nascosti.
Respirò a fondo e guardò l’orologio, 00.17, precise, il rumore metallico incominciò: un battere incessante, a intervalli regolari; sapeva che proveniva dalla recinzione metallica del grande campo sportivo costruito appena pochi mesi prima davanti a casa sua, da più di un mese alle 00.17 precise iniziava quel rumore snervante, dieci interminabili minuti, poi svaniva nel nulla.
Tic, silenzio, tic, silenzio, tic, silenzio, tutti i muscoli le tremarono per il fastidio, detestava i rumori ad intervalli regolari.
Tic, silenzio, tic, silenzio, tic, silenzio….
Cercò di controllare il brivido che le scendeva giù per la schiena…perché? Si chiese perché aver paura di una cosa del genere? Poteva essere qualsiasi cosa: un ragazzino che si divertiva a far scherzi, un cane abituato ad uscire a quell’ora…Eppure qualcosa, una sensazione di disagio, le suggeriva che non fosse così…uscì, snervata, afferrò la felpa e infilandola varcò la grande porta di legno; si avvicinò a grandi passi alla recinzione, guardandosi attorno: nessuno.
Si avvicinò, afferrando la rete tra le mani, il rumore cessò di colpo, scrutò il grande campo illuminato dalla luna, vuoto.
La figura biancastra al centro del campo la guardò con aria triste, rassegnata, provò a parlarle ma dalla sua gola non uscì nessun suono, gli occhi di lei che scrutavano l’orizzonte alberato gli fecero capire che non si era minimamente accorta di lui.
Le corse incontro, appoggiandosi alla recinzione, con occhi lacrimosi provò a toccarle una mano, niente, gli occhi di lei lo trapassavano come nulla fosse; provò di nuovo a parlare, niente, non un solo suono, non una sola reazione.
Diede un calcio alla rete, provò a scuoterla, ma nulla accadde; la ragazza si girò, provò ad afferrarle la felpa da un buco, la stoffa scivolò leggera attraverso la sua mano.
Tornò a sedersi in mezzo al campo erboso con la testa tra le mani, piangendo e singhiozzando, ma persino il suo pianto era muto.
Dopo un tempo che gli sembrò infinito riprese a camminare vacuamente per il campo, avanti, indietro, destra, sinistra, non gli importava…un uomo vecchio portava a spasso il cane, passò vicino alla recinzione, buttò un occhio all’interno e poi proseguì; due ragazzi sui diciotto anni scesero da una macchina, si baciarono a lungo, poi lei sparì dentro una casa e la macchina ripartì; gli uomini della nettezza urbana arrivarono alle prime luci dell’alba, ritirarono i sacchetti fuori da ogni porta e ripartirono.
Si sentì cogliere da un sonno profondo, come ogni volta quando si riebbe era in mezzo al campo da calcio, solo, illuminato solo dalla fievole luce lunare, si avvicinò ad uno dei pali metallici della rete, lo colpì con il cinturino dell’orologio: ne scaturì un suono metallico; continuò a lungo, ma nessuno venne, nemmeno la ragazza della sera prima.
Quando, all’ennesimo colpo, il rumore smise di diffondersi nell’aria si rese conto che i suoi dieci minuti erano scaduti e riprese a camminare per lo stadio, come la notte prima, e quella prima, e quella prima, e quella prima, pensando alla sua vita inutile e alla sua morte altrettanto inutile.
Una volta aveva un nome, ma ora, probabilmente, non importava più, anche in vita non era stato un gran nome, si chiamava Mario Rossi, il nome più comune esistente in Italia e lui era esattamente così, l’uomo più comune esistente in Italia; era stato un impiegato al catasto, aveva quarant’anni e non era sposato, niente figli, niente fidanzata, aveva un Rolex falso, comprato da un marocchino davanti a un hotel che non si sarebbe mai potuto permettere, leggeva la Gazzetta dello Sport mentre beveva il cappuccino al bar e guardava il tg una volta tornato a casa.
Il suo unico neo? Per una volta, una sola volta, era stato troppo zelante nel suo lavoro.
Un paio di sere prima di morire era stato in una discoteca con un collega ed aveva conosciuto una donna, si chiamava Mara, aveva qualche anno meno di lui e tra loro era subito scoccata la scintilla; il mattino seguente era di buon umore, lesse sulla Gazzetta che la sua squadra del cuore aveva vinto quattro a zero, il cappuccino era persino sembrato più buono; in ufficio un omino basso, tarchiato, si presentò per acquistare un terreno comunale, gli spiegò che ci avrebbe costruito qualcosa di stupendo, l’Europa concedeva grossi finanziamenti per queste cose.
Lui fece presente che su quel terreno non poteva essere costruito nulla, gli mostrò tutti i documenti che negavano i permessi; l’omino se ne andò.
Mario Rossi fece rapporto dell’accaduto al suo capo, il suo lavoro era talmente noioso che un fatto del genere andava certo riferito.
Il sovraintendente lo elogiò, promettendogli una promozione, gli disse che però ora era in partenza per Nonsisadove e che sarebbe tornato solo a fine settimana, ma questa cosa era degna di essere trattata subito, per cui lo invitò a portagli i documenti la sera stessa del suo rientro e spiegò dove doveva essere l’appuntamento.
Mario si presentò puntuale, il capo era lì, sventolò la cartellina con i documenti ma il suo sorriso non fece in tempo nemmeno a spegnersi: due rumori appena udibili, un dolore acuto al petto, l’omino uscì dall’ombra con la pistola ancora in mano.
Cadde, vide appena l’omino sfilargli la cartellina dalla mano e bruciarla, lì, in mezzo al parcheggio.
Quattro uomini lo presero, poi fu il buio.
Quando si risvegliò si guardò attorno e capì: era stato sepolto sotto una spessa colata di cemento armato, la prima, che avrebbe portato alla costruzione del campo da calcio.
E così ogni notte camminava, su e giù, prigioniero, tentando di farsi notare da qualcuno.
Ma nessuno l’aveva mai notato in vita, come poteva sperare che lo notassero nella morte?
Nemmeno un maniero gli era toccato, ma uno stupido campo da calcio, non c’erano stati né angeli, né spiegazioni, né giudizi: Mario Rossi era morto; ed era morto nel più stupido e comune dei modi, era morto per una speculazione, l’attività più comune in Italia.