In Pensieri selvaggi a Buenos Aires Alberto Arbasino chiude il suo libro con un’intervista a Jorge Luis Borges realizzata nel 1977. Tra due degli scrittori più colti del Novecento scaturisce un dialogo che cerca quasi di fornire una nomenclatura essenziale della letteratura moderna. Il discorso metaletterario, forzato da tempistiche prettamente televisive, arriva in realtà ben presto ad insabbiarsi in un ben poco stimolante gioco della torre, dove i vari giudizi estetici sui colleghi di penna vengono sciorinati secondo la logica della brillantezza aforistica più che su quella di un corposo ragionamento. Ma d’altronde è giusto ricordare che non è in una tale sede encomiastica che va ricercato il maggior contributo esplicativo dell’arte della scrittura da parte dell’autore argentino. Tralasciando per ovvie ragioni di spazio e per parziale gusto personale la notevole produzione saggistica, Borges aveva infatti già affrontato l’argomento in quasi tutte le sue opere poetiche e narrative, fino a pervenire a quel vertice assoluto che è L’Aleph, l’ormai preclara (non troppo a dire il vero, se nella classifica redatta da Le Monde sui cento libri più importanti del Novecento gli viene preferito il quasi coevo Finzioni) raccolta di racconti da me letta nell’edizione Universale Economica Feltrinelli e tradotta da Francesco Tentori Montalto. Parto proprio dalla fine di questa succinta silloge, e cioè dalla storia omonima che dà il titolo al libro. In un arco spaziale di appena venti pagine Borges riesce, con classe sopraffina, a portare avanti contemporaneamente diversi generi letterari. Vi è innanzitutto una compatta tela narrativa che, dalla morte di Beatriz alla scoperta dell’Aleph, mantiene un suo solido dispiegamento nonostante la sopraccitata eterogeneità di stili che a volte la circostanzia. Non si assiste, insomma, alla prevaricazione del saggista sul narratore, come avviene ad esempio in La ricerca di Averroè, né a un supino accomodamento dello scrittore al pensatore come in Biografia di Tadeo Isidoro Cruz (1829-1874).

Borges qui lascia a frasi brevi, apparentemente sconnesse dall’impianto cronologico, il compito di sussurrare al lettore stati d’animo e accecanti illuminazioni come questa: «Compresi che il lavoro del poeta non consisteva nella poesia, ma nell’invenzione di ragioni perché la poesia fosse ammirevole; naturalmente, questo lavoro modificava l’opera per lui, ma non per gli altri». Così la tristezza dello stesso Borges, protagonista del racconto, incidentale e quasi accidentale per la parca misura con cui è delineata nella prima parte, viene ad assumere gradatamente una valenza più marcata nel finale, dopo la svolta metafisica che sconvolge il tran tran della rassegnazione post mortem. Anche ne I teologi quella che appare dapprima come una disputa accademica cavillosa su quale argomentazione possa essere più brillante per sedare le pericolose eresie degli Anulari, si trasforma in una sorprendente riflessione sul tema del doppio. Materia già cara all’autore, qui ulteriormente ampliata da una sottile divagazione retorica sulla competizione intellettuale e sulla tenue linea di demarcazione che separa la tolleranza dal dogmatismo. Altro esempio in cui Borges riesce a trasformare simulacri di cultura, con tutta la storia simbolica di cui sono carichi, in splendidi strumenti metaforici atti a delineare le sue profondissime intuizioni è il racconto L’immortale. Facendosi sottilmente beffa di una delle questioni più dibattute nella storia della letteratura, Omero in questa novella è fatto diventare portavoce di una nuova e pessimistica visione dell’immortalità, non più ingenuamente celebrativa: «Essere immortale è cosa da poco: tranne l’uomo, tutte le creature lo sono, giacché ignorano la morte; la cosa divina, terribile, incomprensibile, è sapersi immortale». Ancora una volta nel finale lo scrittore argentino gioca col tema dell’identità, come a voler rimarcare l’assoluta incertezza di quello che con gonfio positivismo osiamo definire reale.
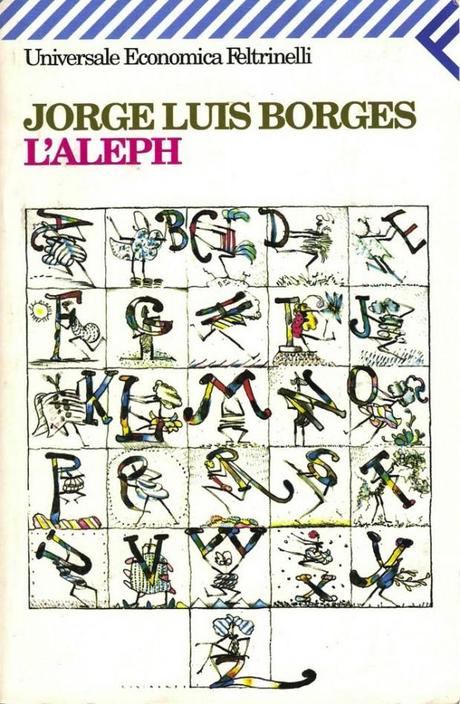
Proseguendo in questa rilettura zigzagata della raccolta, una menzione d’onore va al mai ricordato Deutsches Requiem che mostra come il bistrattato filo-europeismo di un autore sudamericano (che non si sa per quale giustificazione analitica si vorrebbe officiante culturale del folklore argentino) sappia in realtà addentrarsi con inaudita profondità psicologica, estranea a tanti tedeschi, nella mentalità di un teutonico aguzzino colluso con il nazismo. Borges dimentica volontariamente il senso tutto luterano della colpa per quella follia storica che ancora affligge la Germania e inscrive quella fase di violenza nella necessità di un destino che sarebbe comunque dovuto accadere, tingendo di grandezza tragica perfino la barbarie. I due racconti più tipicamente borgesiani che giocano con la dimensione del mistero razionale tipica dell’autore sono comunque La casa di Asterione e La scrittura del dio, entrambi osannati dalla critica perché nella loro brevità funzionano bene come manifesti di stile dello scrittore argentino. «L’estasi non ripete i suoi simboli; c’è chi ha visto Dio in una luce, c’è chi lo ha scorto in una spada o nei cerchi di una rosa» (La scrittura del dio): io l’ho avuta leggendo L’Aleph.








