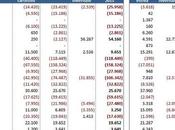ANALISI (Torino). Serve di più. Questo è lo slogan che nel day-after giornali e televisioni stanno largamente utilizzando per descrivere l’eliminazione della Juventus dalla Champions per mano del Bayern. “Troppo più forte” questo Bayern secondo tifosi e appassionati. Già, ma in che cosa è davvero così tanto più forte la squadra, o sarebbe meglio dire la società, bavarese paragonata agli attuali e, presumibilmente, futuri campioni d’Italia?
ANALISI (Torino). Serve di più. Questo è lo slogan che nel day-after giornali e televisioni stanno largamente utilizzando per descrivere l’eliminazione della Juventus dalla Champions per mano del Bayern. “Troppo più forte” questo Bayern secondo tifosi e appassionati. Già, ma in che cosa è davvero così tanto più forte la squadra, o sarebbe meglio dire la società, bavarese paragonata agli attuali e, presumibilmente, futuri campioni d’Italia?
Il doppio turno dei quarti di finale di Champions induce a un’analisi spaccata in due: ciò che si è visto sul campo e ciò che accade al di fuori del rettangolo verde.
Il Bayern Monaco è una compagine completa, solida e di qualità in quasi tutti i settori del campo. A livello individuale soffre un po’ in elementi quali Van Buyten, Boateng e, a volte (non è il caso di ieri sera), Dante, ma ha un impianto talmente organizzato e collaudato che in fase difensiva i bavaresi soffrono davvero poco. Dopo l’immensa delusione della finale persa in casa propria, Lahm e compagni hanno aggiunto ulteriore benzina a un motore che già viaggiava ottimamente: il dominio in Bundesliga e il percorso compiuto fino a oggi in Europa testimoniano la bontà del progetto tecnico, un progetto che l’anno prossimo avrà come timoniere Pep Guardiola, tanto per non accontentarsi.
Eppure qualcosa ci induce a pensare che la Juve che in Italia comanda non sia quella squadra leggera e intimidita vista negli ultimi 180 minuti europei. Un Pirlo misteriosamente (?) opaco, un Marchisio senza brillantezza, le squalifiche di Vidal e Lichtsteiner al ritorno, qualche episodio che non si è “incanalato” per il verso giusto (espulsione sacrosanta di Ribery, ammonizione ingiusta per lo stesso Lichtsteiner, posizione molto sospetta di Mandzukic sul gol di Muller a Monaco…) fanno insomma ipotizzare una Juve che, a pieno regime, avrebbe potuto recitare una parte migliore rispetto a quella andata in scena in questi quarti di finale.
Con l’ormai tiritera del “serve di più”, lo sappiamo, si indica inevitabilmente nell’attacco il reparto che necessita di un’aggiunta, un giocatore che negli ultimi 20-25 metri metta in apprensione qualsiasi difesa: tutte e quattro le semifinaliste della Champions, infatti, hanno come terminale offensivo un attaccante che “la butta dentro”, o comunque, vedasi Bayern, un reparto offensivo che mette paura solo a leggerlo sul giornale.
Insomma, la Juve avrebbe potuto giocarsi qualche arma in più con un organico a pieno servizio, nel quale ci inseriamo la fondamentale assenza di Pepe (senza il quale Conte è costretto al 3-5-2) e alla lunga convalescenza di Isla, moto perpetuo prima del brutto infortunio.
In realtà Marotta ha già lavorato in ottica attaccanti, facendo suo Fernando Llorente, un nome che attualmente paga l’inattività riservatagli dall’Athletic Bilbao e una carta d’identità spagnola che poche volte in passato ha significato grandi soddisfazioni nelle compagini italiane, ma che, tuttavia, ha dalla sua una confidenza con il gol niente male.
Llorente ci permette, però, di mettere il piede fuori dal prato dello Stadium e prendere in considerazione altri fondamentali aspetti che hanno inciso sul cammino europeo della Vecchia Signora e, in generale, dell’ennesima figuraccia – perché di questo si tratta – del calcio italiano in campo internazionale.
Innanzitutto, la favola del top player è da sfatare una volta per tutte.
Attualmente la Juventus è il club italiano maggiormente all’avanguardia dal punto di vista societario, quindi in progettazione, redditività, strutture e modernizzazione. Nonostante ciò, chiedere ad Agnelli e Marotta di gareggiare con i competitors europei riguardo all’ingaggio dei Falcao, dei Cavani, dei Suarez, è pressochè impossibile: la Juve non ha la possibilità di acquistare attaccanti simili spendendo dai 40 milioni di euro in su.
Al di là dell’inesperienza dei ragazzi di Conte nella massima competizione continentale (non è vero che al primo anno non si può vincere: contro i campioni d’Europa del Chelsea gli inesperti sembravano i Blues), è la differenza di contesto nel quale la Juve agisce a tracciare il divario con i club che regnano in Champions.
In Germania, per esempio, i tanto elogiati stadi tedeschi hanno già quasi dieci anni: questo significa che, rispetto alla società torinese che ha inaugurato lo Stadium un anno e mezzo fa, da circa un decennio i vari Bayern Monaco e Borussia Dortmund stanno beneficiando delle risorse provenienti dai loro “catini”, risorse che rivestono un’importanza fondamentale in assenza del magnate di turno disposto a “giocare”.
Continuando il paragone con la Germania, anche l’aspetto dei settori giovanili incide. Per stessa ammissione di Oliver Bierhoff, campione d’Europa con i panzer tedeschi e vincitore in Italia con il Milan di Zaccheroni, i teutonici hanno fatto una vera e propria tabula rasa dopo i Mondiali del 1998, investendo nelle giovani leve e traendone alla lunga enormi vantaggi: gli stranieri in Bundesliga si sono ridotti notevolmente, nei club aumentano i calciatori provenienti dal vivaio, nelle formazioni che scendono in campo vi sono frequentemente blocchi collaudati da anni di sfide giocate fianco a fianco.
Ciò che, però, le italiane stanno pagando inevitabilmente davanti a inglesi, spagnole e tedesche, è l’enorme difficoltà del sistema-calcio nel quale agiscono a livello nazionale. Detto di stadi – ancora senza normativa da parte del legislatore– e di settori giovanili (brutto segno le dimissioni di Baggio dal settore tecnico), i top club nostrani sbattono continuamente contro lo stallo dell’italico pallone, con istituzioni che dormono e la totale mancanza di innovazione.
Non è un caso che proprio la Juve, nell’ultima elezione a presidente della Lega Serie A, si sia fatta promotrice del nome di Abodi: un club all’avanguardia vedeva senza dubbio di buon occhio un uomo moderno e innovativo come presidente. E non è un caso che invece Abodi sia dovuto tornare con la coda fra le gambe alla sua Serie B, davanti all’imperante rifiuto al cambiamento proprio della maggior parte dei patron della A. Un esempio come tanti in un’Italia che non vuole crescere ma che, con i posti validi alla Champions già passati da quattro a tre, resta a scannarsi in polemiche arbitrali e insulti a distanza.
La realtà è che la Juve ha diversi motivi per sorridere, nonostante l’eliminazione.
Lo spread, per usare un termine fortemente in voga, che esiste in questo momento è destinato a ridursi se solo la Uefa applicasse la metà di quanto sta promettendo.
Con il fair-play finanziario, realtà neonate come Manchester City e Paris Saint Germain dovranno necessariamente rivedere i loro piani di sperperio illimitato; la Liga spagnola, ma sarebbe meglio dire l’intera economia del paese, dovrà presto o tardi fare i conti con l’indebitamento di Barcellona e Real Madrid, la cui esistenza è affidata, con veri e propri drammi finanziari, al supporto delle banche nazionali. L’Inghilterra, grazie ai ricchissimi accordi sui diritti TV, tornerà a beneficiare di molta liquidità, ma il Manchester United non potrà nascondere in eterno il comunque enorme indebitamento raggiunto con la sua proprietà americana.
Insomma, quatta quatta la Juve targata Agnelli-Marotta sta facendo il suo, e lo sta facendo bene. Quando i dirigenti bianconeri parlano dei risultati raggiunti, si riferiscono anzitutto alla rivalutazione di un parco giocatori che solamente un anno e mezzo fa valeva quanto una squadra di metà classifica spagnola. L’appeal sugli sponsor, inoltre, è decuplicato rispetto alle due annate terminate al settimo posto. Vuoi mettere con uno Scudetto vinto…?
E poi il potere di attrazione nel calciomercato, la fidelizzazione del tifoso, il prestigio – seppur non totalmente – ritrovato, la cittadella juventina in fase di realizzazione attorno allo stadio; di motivi per guardare con ottimismo al futuro in Corso Galileo Ferraris ve ne sono eccome.
Certo, l’eliminazione e la sconfitta di per sé bruciano un po’, come è giusto che sia. Ma per ora la Juve merita senza dubbio elogi.
Serve di più? Forse non contro il Bayern, ma contro lo spread.