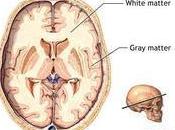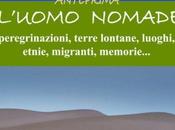Ieri la Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile è stata condannata per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni personali con riferimento al fatto che la Commissione avrebbe dato ""informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica vanificando le attività di tutela della popolazione" dopo le scosse che si erano registrate nei mesi precedenti al terremoto del 6 aprile 2009 all'Aquila.
Condannati sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Enzo Boschi (al tempo presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Bernardo De Bernardinis vice capo tecnico del dipartimento di Protezione civile, Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e. e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile. Avrebbero ucciso 29 persone e ferite 4. Secondo i sostituti procuratore Roberta D'Avolio e Fabio Picuti, infatti, gli imputati "sono venuti meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro funzione" anche sotto il profilo dell'informazione, con notizie rassicuranti che "hanno indotto le vittime a restare nelle case". "Così delimitata la materia del giudizio - scrive Stefano Rodotà su Repubblica -, non sarebbe la scienza ad essere sotto accusa, ma i comportamenti specifici delle persone riunite d'urgenza in quella mattinata, di chi ha scritto il comunicato, di chi guidava la Protezione civile".
Quali sono questi comportamenti? Il 31 marzo 2009, 6 giorni prima il disastro, la riunione della Commissione per valutare i rischi di un terremoto (che non si può prevedere) durò appena un'ora. Iniziò alle 18:30 e finì alle 19:30. Gli esperti sapevano che la "scossa sismica nel territorio aquilano durava da sei mesi". Per i pm "una corretta analisi dei rischi e una corretta informazione avrebbero potuto, in primo luogo, suggerire misure di prevenzione a livello collettivo quali, ad esempio, la previa selezione e individuazione di luoghi di raccolta da comunicare alla popolazione, indicazioni sulle vie di fuga, su come radunarsi, su come prestare assistenza o abbandonare le abitazioni danneggiate, l'allestimento o il potenziamento di mezzi di soccorso immediatamente operativi, l'aumento della recettività ospedaliera e delle strutture di primo soccorso, o anche una più generale consapevolezza e una più ampia preparazione all'emergenza".
Durante un'intervista televisiva di giorno 31 De Bernardinis parlo di "fenomenologia sismica normale. Non c'è pericolo, anzi è una situazione favorevole perchè c'è uno scarico di energia continuo. Ci sono pochi danni. Siamo pronti a fronteggiare la situazione. Chiedo ai cittadini di starci vicino". Significa che, secondo le valutazioni degli scienziati, i cittadini potevano restare a casa e che, comunque, erano ben salvaguardati anche in caso di pericolo.
Ancora: per gli scenziati era "improbabile che ci potesse essere a breve una scossa come quella del 1703, pur se non si poteva escludere in maniera assoluta". Per i pm, però, non si tenne sufficientemente conto, se non in maniera frettolosa, di una ricerca del 2005 dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, " usata per l'elaborazione di modelli probabilistici di pericolosità sismica".
Secondo un documento diffuso dal Dipartimento della protezione civile nei giorni precedenti la scossa, gli edifici all'Aquila non erano a rischio. E questo è un problema, perchè nel 1999 il "Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia", cui contribuirono tre degli imputati (Barberi, Eva e Dolce), si legge che che "all'Aquila su un totale di 752 edifici in muratura analizzati, ben 555 ricadevano in fascia di vulnerabilità medio-alta". Almeno tre degli imputati conoscevano bene l'edilizia aquilana.
In un altro studio del 2007 Boschi, Barberi e Guido Bertolaso scrivono: "La vulnerabilità del patrimonio edilizio è così elevata che sono possibili ancora nel futuro eventi catastrofici di enormi dimensioni. Nella città di L'Aquila, per citare un altro esempio, il numero delle vittime in caso di ripetizione del massimo terremoto storico sarebbe di 4.000 - 14.500". Si ribadisce, insomma, che la Commissione Grandi Rischi conosceva bene l'ediliza pericolante del capoluogo abruzzese.
Sempre durante la riunione del 31 marzo Selvaggi "evidenzia come ci siano stati anche alcuni terremoti recenti preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero che molte sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti". Che fare in questi casi? Correre il rischio di essere accusati di allarmismo? Ma questa è un'attitudine sbagliata, tipica della "medicina difensiva", come scrive ancora Rodotà: "di fronte al rischio di dover risarcire possibili danni [...], ecco, allora, la prescrizione infinita di accertamenti preventivi, di analisi forse inutili, fino alla rinuncia ad effettuare interventi ritenuti troppo rischiosi non per il malato, ma per il chirurgo. Forse, di questa attitudine difensiva abbiamo già avuto una prova in occasione dell'allarme recente su un nubifragio a Roma, rivelatosi in buona parte infondato, ma che evidentemente rifletteva la volontà di non trovarsi di nuovo di fronte ad una emergenza incontrollabile, com'era avvenuto in occasione della memorabile nevicata dell'inverno scorso. Meglio questo, si dirà, che far correre rischi alle persone. Ma un regime di allarme permanente e generalizzato, non filtrato da alcuna valutazione scientifica, può alterare le dinamiche sociali, produrre costi ingiustificati".
Barberi conclude quel 31 marzo dicendo che " oggi non ci sono strumenti per fare previsioni e qualunque previsione non ha fondamento scientifico. Il problema va, invece, visto nei termini generali, perché l'unica difesa dai terremoti consiste nei rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto". Ma non è bastato.
Oggi l'ufficio Presidenza della Commissione, presidente Luciano Maiani, presidente emerito Giuseppe Zamberletti e vicepresidente Mauro Rosi, ha rassegnato in blocco le dimissioni. Per Zamberletti ''il rischio è che gli scienziati non se la sentano più di esprimere liberamente il risultato delle proprie conoscenze. Che garanzie hanno che gli studi fatti non possano diventare oggetto di una responsabilità penale? Manca una normativa".
Questi i fatti. Un'amara considerazione: ma a processo non dovrebbero andarci politici e imprenditori edili che hanno messo in piedi questa Italia cementificata e sgangherata? E ancora stiamo a parlare di Ponte sullo Stretto?