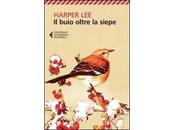Magari non tutti sanno che Italo Calvino scrisse tre romanzi collegati tra loro e che lo rese noto solo dopo che vennero pubblicati. Stiamo parlando della trilogia de “I nostri antenati” che comprende i famosissimi Il visconte dimezzato (1952), Il barone rampante (1957) e Il cavaliere inesistente (1959).
Partiamo da Il visconte dimezzato. Leggendo il titolo dell’opera ci si aspetta che la parola “dimezzato” abbia un significato solamente metaforico: forse si racconta di un visconte la cui fortuna viene dimezzata da un furto oppure la cui contea viene divisa a metà fra lui e un lontano parente che sostiene di esserne il legittimo erede. Quello che non ci si aspetta (o che io non mi aspettavo) è di leggere del Visconte Medardo di Terralba che a causa di una cannonata si è ritrovato letteralmente diviso in due. La sua parte destra viene recuperata intatta, con un occhio, un orecchio, mezza bocca, mezzo mento e mezza fronte, il tutto perfettamente vivo e conservato, se si tralascia l’enorme squarcio dove fino a poco tempo prima aderiva la parte sinistra del suo corpo. “Vivo e dimezzato”, Medardo torna a Terralba, dove guadagna ben presto il soprannome di Gramo poiché si macchia della colpa di aver compiuto atti di ineffabile malvagità. Ebbene sì, la parte restante del Visconte era un concentrato di malvagità. Mentre questo mezz’uomo imperversa sulla sua contea seminando terrore anche tra i suoi famigliari, compare l’altra sua parte, il Medardo buono, anch’essa miracolosamente messa in salvo e curata. Figura antitetica al Gramo, il Buono comincia a compiere azioni di una bontà indicibile che paradossalmente si rivelano dannose tanto quanto le crudeltà compiute dal suo opposto e complemento. Entrambe le metà sono convinte che la spaccatura abbia dato loro una più chiara conoscenza del mondo: il Gramo afferma che lui fa del male esattamente come lo fanno tutti gli altri, l’unica differenza è che lui lo fa con mano sicura; il Buono invece sostiene che essere dimezzato gli abbia permesso di riconoscere che in fondo tutti sono dimezzati e non lo sanno. Come non individuare in questo scontro tra il Gramo e il Buono la metafora di uno scontro più universale e ancestrale, cioè quello tra bene e male? In questo senso l’opera di Calvino è fortemente metaforica e spinge a riflettere sul contrasto che ognuno in sé può percepire, ma lo fa in un modo leggero e ironico. Lo stesso Calvino, infatti, ha dichiarato che il suo intento era «scrivere una storia divertente per divertire me stesso e possibilmente per divertire gli altri» (Intervista con gli studenti di Pesaro dell’11 maggio 1983, trascritta e pubblicata in Il gusto dei contemporanei, Quaderno n. 3, Italo Calvino, Pesaro 1987, p. 9). Nella stessa intervista l’autore ha dichiarato di essere convinto che «questo tema dell’uomo tagliato in due, dell’uomo dimezzato, fosse un tema significativo, avesse un significato contemporaneo: tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti, tutti realizziamo una parte di noi stessi e non l’altra». Questo è sicuramente un tema trasversale e sempre attuale che Calvino ha saputo rappresentare egregiamente nel doppio Medardo, ma anche l’immagine dei fuochi fatui presente nel testo è sicuramente una metafora arguta dell’uomo incompleto che non è riuscito a realizzarsi completamente.
Passiamo adesso a Il barone rampante. Chi, da ragazzino, non ha mai sognato di vivere sugli alberi? Chi non ha mai desiderato di potersi arrampicare e di non dover mai più scendere? Italo Calvino permette a un suo personaggio di realizzare questo sogno. La vicenda è ambientata a Ombrosa (ovviamente un paesino con molta ombra per via dei molti alberi, altrimenti come sarebbe stata possibile questa straordinaria vicenda?), luogo immaginario della Liguria, precisamente il 15 giugno del 1767 quando Cosimo Piovasco di Rondò di anni 12, rifiuta di mangiare le lumache e abbandonata la sala da pranzo, si arrampica su un albero. Non scenderà mai più, neanche quando morirà all’età di 65 anni. Si potrebbe pensare che la sua vita sia stata paragonabile a quella di un animale, selvatica e senza regole, ma non si potrebbe pensare niente di più sbagliato. Certo, Cosimo andava a caccia e lo si vedeva girare sugli alberi con in testa un cappello fatto con il pelo di un gatto selvatico, suo acerrimo nemico e sua prima preda, ma non prese mai abitudini di vita selvagge. Nel tempo trovò il modo di vivere una vita, se non agiata, almeno comoda e trovò anche il modo di essere utile alla comunità che inizialmente lo riteneva un pazzo ma finì poi per apprezzarlo. E così Cosimo visse tutta la sua vita senza mai toccare terra: studiò, succedette al padre come Barone di Rondò, sostenne l’esercito francese, conobbe Napoleone, divenne Maestro Massone, sventò un attacco dei pirati e, soprattutto, conobbe l’amore. Le vicende sono raccontate da Biagio, il fratello minore di Cosimo, fedele trascrittore delle sue avventure. Avventure vere, verosimili o inventate, ma molto piacevoli da leggere, che trasportano il lettore in un mondo realistico che partecipa degli avvenimenti del tempo (la Rivoluzione francese e la Restaurazione) ma lo fanno in un modo peculiare, in una sorta di atmosfera fiabesca, con soldati coperti di muschio che rischiano di mettere radici e nobili spagnoli in esilio costretti a vivere sugli alberi. Potrebbe leggersi come una metafora dell’uomo contemporaneo: Cosimo è un solitario che però non rifugge il contatto con le persone, al contrario si impegna a creare associazioni e confraternite, forse in un’idea di società universale, sull’onda dell’ideale di fratellanza sostenuto dalla Rivoluzione francese. Questo secondo capitolo della trilogia araldica “I nostri antenati” prosegue nella creazione di personaggi fortemente emblematici che rimangono impressi, come la scostante e superba Donna Viola che fece impazzire definitivamente Cosimo, e l’ambiguo Cavalier Avvocato Enea Silvio Carrega. Con la stessa vena ironica presente ne Il visconte dimezzato, Calvino ha raccontato un’altra fiaba, forse un po’ troppo lenta e descrittiva in alcuni punti, ma sicuramente divertente e capace di portare il lettore ad arrampicarsi tra il fitto fogliame degli alberi di Ombrosa.
Finiamo quindi con Il cavaliere inesistente, una sorta di poema cavalleresco in chiave moderna. Calvino narra le gesta dei cavalieri dell’esercito di Carlo Magno ma i suoi cavalieri non potevano che essere atipici. Il più anomalo è sicuramente Agilulfo che, come dice il titolo, non esiste. È una bianca armatura vuota che parla, cammina, cavalca e combatte ma non ha nessun bisogno umano: si siede a tavola e segue perfettamente l’etichetta ma non mangia, passa le ore notturne a sforzarsi di non dissolversi perché la notte per lui è il momento più rischioso, non ha necessità di dormire e non può trovare sollievo nell’allentamento della coscienza che gli sarebbe fatale. È un grumo di volontà, di ostinazione di esserci e di coscienza di sé che si è condensato e si è imbattuto in un nome e in casato vacanti. L’unica cosa che gli sta a cuore è l’adempimento delle regole della cavalleria ed è così pedante che nessuno lo sopporta e sono tutti ben felici di escluderlo e di revocargli il titolo appena se ne presenta l’occasione. È proprio questa occasione, che in realtà è un’accusa e un insulto, a dare il via al cuore della vicenda, che è una ricerca che coinvolge tutti i protagonisti, chi per riscattarsi, chi per raggiungere il proprio amore, chi per conoscere le proprie origini. Un altro cavaliere notevole è Bradamante, unica donna dell’armata. Lei ha già conquistato e poi rinnegato tutti i cavalieri e ora brama di possedere l’unico che non può avere, perché non esiste. Non suona questo desiderio come la ricerca di qualcosa che non si può raggiungere? E l’incapacità di essere felici di quello che si ha? Chiude la triade il giovane Rambaldo che è entrato nell’esercito per vendicare la morte del padre ma subito sente che inspiegabilmente il cavaliere dalla bianca armatura è l’unico che potrebbe comprenderlo e si innamora poi della bella Bradamante. Le vicende dei tre si intrecciano e portano ad un finale inaspettato. Ancora una volta Calvino crea un’ambientazione fiabesca e ironica, con gli interpreti che scorrazzano per il campo di battaglia per tradurre gli insulti che i cavalieri degli eserciti opposti si rivolgono e Gurdulù che si immedesima talmente tanto nella vita che passa dall’essere un’anatra all’essere un pesce, una farfalla, un pero, lo stesso re e chi più ne ha più ne metta. Non si può dare torto a Carlo Magno quando esclama: «Questo suddito qui che c’è ma non sa d’esserci e quel mio paladino là che sa d’esserci e invece non c’è. Fanno un bel paio, ve lo dico io!».
In copertina una fotografia che ritrae Italo Calvino