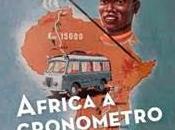Parlando de La vera vita di Sebastian Knight, apparso per la prima volta in inglese nel 1941, mi limiterò a dire che il libro, nella finzione narrativa, è la biografia (meglio: il tentativo di ricostruire una biografia), scritta dal fratellastro, di Sebastian Knight, scrittore di origini russe scomparso prematuramente. Tentativo non riuscito, si potrebbe aggiungere, ma si cadrebbe nell’errore di voler applicare a Nabokov le restrizioni tipiche di un linguaggio codificato; quelle imposte, cioè, da un discorso sulla vita di un artista che si vuole intriso di date, luoghi, riferimenti. Riportati — più che raccontati — con la maggior precisione possibile.
Parlando de La vera vita di Sebastian Knight, apparso per la prima volta in inglese nel 1941, mi limiterò a dire che il libro, nella finzione narrativa, è la biografia (meglio: il tentativo di ricostruire una biografia), scritta dal fratellastro, di Sebastian Knight, scrittore di origini russe scomparso prematuramente. Tentativo non riuscito, si potrebbe aggiungere, ma si cadrebbe nell’errore di voler applicare a Nabokov le restrizioni tipiche di un linguaggio codificato; quelle imposte, cioè, da un discorso sulla vita di un artista che si vuole intriso di date, luoghi, riferimenti. Riportati — più che raccontati — con la maggior precisione possibile.
Ciò che a Nabokov interessa, però, è piuttosto il resoconto (che il fratellastro narra in prima persona) di un tentativo letterario frustrato sul nascere da notizie mancanti o spurie, da persone e luoghi evanescenti, da circostanze che mettono quasi sempre fuori strada. Con la conseguenza non irrilevante che il libro, da presunta biografia di un parente conosciuto appena, finisce col diventare progressivamente, e inconsapevolmente, una sorta di autobiografia in fieri, somma di frammenti sedimentati nel corso di un continuo fluire interiore, dai luoghi della memoria al ricordo delle occasioni mancate.
Ecco, allora, che le vite distinte dei fratellastri russi sembrano spesso intersecarsi e sovrapporsi, in un continuo gioco di specchi, fino ad appaiarsi l’una di fianco all’altra quasi come vite parallele, “allitterative” perché percorse da una reciproca ammirazione, da una familiare assonanza, da una latente volontà di contatto e dialogo. Si legge in un passo di Oggetti smarriti, romanzo di Knight: «La vita con te è stata incantevole — e quando dico “incantevole” intendo canti e voli e viole, e quella morbida, rosea “v” nel mezzo, e quelle sillabe sulle quali si curvava indugiando la tua lingua. La nostra vita insieme è stata allitterativa, e quando penso a tutte le piccole cose destinate a morire, ora che non le possiamo più condividere, sento come se fossimo morti anche noi. E forse lo siamo.» Si sta parlando del testo di una lettera d’amore, in queste righe, ma il concetto contenuto nella seconda frase funziona benissimo anche nel caso dei due fratellastri: l’uno defunto, l’altro all’inseguimento di un’esistenza — quella di Sebastian, ma in fondo anche la propria — quasi perduta.
Ma torniamo allo stile. Giorgio Manganelli, nel saggio Mistificazione e incantesimo — apparso nel 1980 sul Corriere della Sera e posto successivamente in calce all’edizione Adelphi —, definisce così La vera vita di Sebastian Knight: «Questo libro breve e “leggero” — pare avere la consistenza del sughero — è, in realtà, un libro astutamente ambizioso; il suo obiettivo a me sembra quello di costruire un tessuto di parole — mi ripugna chiamarlo “romanzo” — attorno a un punto vuoto, un’assenza, un luogo mentale, indefinibile». Ed è sufficiente fermarsi per un attimo sulla prima parte della citazione da Oggetti smarriti — basata su un gioco di parole, assonanze e allusioni linguistiche del tutto sterile e autoreferenziale (come non ricordare l’attacco di Lolita?) — per rendersi conto che una simile interpretazione risulta davvero illuminante. Soprattutto, Manganelli coglie nel segno quando parla di un discorso intorno al “vuoto”. È proprio il vuoto, infatti, a configurarsi come materia di narrazione primaria del «tessuto di parole» nabokoviano, quell’assenza incolmabile che trasuda da ogni singola pagina del racconto, e intorno alla quale s’imperniano tutti gli episodi fondamentali.
Così “funziona”, ad esempio, per la scena finale del libro, con la veglia notturna del fratello ad una persona sbagliata. E lo stesso vale per la visita di Sebastian a Roquebrune, la cittadina dov’è morta, anni prima, la madre. Dopo un’immersione quasi mistica nel luogo dove crede che lei abbia trascorso gli ultimi istanti, e un colloquio silenzioso con i fiori i profumi e i colori che l’avrebbero accolta a sé, la verità si scopre nello spazio di un “a capo”: «Alcuni mesi dopo, a Londra, mi capitò di incontrare un cugino di mia madre. La piega della conversazione mi portò a parlare della mia visita al luogo in cui lei era morta. “Oh”, disse “ma era l’altra Roquebrune, quella nel Var”». È una verità gelida, spietata, che mette in risalto il contrasto tra una dimensione interiore intima e immaginativa e un mondo, per così dire, “di soli pieni”, inesorabile e cinico nella sua compiutezza.
Media: Scegli un punteggio12345 Nessun voto finora