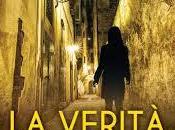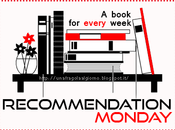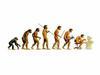[Una seconda recensione a questo nuovo libro di Gamberale, con un punto di vista diverso. Se volete, leggete la prima]
[Una seconda recensione a questo nuovo libro di Gamberale, con un punto di vista diverso. Se volete, leggete la prima]
Qual è la vera famiglia di Biancaneve?
Le luci nelle case degli altri si intravedono da un treno in corsa. Sono quelle finestre accese nei palazzi. Lampi che sfumano dal bianco all’arancione. A ogni luce corrisponde un gruppo di esistenze, ciascuno visibile dalla tonalità che riassume il suo calore. Nel condominio della Gamberale, in via Grotta Perfetta, a prima vista quelle luci possono sembrare cinque (con le loro rispettive ombre), come il numero di famiglie che lo abitano ma, nelle quattrocento pagine del romanzo, diventano un unico lume.
É il bagliore della famiglia allargata che sceglierà di “adottare”, a turno, la piccola Mandorla, rimasta orfana a sei anni. Mandorla è il dono d’addio della giovane amministratrice di condomino, Maria, la cui solare schiettezza aveva reso complice e confidente di quegli inquilini certamente cliché nei profili ma non privi di spessore.
C’è Tina, la maestra zitella in pensione che di giorno ragiona per binomi mentre la notte si veste elegante per ricevere amici immaginari. Sopra di lei, la coppia gay alla moda con due opposti modi di amare: Michelangelo si addormenta sereno nell’amore che Paolo veglia senza sosta. Al terzo piano non mancano i coniugi alla deriva chiusi nelle proprie insicurezze. Idem al piano di sopra, dove Lidia sente di dover assolutamente riempire di parole quegli spazi vuoti che per il suo Lorenzo, scrittore cinico e seguace di Bukowski, sono funzionali alla sopravvivenza. Fino ad arrivare al quinto piano dove i Barilla forniscono l’immagine vincente della famiglia bella e benestante uscita da una pubblicità all’italiana.
Dovendo mappare il romanzo, però, è al sesto piano che si tirano le somme, all’interno di un locale mansardato detto “ex lavatoio”. É lì che l’effervescente Maria conduceva le terapie di gruppo mascherate da riunioni condominiali. É in quel luogo, scrive Maria in una lettera alla figlia appena nata, che sei anni prima ha fatto l’amore con un imprecisato inquilino del palazzo, il padre della piccola Mandorla. Non può che essere nell’“ex lavatoio” che i condomini – in seguito alla prematura morte di Maria in un incidente e dopo aver letto la lettera destinata a Mandorla – metteranno ai voti il futuro della piccola decidendo di bypassare l’esame del DNA e allargando la paternità a tutto il palazzo.
Così Mandorla, ufficialmente adottata da Tina, ogni due anni passerà di piano in piano, risalendo lo stabile fino a raggiungere simbolicamente, alla soglia dei diciassette anni, il luogo dove fu concepita. E nell’entrare e uscire da un nucleo all’altro Mandorla, che nel frattempo scoprirà di non essere figlia di un astronauta come le aveva fatto credere sua madre, diventerà un adolescente in cerca di un’identità da condividere, faticosamente, con gli “altri della ‘sua’ età” (ADME, nel suo acronimo preferito). Pur di scappare dalle aspettative del mondo fantastica di essere taxi, documentario o libro di algebra. Evasioni e ansie di primi amori che l’efficace scelta lessicale dell’autrice trasmette senza intermediari, lungo un filo di coerenza che trasforma anche il lettore in un “ADME di marca”.
Gamberale sceglie il collaudato microcosmo del condominio per raccontare quell’intimità che va oltre al sangue, quel tipo di complicità che si guadagna solo con la convivenza. Se è vero che una famiglia non si sceglie, va da sé che anche i propri vicini di casa vengono assegnati in modo fittizio. É questo, forse, lo spunto più incisivo di Le luci nelle case degli altri: una famiglia non è per forza lì dove uno si aspetta di trovarla. Non è necessariamente un filamento di DNA, una firma su un atto di nascita o un cognome sull’ottone di un campanello.
Le famiglie sono gruppi intimi e peculiari che non sempre obbediscono alle leggi del sangue pur essendo soggetti al bene e al male, alle luci e alle ombre. In un certo senso, Gamberale “benedice” questa famiglia improbabile facendola risiedere in via Grotta Perfetta che, abbinata al nome ‘Maria’ e a una trama di paternità putativa, fa molto Betlemme anno zero. É una dignità di nucleo che va oltre i valori prestabiliti.
Con gli occhi appesantiti dai troppi corsivi, sulla scia delle parole di Lorenzo, ci si dimentica di inseguire la misteriosa identità del padre, rivelata con il classico colpo di scena dell’ultima pagina. Si finisce a fare il tifo per i sette nani, vittime di quell’imposizione di ideali canonici che ignorano quanto il “meglio” sia, da sempre, acerrimo nemico del “bene”. É stato davvero meglio per Biancaneve essere svegliata dal principe azzurro (secondo la Disney) invece che continuare a dormire nei boschi vegliata dall’affetto di quei sette amici che oggi avrà, sicuramente, perso di vista?