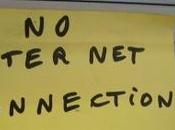Patrizia Dughero, Le Stanze del sale, Le voci della Luna, 2010 – Premio Giorgi 2010
Prefazione di Gregorio Scalise
Il percorso del sangue
“Compito”, il primo testo de Le stanze del sale, dell’autrice Patrizia Dughero, si apre con una precisa dichiarazione: “A volte li frantumo i sassi/per vedere se trovo qualche pezzo// buono da salvare.//” E’ una dichiarazione che fa intendere una attenta perseveranza, e, come dicono i versi successivi, “…scavo dei buchi” e poi “intesso con mattoni nuovi”. Oppure con improvvise virate dopo aver descritto la fine di un coniglio, la Dughero dichiara di essere sicura di volere una sorellina. Dichiarazione appunto inattesa che rivela dei pensieri che sino a quel momento erano stati riposti o rimossi. In una recente dichiarazione dell’autrice si legge che se “ad un membro organo della famiglia sistema corpo è stato fatto un torto (..) è possibile che nella famiglia stessa esista una esigenza di compensazione”. Vivrebbe una coscienza della stirpe e la dialettica di questa coscienza guarda ai predecessori più che ai discendenti. Tali riferimenti antroposofici sorreggonoin certa misura le nervature ideocratiche dei testi. Molti di essi d’altronde rivelano un finale a sorpresa, come se il testo dovesse compiere un lungo percorso (quello del sangue, della vita corporea) per giungere ad una specie di rivelazione.
C’è anche un inserimento dialettale in friulano, la lingua della poesia di Pasolini. Il friulano della Dughero è costruito, più che vissuto nei luoghi, ma si deve prendere atto che Koinè ha accettato assieme a degli errori di
grammatica la plausibilità verosimile di questa lingua. In “Nel Carso, ancora” questo dialetto-lingua sa offrire affascinanti suoni -significanti persino nel titolo “Tal Cjars” (ciars, come suono, Carso) e “ancjemò”, dove ancje è
ancora, e mò, adesso, e quindi “di più adesso”, cioè “ancora”. E subito dopo: “ma cuant la tiere varà glotit il cuarp” (notare il suono “cuarp”, indica il corpo).. “quando la terra avrà inghiottito il corpo”, dove però “tiere” e
“glotit” si presentano con ben altro fascino e si potrebbe persino dire, nei riguardi dell’italiano, persino con una storia più densa. Inoltre, ampliando questa nota, se “encore” è il termine francese di un indistinto termine ricco
di desiderio, ecco che quel “ancjemò”, sa comunicare quel ritmo timido e fondo del desiderio che chiude questa versificazione con un richiamo proprio di quelle terre. Infine curiosi e divertenti (si fa per dire) sono certi
soliloqui della Dughero, come il testo “Parlando con Raymond Carver”. Difatti l’immagine dello scrittore chiuso nel cofanetto dei Meridiani, non solo non sembra quella di un alcolista ma lo rende anche simpatico. Da
notare il contesto familiare e accattivante: “Quando faccio pulizie// mi capita di colloquiare con qualcuno”. Altri testi sarebbero da richiamare e citare, ma si potrebbe aggiungere a questa riflessione sulla raccolta Le stanze del
sale, ancora versi friulani, che parlano di vino “in tal sac” con le occhiaie di passione “in ta la muse” (muso, cioè viso). Per quanto riguarda le finalità stilistiche messe in atto dalla Dughero, più che di poemetti in prosa, si potrebbe parlare di una sorta di poesia e atteggiamentopoetico in cui il testo si esprime con una sorveglianza accesa che riguarda appunto una spiccata funzione prosastica, narrativa. “Era quasi buio quandoarrivaste//dalla strada principale che seguiva il fiume//,C’erano truppe e camion sulla strada e muli con artiglieria//da montagna.//”. Si tratta dell’inizio di “Distanze” in cui viene descritta non senza fredda angoscia
una via percorsa assieme e poi sigillata da una separazione.
In “Sale”, ancora: “Sul pavimento ogni notte, chiusi gli occhi vicino//al fogolar spento, al centro di ogni senso, contorno//di carta accartocciata che vola con getti di paure//senza piogge a inondare il mondo//e quei massi dal
declivio giù nel profondo,//la lingua spessa e dura//il fegato racchiuso in un cassetto//”, è una descrizione, forse dell’infanzia, certamente da un passato remoto, attraverso il paesaggio aspro e naturale che accompagna spesso
questi testi e questi ricordi. Potrebbe interrogarsi chi legge questi versi sul fatto che a volte guerra, spessopericolo, non di rado rudezza siano presenti in questa autrice. Ma chi conosce le regioni del trentino, i luoghi attorno a Trento, sa che non solo la vita da quelle parti incontra la difficoltà, ma che anche – stranamente,
eppure è così – i ricordi della guerra, sia della seconda ma addirittura della prima, sono conservati in quelle valli e in quei luoghi: è una specie di clima che si respira con l’aria, una specie di ricordo lungo e semovente, che
molto acutamente la Dughero ha ripreso e fatto rivivere nei suoi testi.
*
Compito
A volte li frantumo i sassi
per vedere se trovo qualche pezzo
buono da salvare.
Difficile risalire le parole, appellativi,
come fatua, ad esempio, che impedisce il peso
di ogni mia lettura.
Difficile tessere fili che vedi sparpagliati
se non sei abituata a ore di telaio.
Un giorno una veggente che mi piaceva
consultare – era molto brava
disse che il mio compito è tutto ciò che è materiale.
Basta con la meditazione e la contemplazione
e tutto ciò che è trascendente.
Occorreva appoggiare i piedi a terra.
Non l’ho ascoltata e ho continuato.
Ma quando il dono è arrivato, io l’ho accolto.
Ho iniziato a trasportare ciò che ricevevo, onorando,
a tramandarlo, lasciando che trabocchi su altri.
Ho iniziato a trasportare mattone su mattone
asciugando il sudore con la pietra bianca.
Mi hanno insegnato che esiste il taglia e cuci
anche per i vecchi muri: tecnica raffinata.
Io l’ho osservata e ora è quel che faccio,
che tento, coi gesti e le parole, se posso.
Scavo dei buchi ai vecchi muri e poi li copro
li intesso con mattoni nuovi e poi li mostro.
Vinco la vergogna, a volte, sperando
che sia utile e che serva.
Un compito pesante.
*
Muti come conigli
Sono nell’aia della macelleria di nonna.
E’ settembre, mamma ha il pancione,
deve partorire prima di Natale.
Non so se farà un fratellino
o una sorellina e non so cosa preferire.
Sicuramente andrebbe bene una come la sorella
della Silvana. Ha quasi tre anni,
ed è anche meglio della Silvana
per giocarci.
Arriva Guido, un omone che aiuta nonna. E’ burbero
ma non mi ha mai fatto paura.
Si avvicina alla gabbia dei conigli.
Loro stanno lì silenziosi,
muovendo continuamente la bocca.
Anch’io inizio a muovere la bocca
come loro e annuso l’aria.
Sembra che Guido non mi veda
mentre me ne sto lì a muovere la bocca
e annusare l’aria come un coniglio.
Ne prende uno dalla gabbia e si avvicina
lo tiene per le orecchie e allora
sembra mi guardi. Che tutti e due mi guardino.
Non faccio in tempo a salutarlo
lui prende un coltellaccio dal bancone
sotto il portico.
Smetto di muovere la bocca e annusare l’aria.
Anche il coniglio ha smesso di muovere la bocca
crede che stando così fermo, come se fosse già morto,
non può succedergli niente.
Imparo da lui.
L’omone gli passa il coltello attraverso tutta la gola.
Spruzzi di sangue. Fa in tempo a raccoglierlo
nella bacinella che è sul tavolaccio.
Ora ho capito a che serve. Un lampo sul corpo morbido
ancora peloso.
Lacrime dolci come il sangue.
Lo sento ancora squittire. Lo sentirò per molto.
Guido mi chiede se ho avuto paura.
Rispondo in silenzio scotendo la testa.
Il sangue ha sapore dolce disgustoso e un odore che punge.
Ora sono sicura, vorrei una sorellina.
*
Medesimo intento
Tanto per cominciare allora vivevamo all’isola
e non avevamo animus possidendi.
Così raccontano i presenti, un manipolo
di persone che se ne sta, il mare davanti,
al di là di una rete, a tratti il filo spinato
su sassi polverosi e bianchi che hanno
impresse lacrime nere, per tutti.
Dicono che per prima cosa lei fa scivolare
la corda intrisa di mare per avvicinare a sé
la barca di salvataggio. Tacitamente accordati
un mese pieno senza certezza del medesimo intento.
A mezzogiorno la ragazza entra in acqua a bagnarsi.
Il vento può cambiare verso quest’ora
e il mare incresparsi perdendo trasparenza.
Occorre partire. Due miglia allo Scoglietto.
Lei indossa pinne robuste, speciali, lui scioglie
il nodo all’ormeggio. Due miglia allo Scoglietto.
Il mare a metà diventa blu
poi grigio, un mare d’inverno per ogni stagione.
Un mare infinito. Fa paura.
Il ritmo è lo stesso, lui rema lei nuota
le braccia le gambe, i remi sull’acqua.
Lui espira lei inspira e vanno veloci.
Lo scoglio è più grande di quello
che sembra, di guano rappreso
attaccato alla roccia. A faro spento.
Occorre aggirarlo, piazzarsi sul retro
respiro ansimante.
Dicono che dal lido, a due miglia,
i presenti col binocolo non vedono bene
il retro di scoglio nascosto dal faro
spento. Il ritorno è più lento.
Un applauso all’arrivo.
Stupita la gente ora guarda ascoltando il loro respiro
che è calmo.
Qualcuno dal lido, si narra, ha visto una strana figura
con gli occhi socchiusi
a spiare.
Qualcuno, si dice, ha notato che in seguito
lui indossava una medaglia sul petto glabro
una medaglia piccola e d’oro,
incisa una data davanti e sul retro due parole soltanto:
nodo infinito.
*
Emotìsi
Quando s’è rotta la mia sottile parete capillare
-un millesimo di millimetro
tessuto intrecciato finemente per dividere
il mare interno che circonda il respiro
non ero ancora giunto all’alte vette.
Come ragazzo del novantanove m’inerpicavo ardito
a unire i confini. Mostrine luccicanti
al pari di quel fiume, che, pensavo, divideva genti.
-ma a volte il fiume non separa, scorre soltanto.
Ancora non mi chiamavano Mimì quando portavo fiero
gli emblemi di coraggio tra colline bianche,
le ciliegie ancora da venire,
prima di Kobarid, prima della Terra di nessuno.
Nel pallore opaco di quei fiori fini
mentre il fumo avvolgeva una strage, a protezione,
fu uno sbocco, un piccolo frutto di colpi e artiglierie
che attirò su di me un’attenzione audace.
Diverso l’esercito, diversa la sponda.
Al ginocchio un calcio secco e un ordine al sottoposto
-Questo è vivo.
A nord fu la prigionia, ma il freddo
guarì il barbaglio rosso come una ciliegia
e separò il mio respiro e la sua aria.
-il fiume a volte non separa e lascia vivi mentre scorre.
Il mio passo poi, e lo sai bene per quanto con te
ho camminato,
ha ripreso veloce un’andatura fiera.
Ardito nell’asimmetria non
ho mai smesso di cercare
e ti ho insegnato, come ho potuto, a unire
a unire sempre.
*
Ai miei
Vorrei levarvi a queste tristi mura,
vi si stringono addosso giorno dopo giorno,
avete bisogno anche di uno spazio aperto
spazio per tornare alle pareti oscure e scalcinate
Le vedete toccarsi l’una con l’altra
congiungersi
in un tempo che non è più vostro
scrostarsi senza più garruli suoni
controllando ogni vano intorno.
Ora tocca a me condurvi a luoghi nuovi dove
non c’è confine.
*
Tal Cjars, ancjemò
Mi lavris jerin mutis
sicu il bosc clâr di cestis pieris
nessun savêve il passaç
che o fasevino pa restâ unîts.
E tu pur mi voleves ben
nome il sen
di cûr je vite vêre.
Il plasê se disfe tant che lis gotis di rosade
treme ta la piel: supala, ancjemò
tant che la gote e je supada e sparîs tal flôr.
Gnis bregons, gnis giambis
la bocje, lis volis fontis
gno cûr, il petdut sarà roseât
ma cuant la tiere varà glotît il cuarp
gotis infinîtis se poiaran intor.
Nel Carso, ancora
Le mie labbra erano mute/ come la bianca selva di queste pietre/ nessuno si era accorto del passaggio/ che esisteva per unirci./ Eppure ti sono stato caro/ soltanto il desiderio/ del cuore è vera vita./ Il piacere di disfa come goccia/ di rugiada/ trema sulla tua pelle: risucchiala/ così come la goccia svanisce nel fiore./ Le mie braghe, le mie gambe/ la bocca, gli occhi profondi/ il cuore mio, il petto/ tutto sarà roso/ ma quando la terra avrà assorbito il corpo/ gocce infinite vi si poseranno intorno.
*
Parlando con Raymond Carver
Quando faccio pulizie
mi capita di colloquiare con qualcuno.
Oggi tocca a te Ray e non è la prima volta.
Vorrei seguirti anche in questo
tu che parli con Joyce
tu che parli con Baudelaire
tu che parli di Shelleysulle loro
tombe, sempre.
Io sto solo aspettando che si asciughi il pavimento.
So che sembrerà retorico
assolutamente banale
dire che tra noi c’è un oceano
e io vorrei attraversarlo.
La tua immagine sul cofanetto dei Meridiani
mi fissa, ha un’aria simpatica, non sembra
di un ex alcolista. Comprendo il problema.
Vorrei parlarti di spazio
oltre quello oceanico che ci divide
oltre quello che c’è tra whisky e vino
oltre quello che c’è tra le mani che aggiungono all’argilla
e il marmo da scalpello
oltre quello che c’è tra chi ci lascia parole e chi no
ovviamente, spazio.
Un mio amico che si dice piccolo poeta mi ha insegnato:
lo spazio non è sempre uguale a se stesso
dieci centimetri fra due macchine
non sono dieci centimetri in un letto coniugale.
Penso abbia ragione. La coscienza cade sulle cose
che guardiamo diventare assenti
le scalpelliamo per porgerle, che qualcuno legga.
Ciò che non ha significato profondo
l’esistenza non ha alternative, in fondo non è necessaria
non trova radici se non nella combinatoria interna
divisa.
*
Animus possidendi
La mamma di Giacomo ha organizzato
un ricevimento. L’ora del tè.
Le mie mani attaccate ai tondini
attraverso il portone guardo il suo soggiorno buono.
Le signore sedute sul divano – dai pizzi primi novecento -
si sono vestite bene e truccate molto,
hanno capelli cotonati a dovere. Mia madre bellissima,
i grandi occhi disegnati penetrano da lontano,
poi tornano a perdersi nel pensiero di apparire.
La mamma di Giacomo cammina su e giù
dalla cucina porta, ogni volta,
un incantevole piatto di pasticcini nuovi.
“La torta con la panna non c’è!
Aspettami qui!” Mi ordina l’amico
urlando. Scomparso in un lampo
riappare con il solito gioco di costruzioni.
Lui maschio più grande, cinque anni compiuti,
possiede già i Lego, io ancora piccola.
Gli occhi azzurri e piatti di sua madre
mi s’avvicinano, il suo volto sempre più tondo:
“Prendo qualcosa che ti piacerà.”
Riappare con la scatola di biscotti, i miei preferiti.
La forma quella del sole, un sole di cotta terra.
Lui arriva all’improvviso, si fionda ringhiando
come un cane da guardia, enorme e più scuro.
I suoi occhi lucenti sono dilatati,
le labbra non sono contratte, ma gonfie più del solito
si sporgono in fuori. Pronuncia parole sconnesse
si prepara a un verdetto e alza la voce.
Di colpo non è più un bambino.
“Dammeli. Sono miei.”
“Me li ha regalati tua madre.” Non ho paura.
“Te li ha dati mia madre, in casa mia, sono miei.”
Strappa dalle mani il pacchetto fragile,
io immobile e i biscotti a terra.
Ne sto masticando senza gustare. Senza dolore
assaporo lo spietato contrasto
tra i suoi denti aguzzi e il mio labbro morbido.
Qualcosa di denso inizia a sgorgare, uno spruzzo
sul mento. Gocciole rosse sui biscotti frantumati.
Il muro imbrattato del mio liquido, rosso.
Un bellissimo rosso.
Le donne sono accorse. Senza dimenticare di aggiustare
le gonne strette sui fianchi,
non pronunciano l’atteso verdetto.
Resto impietrita, qualcuna si affretta a pulire
qualcun’altra mi preme il cotone sul labbro.
Che io ricordi, da allora ho una specie di tic
ogni mattina al risveglio mi inumidisco le labbra
cerco l’indurimento, impercettibile cicatrice.
Poi mi avvio al combattimento.
*
Distanze
Era quasi buio quando arrivaste
dalla strada principale che seguiva il fiume.
C’erano truppe e camion sulla strada e muli con artiglierie
da montagna.
Laggiù lontano il fiume che vedevate insieme
a file di rotaie e traversine.
Gli correvate accanto, un rigagnolo che brilla tra sassi
che brilla al sole, se c’è, come può brillare
un verde cupo tra i boschi.
V’inerpicaste su per colline
e sempre una linea che separava eserciti.
Al bivio già assieme
la strada che saliva
spuntavano a nord montagne alte ancora con la neve sulle cime.
Attraversavate gli stessi ponti in pietra bianca
dopo il bivio del paese.
Un unico treno
ammorbato dalle stesse cose
congelamenti e geloni itterizia gonorrea
autolesioni ulcere molli e dure polmoniti.
- passato infetto che non sfugge alla mente -
Un vagone forse a dividervi.
Da qualche cima lei prese un’altra
direzione
nel rimorchio, mucchio di gente serrata come bestie.
Lo capivano o no?
Stretti nel passaggio austeri nella vostra malattia
sostenevate un peso della storia, la nostra, la mia.
Lo capivate?
Pochi metri a dividervi.
Di lei ci resta questo telo che odora ancora
di ferro da stiro coi carboni. Profuma, damascato di Boemia,
avvolge e cancella ogni vergogna
d’intangibili colpe – Ci restò avvinghiata
con ali aperte di piccola civetta.