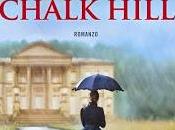Lessico dei tempi feroci

I politici della Prima Repubblica. Erano incomprensibili. Il linguaggio era fatto apposta per non essere compreso. Se non da loro. Al loro interno. Messaggi cifrati. Obliqui. Paralleli. I cittadini, d’altronde, non se ne occupavano troppo. I discorsi politici e dei politici: non li interessavano. Tuttavia, la società non era estranea al contesto politico. “Con-testo”, appunto. Un “testo” condiviso. Perché la politica è rappresentanza e rappresentazione. I “rappresentanti” riflettono la società e la società vi si riflette. Almeno in parte. E il linguaggio ne era lo specchio. Così, le persone parlavano in modo “educato”. In pubblico. Le parolacce non erano ammesse. Quando scappavano, il responsabile veniva guardato con un sorriso tirato, di riprovazione. Sui giornali e sui media, poi, guai. Quel “Cazzo!”, pronunciato sapientemente da Zavattini, nel 1976, fece rumore. Anzi, fragore. Mentre quando Benigni in tv, ospite della Carrà, recitò tutti i sinonimi della “passerottina” (dalla chitarrina alla vulva…), sollevò grandi risate, ma molto meno clamore. Era il 1991. Il muro di
Berlino era caduto. E stava travolgendo anche il sistema politico italiano. Seppellendo, insieme alla Prima Repubblica, una civiltà formalista e un po’ ipocrita. Dove il distacco tra società e politica era riprodotto dall’impossibilità di comprendere quel che avveniva “in alto”. I politici non erano apprezzati né, tanto meno, stimati. Anche prima di Tangentopoli. Venivano considerati disonesti. Inattendibili. Disinteressati ai problemi della “gente comune”. Eppure non ci si faceva troppo caso. Tutti votavano sempre. Allo stesso modo.
Certo, negli anni Settanta i movimenti sociali portarono in piazza slogan violenti. Ma si trattava di metodi di lotta. Il linguaggio era usato come strumento “politico”. Non “antipolitico”. Perché, comunque, la “politica” e la “classe politica” contavano. Il loro “potere” era riconosciuto.

Oggi, anzi, da almeno vent’anni: la scena è cambiata. I politici sono impopolari come prima, più di prima. Ma nessuno si fa scrupolo a dirlo. Neppure i politici. I quali si fanno schifo e se lo dichiarano reciprocamente. Non c’è nessuno, d’altronde, che sia disposto ad ammetterlo. Di essere un politico. Neppure i dirigenti di partito, i parlamentari, i senatori. Tutti im-politici. Il vetro che separava i politici dalla società e la società dai politici: si è rotto. Certamente, almeno, dal punto di vista della comunicazione e del linguaggio. L’alto e il basso. Chi sta in alto, i rappresentanti, insegue chi sta in basso, i rappresentati. E scende più in basso possibile. Tutti leader e tutti follower. Gli “eletti” fingono di essere come il “popolo”. Per imitare il “volgo” cercano di essere “volgari”. E ci riescono perfettamente. Senza fatica. Perché spesso sono peggio di loro. Nei comportamenti e nelle parole. Hanno trasformato il Parlamento e la scena politica in un luogo dove non esistono limiti né regole. Ai discorsi, al linguaggio.

Fra i rappresentanti e i rappresentati, è un gioco di specchi infinito. Così l’esibizione di chi “ce l’ha duro” si alterna al grido di “Forza gnocca”. Mentre si sviluppano relazioni internazionali tra “Cavalieri arrapati” e “Culone inchiavabili”. Di recente, infine, nelle piazze, nei palazzi e sui media echeggiano i “vaffanculo”, ripetuti all’infinito. Da chi rifiuta di dialogare con i “morti-che-parlano-e-camminano”. Con i “padri puttanieri della Patria”. Che sono già morti. E, comunque, “devono morire”. Il più presto possibile. Per cambiare davvero il Paese. È il clima del tempo. Il linguaggio del tempo. (Ben riassunto nel Dizionario della Seconda Repubblica, scritto da Lorenzo Pregliasco e di prossima pubblicazione per gli Editori Riuniti). Contamina tutto e tutti. Anche gli artisti più gentili. Perfino lui, l’Artista a cui mi rivolgevo nei momenti più concitati. Quando vivevo “strani giorni”. Mi rassicurava, sussurrando: “avrò cura di te”. Anche lui, divenuto “politico”, descrive il Parlamento come un luogo affollato di “troie disposte a tutto”.
E, allora, perché resistere? Perché rivolgersi, ancora, agli altri in modo educato? Perché chiedere rispetto: tra genitori e figli, professori e studenti, autorità e cittadini, immigrati e residenti, vicini e lontani, amici, conoscenti e sconosciuti. Perché? E perché limitarsi alle parole e non passare alle vie di fatto? D’altra parte, la distanza è breve. Le parole sono fatti. Perché mai, allora, io – proprio io – dovrei essere l’ultimo “coglione” rimasto in circolazione? L’unico a trattare tutti, ma proprio tutti, con rispetto? Anche coloro che non rispetto?
Così mi arrendo. Al clima e al linguaggio del tempo. E, per chiudere, rilancio un elegante adagio raccolto al Bar da Braun: “Andate tutti a-fare-inculo. Voi e la vostra politica del cazzo”.
Appunto a margine.
Ho svolto il filo del discorso sul rapporto – degenerato – fra linguaggio, politica e società cercando di essere coerente. Fino in fondo. Eppure, questo linguaggio mi dà fastidio. Scrivere così, a maggior ragione, mi dà (e io mi do) fastidio. Non lo farò mai più. E se le parole servono a “rappresentare” la realtà, se il linguaggio è rappresentanza, io, oggi, non mi sento rappresentato. In questa “Repubblica a parole” (o meglio: “a parolacce”), mi dichiaro prigioniero politico. In questi tempi cattivi, sempre più feroci, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Segnalazione di Gianluca Brembilla